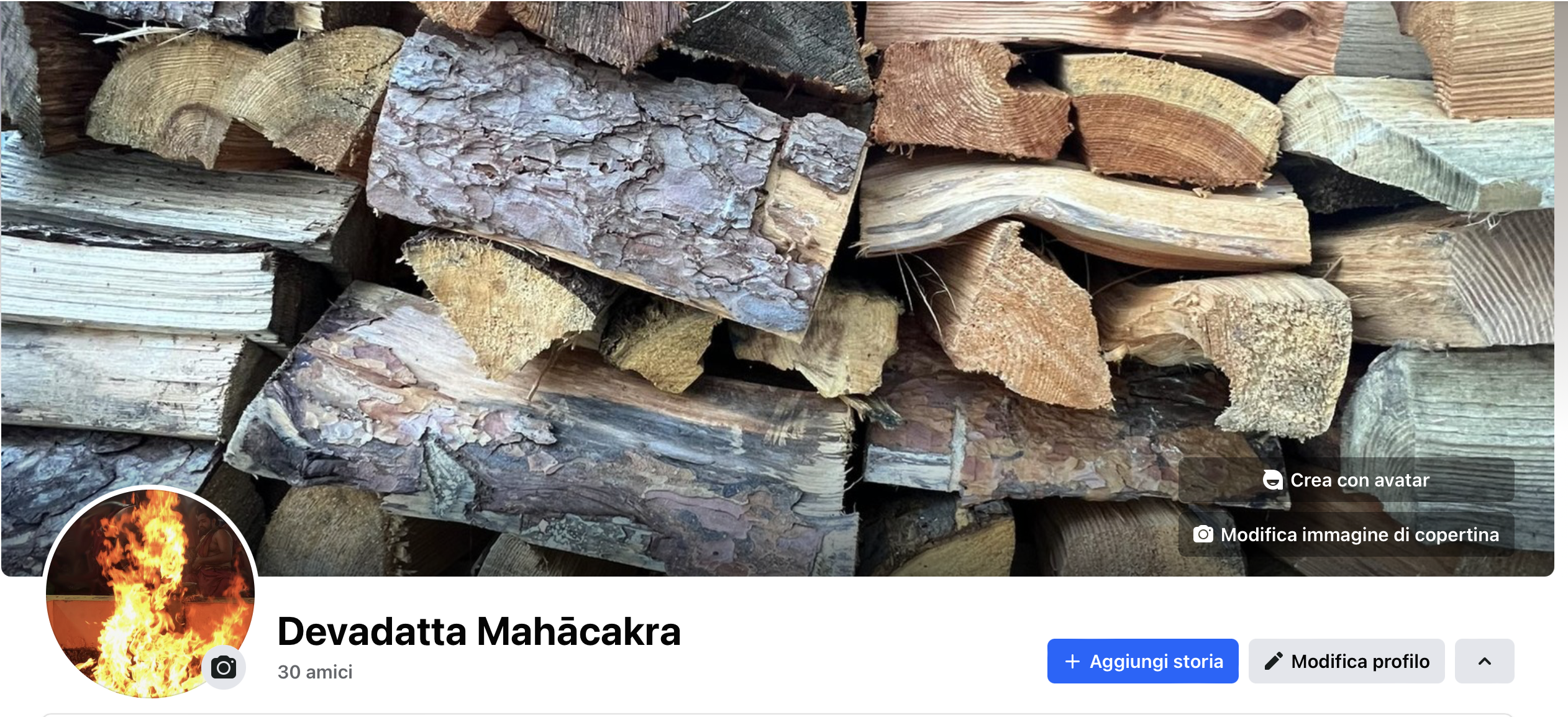Published: Sep 12, 2021 by devadatta
Tratto da “Hindūismo” di Antonio Rigopoulos, Editrice Queridiana, 2005, pp. 223-228.
Antonio Rigopoulos, professore di indologia e sanscrito presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha lungamente studiato la figura di Śirḍī Sāī Bābā. Nel capitolo dedicato alla figura del “guru”, ne riassume i tratti principali:
“Per scendere più nel concreto vengo all’illustrazione di un caso emblematico, quello del Sāī Bābā, che per certi aspetti può richiamare la figura di un carismatico quale Padre Pio. Se il centro tradizionale della spiritualità del Mahārāṣṭra è il santuario di Viṭṭhala/Viṭhobā in Paṇḍharpur, il suo centro moderno è senz’altro il piccolo villaggio di Śirḍī lungo la Godāvarī - distretto di Ahmednāgar, non molto distante dalla città di Nāsik - ove dagli anni sessanta/settanta del XIX secolo visse il santo noto con l’appellativo di Sāī Bābā. Qui è meta d’incessanti pellegrinaggi la tomba del guru, che in Śirḍī morì il 15 ottobre 1918. Egli è adorato da decine di milioni di persone, sia hindū che musulmane, e non soltanto in Mahārāṣṭra dal momento che il suo culto non ha mai smesso d’espandersi. I templi a lui dedicati sono varie centinaia per non dire migliaia, dalle regioni himālayane giù giù fino a Kanyākumārī sull’estrema punta meridionale del subcontinente. Il suo culto si è diffuso persino fuori dei confini dell’Unione Indiana. Gli sono stati consacrati templi in Nepāl e in Śrī Laṅkā come anche in Inghilterra, in Canada e negli Stati Uniti. Nell’India contemporanea il Sāī Bābā è certamente il santo più popolare e amato.
Di lui, dal punto di vista biografico, sappiamo pochissimo. Sāī è un termine che deriva dall’arabo e viene a significare “Dio’’, “Signore” o anche “maestro”, “santo”, mentre bābā è un termine hindi che significa “padre” ed è spesso usato a denotare il rinunciante. Sāī Bābā non è dunque un nome bensì l’appellativo col quale divenne noto un asceta identificato fin dall’inizio come un faqīr (lett. “povero”) ossia come un musulmano (forse l’adepto di una confraternita ṣūfica o un “freelance” sulla scorta dei majzūb, i pazzi/intossicati di Dio) a motivo della foggia del suo abito e delle sue abitudini. Egli elesse a propria ‘residenza’ una diroccata moschea (masjid) e praticò sempre la rammemorazione - dhikr - della formula Allāh Mālik, «Iddio è il Sovrano» (al-Malik, quarto dei novantanove bei nomi) ovvero il “Detentore del Regno” (Mālik al-Mulk, ottantaquattresimo dei novantanove bei nomi) implicante la regale trascendenza di Dio. Specie in età giovanile, era uso abbandonarsi a danze estatiche alla maniera dei dervisci. Pare che per decenni egli venisse chiamato semplicemente ‘Sāī’, come s’usa per i faqīr, e che ‘Bābā’ sia stato aggiunto quand’egli divenne più vecchio, in segno di rispetto. Fin dalla sua prima apparizione nel minuscolo villaggio di Śirḍī, questo giovane asceta sviluppò un approccio religioso di sintesi, alla costante ricerca d’integrazione e fraternità tra le comunità hindū e musulmana. Infatti, il Sāī Bābā adottò volentieri molti elementi hindū. Per esempio, ribattezzò la moschea col nome di Dvārakāmāī,“madre Dvārakā”, e non perse occasione di sottolineare la propria identità con svariate divinità del pantheon hindū, tra cui Dattātreya. Ebbe anche a di- mostrare di conoscere il sanscrito, diffondendosi in una puntuale esegesi di passi della Bhagavad-gītā. Al tempo stesso, non volle mai essere etichettato strictu sensu né come musulmano né come hindū. Tuttavia, essendo gli hindū la stragrande maggioranza dei suoi devoti, negli ultimi anni della vita del Bābā e soprattutto dopo la sua morte si determinò fatalmente una sempre più accentuata ‘hindūizzazione’ del culto.
Il suo background prima di giungere a Śirḍī è assai mal ricostruibile essendo avvolto in fitte nebbie agiografiche hindū. Il giovane ci viene presentato come figlio adottivo di un faqīr e quindi quale precoce discepolo di un maestro viṣṇuita (tale Gopālrāo Deśmukh, anche noto come Veṅkuśa) e cultore delle più raffinate tecniche dello Yoga. La spiritualità del Sāī Bābā, mirante a trascendere ogni barriera religiosa e culturale nel nome della fratellanza umana e dell’unicità (eka- tva) di Dio (che, proprio essendo il Mistero al fondo della realtà, può prendere ogni forma ancorché sia privo di forma, nirguṇa), evidenzia un tratto importante della spiritualità del Mahārāṣṭra (si pensi a Eknāth). Essa infatti ci si presenta come una mistica integrativa per eccellenza, assimilante influssi provenienti tanto dal nord quanto dal sud del subcontinente. Ciò ha condotto a integrazioni e complementarità tanto śivaite/viṣṇuite quanto del cosiddetto hindūismo e dell’islam in un orizzonte universalistico più ampio.
Nel Sāī Bābā, la componente musulmana e quella hindū sono inscindibili. Egli ha incarnato un paradigma di mutua fraternità fra le due comunità, sull’esempio del grande santo medievale Kabīr insistente sull’eguaglianza di tutti gli uomini e sull’unicità e inconoscibilità di Dio, chiamato indifferentemente Allāh o Rāma. Kabīr rappresenta il modello del Sāī Bābā anche per quanto concerne la leggenda circa le sue origini: Kabīr sarebbe cresciuto, forse quale figlio adottivo, in una famiglia di tessitori musulmani (Julāhā), e, successivamente, sarebbe divenuto discepolo del maestro viṣṇuita Rāmānanda.
Il Sāī Bābā fu un maestro dal carisma eccezionale che insegnò attraverso il suo esempio di vita, non attraverso discorsi o dotte disquisizioni teologiche. Egli non ci ha lasciato nulla di scritto. Semmai, il Bābā amava raccontare delle storie o lanciarsi in estemporanee conversazioni coi devoti presenti alla moschea. Se la sua giornata era scandita da una routine dagli orari piuttosto stabili (due o tre giri di questua presso alcune case del villaggio, incontri il mattino e la sera con i fedeli, periodi di solitudine), egli era d’altra parte altamente eccentrico e imprevedibile. Celebri sono le sue misteriose parabole, i suoi simbolismi numerici, le sue ire e i suoi comportamenti a dir poco bizzarri.Tratti essenziali della sua santità sono i protratti silenzi (anche per giorni), la contemplazione di un focolare a legna perpetuamente alimentato all’interno della moschea (la dhūnī, da cui egli estraeva la cenere sacra o udī che donava ai devoti quale pegno della sua grazia e alla quale si attribuiscono straordinari poteri), il voto di castità e povertà mantenuto sino alla fine (spesso egli chiedeva elemosine ai visitatori senza tema di contaminarsi per il fatto di maneggiar denaro: poi, puntualmente, alla fine della giornata le redistribuiva tra i fedeli più bisognosi).
Molto popolari sono alcuni suoi detti, quale per esempio quello che identifica nel binomio fede (niṣṭhā, śraddhā) e pazienza (saburī, termine tipicamente ṣūfico), devozione e coraggiosa sopportazione, le due ‘monete’ o virtù fondamentali in grado di far attraversare il periglioso oceano del saṃsāra. Il Sāī Bābā amava dire che quando ‘chiamava’ delle persone a Śirḍī egli le legava a sé per sempre. Paragonava i devoti a degli uccellini, cui legava le zampine con fili invisibili. Spesso diceva di ‘dare filo’, permettendo loro di svolazzare anche molto lontano per le vie del mondo, altre volte diceva invece di ‘tirare i fili’, così da tenerli vicini a sé. Essendo tutti legati a lui ed essendo lui a reggere i fili e le fila d’ogni cosa, concludeva dicendo che tutti dovranno comunque far ritorno ‘a casa’, senza eccezione. L’idea è che è sempre il maestro divino a reggere i fili dei destini umani, delle diverse ‘traiettorie karmiche’, e che tutto è frutto della sua iniziativa, della sua chiamata.
Fondamentale è la fama del Sāī Bābā come operatore di prodigi. È in primis a motivo di queste supposte facoltà miracolose che egli deve la sua popolarità. La sua biografia/agiografìa più importante, lo Śrī-sāī-satcarita, in marāṭhī, documenta un’impressionanate varietà di atti di potenza a lui ascritti (sia in vita, sia in morte): alcune risurrezioni, materializzazioni, guarigioni d’ogni tipo, bilocazioni, il conferire progenie a coppie sterili, dare visione di sé come una qualche divinità del pantheon hindū, il proteggere il villaggio da malattie epidemiche quali il colera tramite l’utilizzo di ‘cerchi magici’ di farina tracciati tutt’intorno l’abitato quale invalicabile ‘confine’ ecc. Mentre i devoti musulmani lo onorano alla stregua di un grande santo (pīr), per gli hindū il Sāī Bābā è un sarva-jña, un “onnisciente”, ovvero un avatāra, una manifestazione divina che, oltre all’onniscenza, assomma i tratti dell’onnipotenza e dell’onnipresenza. I fedeli credono fermamente alla promessa del Bābā, che un giorno ebbe a dichiarare: «Sarò più attivo dalla tomba di quanto non fossi quand’ero in vita».
Più che sui suoi tanti miracoli, i vegliardi che lo conobbero e che ebbi la ventura d’incontrare circa ventanni fa a Śirḍī, ponevano l’accento sulla personalità del santo: misericordioso e amorevole (sempre pronto a condividere il cibo elemosinato con poveri e lebbrosi, anche con animali) ma anche severo e terribile nei suoi imprevedibili scatti d’ira (le ‘ire sante’ potevano durare ore e allora tutti venivano allontanati a male parole o perfino a sassate e nessuno gli si poteva avvicinare). Sono tratti che richiamano la duplice tipologia jamālī/jalālī tipica del sufismo. I suoi occhi erano intensi e profondi, trafiggevano i devoti, che volentieri naufragavano in quel ‘mare’. Una dichiarazione di uno di questi anziani mi è rimasta particolarmente impressa: l’esperienza di trovarsi al cospetto del Sāī Bābā dava la netta sensazione d’essere al cospetto di Dio.
Accanto ai tīrtha tradizionali, Śirḍī è senz’altro tra i luoghi di pellegrinaggio più importanti di tutto il subcontinente. Il culto quotidiano al tempio principale, il samādhi-mandir ove si venera la murti del Sāī Bābā e ove è posta la sua tomba, è perfettamente ‘hindūizzato’. L’adorazione del Bābā, equiparato a un “grande re” (mahā-rāja), è identica a quella che si offre a una divinità. Il programma di una giornata-tipo prevede la routine seguente: alle 5:15 si inizia con la cerimonia del “risveglio” del dio (kākaḍ-ārtī)’, alle 6:00 si svolge il bagno, la toilette del Sāī Bābā ossia il lavacro della sua mūrti; dalle 7:30 alle 11:00 i fedeli possono recare le offerte (incenso, fiori, cibo ecc.) e onorare il dio con una serie di abluzioni (abhiṣeka) che sono solennemente officiate dai sacerdoti pujārī (il culto è intervallato alle 9:00 dalla satyanārāyaṇa-pūjā); alle 12:00 segue l’ārtī di mezzogiorno. Intorno alle 16:00, una qualche personalità tiene un discorso religioso oppure si svolge una lettura edificante tratta da un Purāna o dallo Srī-sāī-satcarita. Al tramonto, si celebra un terzo ārtī (dhūp-ārtī). Dalle 21:00 alle 22:00 si cantano inni devozionali (kīrtan, bhajan). Infine, alle 22:00, si celebra il quarto e ultimo ārtī (śej-ārtī), col quale il Sāī Bābā è ‘preparato’ per la notte e ‘messo a dormire’. Prima di questo ārtī i fedeli possono recare altri doni e offerte alla mūrti (ghirlande di fiori, cibo ecc.) o qualsiasi altra cosa vogliano far benedire. In occasione delle grandi festività (quali rāmanavamī’, guru-purṇimā, datta-jayantī, mahā-śiva-rātrī ecc.), la utsava-mūrti del Sāī Bābā è portata in processione su di un palanchino (pālkhì) in pompa magna e con tutti gli onori, anche alla presenza di autorità politiche oltre che religiose.”