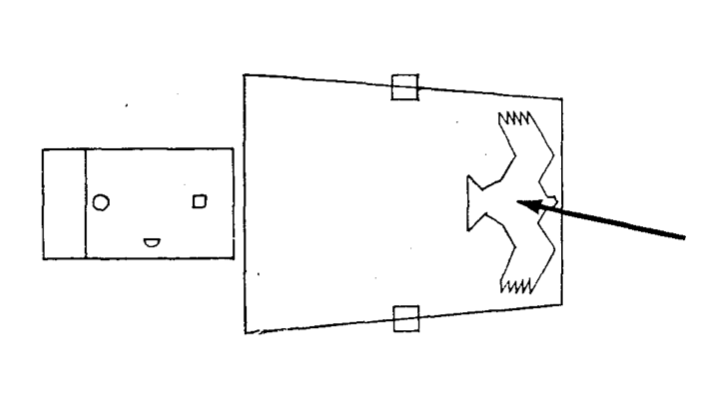scarica il pdf in italiano
scarica il pdf in originale inglese
In questo capitolo mi occuperò, da un lato, di quelli che sono considerati fatti indiscutibili e, dall’altro, di teorie speculative e talvolta controverse. “E forse, guardando le due cose l’una accanto all’altra e sfregandole l’una contro l’altra, potremo far divampare la giustizia come da due bastoni ardenti” (Platone, Repubblica 435 a 1-6).
Per comprendere l’agnicayana è necessario innanzitutto conoscere agni.1 Circa 200 dei 1.028 inni del ṛgveda sono rivolti ad agni, che in questo senso è secondo solo a indra. Il nome di agni è chiaramente indoeuropeo: si pensi al latino ignis, al russo ogon’, al lituano ugnis, ecc. Pur essendo considerato un dio, non è mai slegato dal suo elemento, il fuoco, fino alla mitologia indù più tarda, dove appare in termini più antropomorfi. Nel ṛgveda, agni è brillante, dorato, ha capelli e barba fiammeggianti, tre o sette lingue, il suo volto è chiaro, i suoi occhi brillano, ha denti affilati, fa un rumore di crepitii e lascia dietro di sé una scia nera. È ghiotto di burro chiarificato (ghṛta, o ājya se usato come oblazione), ma mangia anche il legno e divora la foresta. In effetti, mangia tutto (viśva-ad). È in particolare un distruttore di demoni e un uccisore di nemici.
Pur essendo vecchio, agni è anche senza età e permanentemente giovane. Egli stesso fertile, è figlio e manifestazione della forza vittoriosa (sahas; Gonda 1957). Dà lunga vita. Nasce dai blocchi accesi (araṇī), dal cielo (dove è il fulmine e il sole) e dalla terra, dove risiede nelle piante e nei boschi. Nasce anche dall’acqua, sia celeste che terrestre. Questa origine, a prima vista sorprendente, è collegata alle nuvole e alla legna da ardere che proviene da piante e alberi, anch’essi nati dall’acqua. Riflette l’immagine del sole che sorge dall’oceano orientale e tramonta in quello occidentale; e indica anche che agni, come potenza generativa, è il principio maschile, che entra nelle acque femminili come entra nella terra.
agni è intimamente legato alla casa, al clan, alla tribù e ai rituali. È installato nella casa come fuoco domestico; custodisce e illumina la casa; è ospite, amico, capo del clan o della tribù (ad esempio, degli aṅgira o dei bharata). Ma è anche il sacerdote domestico, il sacerdote hotā o adhvaryu e il sacrificatore degli dei. Ha una triplice sede (i tre altari). È intelligente, infatti, saggio e onnisciente: è un veggente, ispirato e ispiratore. Porta le offerte agli dèi, ma fa anche scendere gli dèi sulla terra per parteciparvi. È il messaggero tra gli dei e gli uomini. È il compagno di tutti gli uomini (vaiśvānara). Questo appellativo è tradizionalmente considerato come un riferimento al sole, al fuoco sacrificale e, in tempi successivi, al “fuoco della digestione” (ma vedi sotto, pagg. 161-162). Si suggerisce anche che agni come jātavedas sia identificato con il fuoco domestico, e come naraśaṃsa o tanūnapāt, con il fuoco meridionale (Findly, inedito). agni ha anche strette relazioni con diverse altre divinità. La sua funzione rituale diventa sempre più importante nello yajurveda e nei brāhmana.
Ecco un tipico inno rivolto ad agni (ṛgveda 5.11):
- Guardiano del popolo, vigile e intelligente, agni è nato per una nuova prosperità. Con il volto ricoperto di burro, risplende di una grande fiamma che tocca il cielo per tutti i bharata.
- Sul triplice altare gli uomini hanno acceso agni, vessillo del sacrificio, primo sacerdote domestico. Che cavalchi il carro con indra e gli dèi !; che sia seduto sull’erba sacra per il sacrificio come un abile hotā!.
- Impuro, sei nato dai tuoi genitori; luminoso, sei sorto come veggente portatore di gioia di vivasvant. Con il burro ti hanno reso forte, agni, a cui viene fatta l’offerta.
- agni . . . possa venire subito al sacrificio; agni, che gli uomini portano in ogni casa; agni è diventato il messaggero, il portatore di offerte; agni che stanno scegliendo, scegliendo uno con un potere di veggenza.
- Per te, agni, queste parole dolcissime; per te questa preghiera sia una benedizione per il cuore. Tu sei colui che questi canti riempiono di forza, come i grandi fiumi riempiono l’Indo, tu sei colui che essi rendono forte.
- Gli aṅgiras ti hanno trovato in un luogo segreto, agni, che riposi in ogni bosco. Così nasci, quando ti agiti con grande forza; sei colui che chiamano “Figlio della Forza”, O aṅgiras.
| जन॑स्य गो॒पा अ॑जनिष्ट॒ जागृ॑विर॒ग्निः सु॒दक्षः॑ सुवि॒ताय॒ नव्य॑से । घृ॒तप्र॑तीको बृह॒ता दि॑वि॒स्पृशा॑ द्यु॒मद्वि भा॑ति भर॒तेभ्यः॒ शुचिः॑ ॥ |
jánasya gopā́ ajaniṣṭa jā́gṛviragníḥ sudákṣaḥ suvitā́ya návyase ǀ ghṛtápratīko bṛhatā́ divispṛ́śā dyumádví bhāti bharatébhyaḥ śúciḥ ǁ |
|---|---|
| य॒ज्ञस्य॑ के॒तुं प्र॑थ॒मं पु॒रोहि॑तम॒ग्निं नर॑स्त्रिषध॒स्थे समी॑धिरे । इंद्रे॑ण दे॒वैः स॒रथं॒ स ब॒र्हिषि॒ सीद॒न्नि होता॑ य॒जथा॑य सु॒क्रतुः॑ ॥ |
yajñásya ketúm prathamám puróhitamagním nárastriṣadhasthé sámīdhire ǀ índreṇa deváiḥ sarátham sá barhíṣi sī́danní hótā yajáthāya sukrátuḥ ǁ |
| अस॑म्मृष्टो जायसे मा॒त्रोः शुचि॑र्मं॒द्रः क॒विरुद॑तिष्ठो वि॒वस्व॑तः । घृ॒तेन॑ त्वावर्धयन्नग्न आहुत धू॒मस्ते॑ के॒तुर॑भवद्दि॒वि श्रि॒तः ॥ |
ásammṛṣṭo jāyase mātróḥ śúcirmandráḥ kavírúdatiṣṭho vivásvataḥ ǀ ghṛténa tvāvardhayannagna āhuta dhūmáste ketúrabhavaddiví śritáḥ ǁ |
| अ॒ग्निर्नो॑ य॒ज्ञमुप॑ वेतु साधु॒याग्निं नरो॒ वि भ॑रंते गृ॒हेगृ॑हे । अ॒ग्निर्दू॒तो अ॑भवद्धव्य॒वाह॑नो॒ऽग्निं वृ॑णा॒ना वृ॑णते क॒विक्र॑तुं ॥ |
agnírno yajñámúpa vetu sādhuyā́gním náro ví bharante gṛhégṛhe ǀ agnírdūtó abhavaddhavyavā́hano’gním vṛṇānā́ vṛṇate kavíkratum ǁ |
| तुभ्ये॒दम॑ग्ने॒ मधु॑मत्तमं॒ वच॒स्तुभ्यं॑ मनी॒षा इ॒यम॑स्तु॒ शं हृ॒दे । त्वां गिरः॒ सिंधु॑मिवा॒वनी॑र्म॒हीरा पृ॑णंति॒ शव॑सा व॒र्धयं॑ति च ॥ |
túbhyedámagne mádhumattamam vácastúbhyam manīṣā́ iyámastu śám hṛdé ǀ tvā́m gíraḥ síndhumivāvánīrmahī́rā́ pṛṇanti śávasā vardháyanti ca ǁ |
| त्वाम॑ग्ने॒ अंगि॑रसो॒ गुहा॑ हि॒तमन्व॑विंदंछिश्रिया॒णं वने॑वने । स जा॑यसे म॒थ्यमा॑नः॒ सहो॑ म॒हत्त्वामा॑हुः॒ सह॑सस्पु॒त्रमं॑गिरः ॥ |
tvā́magne áṅgiraso gúhā hitámánvavindañchiśriyāṇám vánevane ǀ sá jāyase mathyámānaḥ sáho maháttvā́māhuḥ sáhasasputrámaṅgiraḥ ǁ |
Non è possibile comprendere il ruolo di agni nel ṛgveda se non in relazione ad altre divinità, poteri e idee. Mi limito a ricordare che agni è vicino a indra, anche se indra è un dio guerriero e un eroe, mentre agni rimane sempre vicino al fuoco. Per altri aspetti, agni è complementare a soma, che è un dio, una pianta e il succo estratto da quella pianta, ed è quindi privo di tratti antropomorfi. agni e soma, pur essendo entrambi dèi, non risiedono semplicemente in cielo o nel cielo, da dove devono essere portati o richiamati sulla terra. Sono anche già qui, concreti, visibili, possono essere toccati e gustati, presenti nelle mani degli uomini. Secondo Renou, seguendo Bergaigne, l’intera mitologia vedica fu rimodellata, o comunque riorientata, come ambientazione per agni e soma, e tutte le altre divinità divennero loro controparti o riflessi (Renou 1953, 14). agni e soma, il fuoco sacro e la bevanda sacra, sono in ogni caso le principali divinità del rituale vedico. Mentre tutte le divinità del pantheon vedico vengono affrontate e invocate nel corso delle rappresentazioni rituali e il paradiso viene menzionato come frutto dei rituali, il rituale stesso crea un mondo sacro all’interno del recinto sacrificale per mezzo delle attività sacerdotali che si svolgono qui e ora. Qui sta la spiegazione più probabile del fatto, sottolineato da Renou (1953, 16), che gli episodi più importanti della mitologia vedica, che riflettono eventi cosmogonici, non sono riflessi o utilizzati nel rituale. Tutte le caratteristiche della religione vedica trovano espressione nel rituale, ma generalmente attraverso la mediazione di agni e soma.
Nel tardo Induismo, il personaggio di agni cambia. Sebbene alcuni templi siano stati dedicati al suo culto, agni diventa una divinità minore e una figura mitica. Il suo cambiamento di posizione è già indicato nella kena upaniṣad, in cui gli dèi, confusi da brahman (“Che razza di spettro può essere questo?”), inviano agni per scoprirlo. All’arrivo di agni, brahman gli chiede: “Chi sei?”. agni rispose: “Sono agni”. “Se è questo che sei, qual è il tuo potere?”. “Posso bruciare ogni cosa sulla terra”. Allora brahman gli mise davanti un filo d’erba: “Brucia questo”. agni si avventò su di esso con tutta la sua forza, ma non riuscì a bruciarlo.
Nell’epica e nei purāna, “agni è un seduttore di donne senza scrupoli e un adultero, qualità che lo fanno identificare con śiva” (O’Flaherty 1973, 91, nel capitolo intitolato agni, the Erotic Fire). Nella mitologia successiva, è śiva che dona agli dèi un filo d’erba che essi non riescono a bruciare. Oltre al fuoco sessuale, agni è anche il fuoco del tapas, “calore ascetico”, un altro legame con śiva. In una leggenda che si trova in molte versioni, agni si innamora delle mogli dei sette saggi. La storia offre anche una spiegazione dell’associazione di agni con il rituale chiamato svāhā (sopra, pagina 47). Come raccontata nel mahābhārata e riassunta da O’Flaherty, la leggenda merita di essere citata:
Una volta, quando agni vide le belle mogli dei grandi saggi che dormivano nel loro eremo, fu sopraffatto dal desiderio per loro. Ma rifletté: “Non è opportuno che io sia pieno di desiderio per le caste mogli dei bramini, che non sono innamorate di me”. Allora entrò nel fuoco domestico per poterle toccare, per così dire, con le sue fiamme, ma dopo molto tempo il suo desiderio divenne ancora più grande ed entrò nella foresta, deciso ad abbandonare la sua forma corporea. Allora svāhā, la figlia di dakṣa, si innamorò di lui e lo osservò a lungo, cercando qualche punto debole, ma invano. Quando seppe che lui era andato nella foresta pieno di desiderio, la dea amorosa decise di prendere le sembianze delle mogli dei Sette Saggi e di sedurre agni; così entrambi avrebbero ottenuto il loro desiderio. Assumendo a turno le sembianze di ciascuna delle mogli, fece l’amore con agni, ma non poté assumere le sembianze di arundhatī, la moglie di vasiṣtha, perché arundhatī aveva grandi poteri di castità. Prendendo ogni volta in mano il seme di agni, rifletté: “Chiunque mi veda in questa forma nella foresta accuserà ingiustamente le mogli dei saggi di aver commesso adulterio con agni”, quindi per evitare ciò prese la forma dell’uccello gāruḍī e lasciò la foresta. Gettò il seme in un lago dorato sulla vetta della montagna bianca sorvegliata dalle schiere di rudra. Il seme generò un figlio, skanda, e qualche tempo dopo le mogli dei sei saggi andarono da skanda e gli dissero che i loro mariti, pensando che skanda fosse nato da loro, le avevano abbandonate. Pregarono skanda di farle dimorare per sempre in cielo e, per sua grazia, divennero la costellazione dei kṛttika, considerate le madri di skanda. Poi svāhā sposò agni (O’Flaherty 1973, 94-5).
La posizione intermedia di agni è mantenuta in un’altra leggenda, che getta luce sulla psicologia delle libagioni. Sebbene parvatī sia la sposa di śiva, non è in grado di sopportare l’energia infuocata del seme di śiva. agni collabora bevendo il seme, cospargendo con esso (o con il proprio seme) il Gange, dopodiché parvatī lo beve, riceve il seme così opportunamente diluito e dà alla luce skanda (O’Flaherty 1973, 103-107; Foto 9; si veda anche O’Flaherty 1975, 104).
Il simbolismo sessuale del fuoco è anche collegato all’analogia tra l’azione dei due legni accesi e l’atto sessuale, un’associazione che si ritrova in tutto il mondo. ṛgveda 3.29.1-3 paragona manthana, “accensione del fuoco per attrito”, alla procreazione: agni è nascosto nei blocchi di fuoco (araṇī) come il seme (garbha) è ben custodito nelle donne incinte (garbhin). “Mettilo giù nella posizione supina, tu attento (sacerdote). Quando rimase incinta partorì il maschio (agni)”.
Nella bṛhad āraṇyaka upaniṣad 6.4.21 - una sezione a volte lasciata senza traduzione, che incorpora versi del ṛgveda 10.184 e dell’atharvaveda 5.25 - l’associazione è invertita:
Le allarga le cosce. Che il cielo e la terra si allarghino! Unendosi a lei, appoggiando la bocca sulla sua, accarezzandola tre volte nella direzione in cui crescono i peli, dice:
Che viṣṇu prepari il grembo materno, che tvaṣṭṛ plasmi le forme, che prajāpati emetta il seme, Lasciate che dhātṛ ponga il seme in voi. Poni il seme, sinīvālī, Poni il seme, dea dai capelli fluenti! Lascia che i gemelli aśvin pongano il seme in te, le due divinità dalle guance di loto. D’oro sono i legni che gli aśvin usano per accendere il fuoco. Invochiamo quel seme per voi Per partorire nel decimo mese. Come la terra è incinta di agni, come il cielo è in attesa di indra, Come il vento è il seme dei cieli, io metto il seme in voi.
Nel tardo Induismo, agni rimane strettamente legato all’incendio delle foreste. Nel mahābhārata, kṛṣṇa e arjuna fanno un picnic sulle rive del fiume yamunā. Le loro amiche ballano, cantano, litigano e bevono vino. “L’epica ci presenta pochi momenti, se non nessuno, più adatti a una scena di agio e di piacere” (Hiltebeitel 1976, 209). Ma ora appare “un bramino dall’aspetto strano, dalla carnagione dorata e dalla barba bruno-giallastra, radioso e splendido. . . È agni sotto mentite spoglie. Inizia così uno dei segmenti più strani e più macabri dell’epopea, l’incendio della foresta di khāṇḍava”. In questa storia, agni, per ragioni che non è il caso di trattare, è venuto a consumare la foresta con tutte le sue creature. Esegue. Il rumore è assordante, l’acqua delle nuvole di indra non può raggiungere il suolo a causa del calore e solo sei persone sopravvivono. Hiltebeitel conclude il suo studio sul significato mitologico di questa conflagrazione con l’osservazione “che la storia stessa può iniziare ad avere senso come storia, indipendentemente dal fatto che abbia o meno senso anche come storia” (ibid., 224). In ciò che segue mi occuperò principalmente del contrario: agni, soma, indra, viṣṇu e molti elementi del rituale vedico hanno un significato mitologico e spirituale, ma hanno senso anche come storia e preistoria.
Per comprendere meglio la figura di agni dobbiamo andare ben oltre il ṛgveda, risalendo di fatto alla storia più antica dell’uomo.2 Questa storia antica rende conto di molte caratteristiche di agni e dei rituali del fuoco come l’agnihotra, l’agniṣṭoma e l’agnicayana.
Sebbene l’uso del fuoco sia stato attribuito a una scimmia-uomo subumana (Australopithecus prometheus), l’opinione prevalente tra gli studiosi lo attribuisce solo a agli uomini. Con l’eccezione di alcuni insetti, uccelli e del tarsio delle Filippine (un animale notturno che raccoglie le braci calde dei falò), la maggior parte degli esseri umani ha una forte avversione per il fuoco. L’uomo ha impiegato molto tempo per superare la paura del fuoco, ma alla fine lo ha domato e poi addomesticato. In questa evoluzione si possono distinguere quattro fasi: (1) un’epoca senza fuoco, testimoniata da un primo uomo o ominide, Zinjanthropus, della cultura di Olduwan, nell’Africa orientale, circa 1.750.000 anni fa; (2) un’epoca durante la quale il fuoco veniva usato, cioè raccolto, come dimostra il caso dell’uomo di origine animale, raccolta, come testimoniano i focolari dell’uomo di Pechino, almeno 250.000 anni fa; (3) un’epoca in cui il fuoco è stato prodotto e acceso, come testimoniano l’uomo di Neanderthal circa 50.000 anni fa e l’Homo sapiens negli ultimi 20.000-15.000 anni; (4) un’epoca in cui il fuoco è stato addomesticato, che si sovrappone approssimativamente al Neolitico, iniziando in regioni diverse in tempi diversi negli ultimi 10.000 anni.
Da queste scale temporali si possono trarre diverse conclusioni. Per la maggior parte della sua storia, l’uomo si è tenuto lontano dal fuoco e lo ha osservato da lontano. Infine, ha iniziato a raccoglierlo con attenzione dagli incendi che derivavano da conflagrazioni naturali. Sauer ritiene che la regione dei laghi, attiva dal punto di vista vulcanico, nell’interno montuoso dell’Africa orientale, possa aver fornito all’uomo il primo fuoco, anche se il fuoco poteva essere ottenuto da un fulmine o da una combustione spontanea, ad esempio attraverso il contatto tra l’aria e alcuni tipi di carbone (tali carboni si trovavano non lontano dall’area di Choukoutien, dove è stato trovato l’uomo di Pechino). Durante le centinaia di migliaia di anni in cui il fuoco è stato raccolto ma non poteva ancora essere prodotto, l’uomo si è continuamente preoccupato di conservarlo in modo sicuro e corretto, perché non si sapeva quanto tempo sarebbe passato prima di poter ottenere nuovamente del fuoco fresco. Non è azzardato supporre che il senso di continuità dell’uomo sia stato ispirato dalla sua esperienza con il fuoco.
Il fuoco è stato trasportato su lunghe distanze, consentendo all’uomo di spostarsi nelle regioni più fredde dell’Europa settentrionale e dell’Asia, e quindi deve essere stato speso molto ingegno per sviluppare metodi affidabili per la sua conservazione e il suo trasporto. E ora osserviamo un fatto notevole. Quando l’uomo ha finalmente scoperto come fare il fuoco da solo, ha continuato a prendere precauzioni estreme per conservarlo e trasportarlo, e ha acceso il fuoco fresco solo raramente. Questa tendenza può essere spiegata solo in parte dal fatto che potrebbe far risparmiare combustibile e manodopera, essere necessario in un clima umido, mantenere il portatore in qualche modo caldo o essere utile durante la caccia, quando il fuoco deve essere a portata di mano. L’universalità della pratica di mantenere il fuoco suggerisce che si tratta in gran parte di un’usanza sopravvissuta dalla precedente epoca di raccolta del fuoco. Poiché le attività rituali sono attività che vengono svolte anche se non sono, o non sono più, necessarie o addirittura funzionali, l’usanza di conservare e portare con sé il fuoco è diventata una delle prime attività rituali di cui siamo a conoscenza. Ciò ha portato l’uomo a pensare a se stesso come separabile dal fuoco e vulnerabile senza di esso. Non sorprende che il fuoco e la vita siano stati collegati fin dall’inizio e che la conservazione del fuoco sia stata considerata come la conservazione della vita. Così è nata l’idea che un un fuoco duraturo dà una lunga vita. La sua controparte è l’usanza di spegnere il fuoco quando qualcuno muore. Il timore di perdere il fuoco e l’usanza di conservarlo prevalgono ancora oggi presso diverse popolazioni in tutto il mondo. Sebbene la maggior parte dei nomadi e dei seminomadi contemporanei, ad esempio, siano in grado di produrre il fuoco in meno di un minuto, portano il fuoco con sé nella maggior parte dei loro viaggi o delle loro cacce che coprono lunghi periodi di tempo.
I focolari si sono sviluppati durante il periodo di raccolta del fuoco. In origine si trattava di depressioni poco profonde rivestite di pietre o argilla. I focolari in argilla bruciata sono stati ritrovati in molte regioni diverse. Molti sono di forma circolare, forse a causa della disposizione del combustibile intorno al fuoco. Anche i focolari erano realizzati in pietra o sabbia. Un’invenzione successiva fu quella di alzare il combustibile sopra il focolare, per favorire la combustione aumentando il tiraggio. Questo poteva essere fatto ammassando il combustibile su alcune grandi pietre, un metodo che alla fine si è sviluppato negli altari di pietra e nelle prime stufe. Anche tra le tribù contemporanee ci sono alcuni che non utilizzano questi metodi. Tra i Warao della ex Guiana Britannica, ad esempio, il focolare è semplicemente “un grande blocco di argilla, di circa un metro di diametro e di circa 30 cm di spessore, che viene imballato dalle donne sulle travi della palma di manaca della casa-cucina” (Wilbert 1967, 9).
Il primo combustibile è stato probabilmente il legno e le qualità combustibili dei diversi tipi di legno sono state apprese molto presto. Altri primi tipi di combustibile sono il carbone, lo sterco, le ossa e il grasso. La costante ricerca di combustibile, un’attività che richiede molto tempo, ha portato alla deforestazione in molte aree (e continua a farlo) ed è stata collegata a varie caratteristiche dell’organizzazione sociale, tra cui la schiavitù. Gli insediamenti e i villaggi dovevano spostarsi quando le scorte di legna da ardere erano esaurite. Gli indiani del New England pensavano che gli inglesi fossero arrivati sulle loro coste perché le scorte di legna da ardere nelle loro terre erano esaurite. La raccolta del combustibile era accompagnata da elementi rituali. Tra i Paiute del Nord, le ragazze che si sottoponevano ai riti della pubertà dovevano raccogliere ogni giorno cinque cataste di legna da ardere. Le Vestali dell’antichità classica avevano compiti simili.
Il trasporto del fuoco su brevi distanze poteva essere effettuato con l’aiuto di un tizzone ardente o fiammeggiante, o di alcune braci calde, trasportate su una pietra piatta o cava. Per i lunghi tragitti si dovevano sfruttare le proprietà di combustione delle sostanze quando vengono private dell’aria, come il legno in decomposizione, corteccia e funghi. Il fuoco veniva trasportato (e viene tuttora trasportato dagli abitanti della Terra del Fuoco) su argilla sparsa sul pavimento delle canoe. Con lo sviluppo della ceramica, i vasi di argilla divennero i contenitori preferiti per il trasporto sicuro del fuoco su lunghe distanze. Una vivida descrizione si trova nel resoconto di Senofonte di una delle spedizioni di Agesilao, re di Sparta (401-360 a.C.):
Fu allora che Agesilao si guadagnò il merito con un espediente banale ma tempestivo. Infatti, poiché nessuno di quelli che portavano le provviste per il reggimento aveva portato il fuoco, e faceva freddo, non solo perché si trovavano ad alta quota, ma anche perché verso sera c’erano state pioggia e grandine - e inoltre erano saliti con abiti leggeri adatti alla stagione estiva - e stavano tremando e, nell’oscurità, non avevano voglia di cenare, Agesilao inviò almeno dieci uomini che portavano il fuoco in vasi di terra. E quando questi uomini furono saliti da una parte e dall’altra e furono stati accesi molti grandi fuochi, poiché c’era molto combustibile a portata di mano, tutti i soldati si spalmarono di olio e molti di loro cominciarono a cenare solo allora (Hellenica IV.v.4; traduzione di C. L. Brownson, con una modifica).
Quando il fuoco viene trasportato per lunghi periodi, deve essere installato su un focolare temporaneo per la notte o ogni volta che si fa una sosta. Bisogna prendere speciali precauzioni affinché non si spenga. Questo è il caso, ad esempio, di Omero, che descrive il calare della notte dopo che Odisseo era stato portato sulle coste dell’isola di Ogygia:
Come un uomo che nasconde un tizzone nelle braci nere di un lontano podere isolato, conservando il seme del fuoco per non doverlo cercare altrove, così Odisseo si coprì di foglie (Odissea V. 488-91).
In tutto il mondo, quando il fuoco si spegne in una casa di un villaggio, viene preso in prestito da un vicino, spesso portando qualche brace su un coccio. In seguito questa responsabilità è stata assunta dallo Stato. Carlo Magno ordinò di tenere un fuoco acceso in ogni casa abitata. Fino al XVIII secolo, in Europa, le campane venivano suonate al calar della sera. Si chiamava cur-few (“cover-fire”, francese: couvre-feu, italiano: copri-fuoco). In origine il termine cur few si riferiva a un attrezzo di ottone, simile a uno spegni-candela ma più grande, con un manico e dei fori, che veniva posto sopra i carboni e le braci del camino per mantenerli vivi durante la notte.
La cura del fuoco richiedeva un’attenta pianificazione e si è ipotizzato che sviluppasse il senso dell’uomo per il futuro e per il tempo in generale: un’ipotesi che sembra sottovalutare la sensibilità dell’uomo al passare del giorno e della notte e delle stagioni. Mentre la raccolta della legna da ardere e, più tardi, l’accensione del fuoco erano occupazioni per lo più maschili, la cura del fuoco era per lo più affidata alle donne. La maggior parte degli archeologi e degli antropologi concorda sul fatto che le prime case si sono sviluppate intorno ai focolari e che la vita familiare è stata fortemente influenzata dalla cura del fuoco. Anche oggi, quando grandi gruppi di persone vivono insieme in capanne o case comuni, ogni famiglia mantiene il proprio fuoco. I primi sociologi hanno descritto questa associazione domestica in termini coloriti, come ad esempio Lippert nel 1887:
La cura del fuoco è un affare da donne. Costituiva il centro della sfera della vita che la donna dominava. Questo rendeva la vita domestica della donna più stabile e in qualche misura più onerosa di quanto non fosse in precedenza, ma la rendeva anche molto più attraente per gli uomini rispetto a quando il suo fascino sessuale intermittente era stato l’unico richiamo. Coloro che in precedenza avevano cercato la compagnia della donna solo per periodi limitati erano ora legati in modo permanente al suo focolare, e presto non più come semplici ospiti, ma da legami di doveri e obblighi reciproci. Intorno al focolare nacque la casa in tutti i sensi (Lippert 1931, 131).
Nel racconto di Senofonte vengono toccati diversi usi importanti del fuoco: il calore, la cucina e la luce sono tra i più elementari. Molto più antico è l’uso del fuoco che ha reso possibile l’abitazione nelle caverne tenendo lontani gli animali pericolosi. In un periodo molto antico, le punte delle lance venivano indurite nel fuoco. Dopo l’età della pietra, il fabbro divenne uno dei primi specialisti. Gli incendi venivano usati per scacciare la selvaggina e le conflagrazioni che ne derivavano allargavano le praterie (ad esempio, in America). Gli incendi portarono a una nuova vegetazione e a una nuova fauna. Gli incendi provocati dall’uomo per catturare la selvaggina possono aver contribuito all’estinzione di grandi animali come il mammut. In epoche molto più tarde, questi nuovi pascoli venivano utilizzati per far pascolare le mandrie e le ceneri come fertilizzante. Il disboscamento delle foreste con il fuoco è un passo importante verso l’agricoltura. Sotto tutti questi aspetti il fuoco è come l’uomo: una forza spietata che disturba e trasforma l’ecologia.
La cucina potrebbe essere nata relativamente tardi, forse non molto prima dell’uomo di Neanderthal. Eiseley ha un elogio eloquente, anche se specificamente americano, della carne:
La carne, più preziosa dell’oro per cui gli uomini hanno lottato in seguito, ha fornito l’energia che ha portato l’uomo attraverso il mondo. Se non fosse stato per il fuoco, però, tutta questa enorme fonte di vita gli sarebbe stata negata: avrebbe continuato a bere il sangue di piccole prede, a masticare stancamente le estremità di ossa non cotte o a masticare i corpi scoppiettanti delle cavallette (Eiseley 1954, 55).
Un altro uso precoce del fuoco era legato ai morti: la controparte, come abbiamo visto, del suo legame con la vita. Il fuoco veniva acceso sui corpi dei Neanderthal morti. Gli scavi negli antichi cimiteri Pueblo mostrano ancora masse di carbone e cenere che appaiono come uno strato nella terra sopra gli scheletri. La cremazione era comune nell’età del bronzo e del ferro e si è diffusa in tutto il mondo. Le eccezioni appaiono molto più tardi, soprattutto nel giudaismo e nel cristianesimo, e culminano in un decreto di Carlo Magno del 785, che rende la cremazione un reato capitale.
L’invenzione dei mezzi per produrre il fuoco rimane avvolta nel mistero. Potrebbe aver avuto luogo più di una volta. Tra i nostri contemporanei, solo gli abitanti delle isole Andamane presumibilmente ignorano quest’arte. Anche se ciò fosse vero, è più probabile che l’abbiano dimenticata piuttosto che non l’abbiano mai conosciuta in passato. I due metodi più antichi per accendere il fuoco sono la percussione e l’attrito; non si sa quale sia stato il primo. I metodi a percussione o per attrito si ottengono principalmente con l’aiuto di pirite e selce. L’uso più antico della pirite è documentato nel Neolitico e nell’Età del Bronzo ed è citato nell’Antico Testamento. Questo metodo continua a essere utilizzato in varie parti del mondo, soprattutto nell’Asia settentrionale. Un metodo unico, limitato al sud-est asiatico, è la produzione di scintille colpendo il bambù con un pezzo di porcellana. I metodi di percussione per produrre il fuoco hanno portato ad almeno un’etimologia fantasiosa:
Gli eschimesi, che in Groenlandia usano ancora il metodo della pietra focaia e della pirite, chiamano il fuoco ignek. Tra gli eschimesi occidentali, che vivono in Alaska e nelle vicinanze, la parola è knik, knok, knakhk, k’nuk, kanuk o ik’nuk. Questo rappresenta molto chiaramente il suono della selce che colpisce un blocco di pirite. . . . Queste parole per il fuoco tra gli eschimesi ci ricordano la serie di parole ari… agni, ogni, ugnis e ignis. È possibile che anch’esse indichino il suono del nodulo di selce e pirite (Peake 1933, 54-5; citato con favore da Oakley 1955, 44).
Anche se questa improbabile etimologia deve essere presa sul serio, rimane il problema che gli indiani non usavano il metodo della percussione.
L’altro metodo antico per fare il fuoco è l’attrito con il legno. Ne esistono diversi tipi, tra cui la “fire-saw, fire-drill, pump-drill e fire-plow”. Il “fire-drill” è probabilmente il più universale, essendo la Polinesia l’unica regione in cui è assente. In Europa risale probabilmente all’epoca neolitica; in Asia è più antico e non ancora obsoleto. Come in tutti i metodi che utilizzano l’attrito, ci sono due pezzi di legno, il più basso dei quali poggia a terra ed è chiamato “focolare”. Nel fire-drill, un trapano cilindrico o affusolato tenuto in verticale viene fatto ruotare tra le due mani che, allo stesso tempo, premono il bastone verso il basso in una fossa poco profonda del focolare. Il fuoco viene attizzato da un piccolo cumulo di stoppaccio, costituito, ad esempio, da funghi o foglie morte. Il processo dura generalmente meno di un minuto. Le parti verticali e orizzontali sono spesso chiamate rispettivamente attiva e passiva, o maschio e femmina, come abbiamo già visto nella sezione precedente.
Un tipo particolare di fire-drill è il thong-drill, in cui il cilindro verticale viene fatto ruotare da una corda fatta girare ad anello. Il palo viene tirato in modo tale che la rotazione ne cambi ripetutamente l’orientamento. Il palo viene abbassato con l’aiuto di un altro pezzo di legno, di osso, di pietra o di un guscio di noce di cocco. Attualmente questo metodo è diffuso tra gli eschimesi, nel nord dell’Asia, India e Indonesia.
...
La preparazione del fuoco è spesso accompagnata da riti e canti. In una saga irlandese:
Fionn estrasse dalla tunica i due bastoni sacri che portava con sé e li fece ruotare l’uno sull’altro mentre Usheen intonava il canto del fuoco:
Uccello d’oro Falco del Sole Scuoti una piuma, una piuma di fiamma.
Il fuoco balzò tra i bastoni e presto il focolare divampò (Young 1929, 133).
È probabile che entrambi i metodi, la percussione e l’attrito, siano stati scoperti casualmente quando gli uomini lavoravano con gli utensili. La percussione e l’attrito non sono attestati prima del Paleolitico superiore. Lucrezio spiegò che l’accensione per attrito ebbe origine osservando i rami di un albero sferzati l’uno contro l’altro dal vento fino a prendere fuoco. Sebbene questa ipotesi sia stata adottata da diversi storici, si riferisce a un evento piuttosto raro, mentre è più plausibile l’ipotesi che il fire-drill sia stato scoperto mentre si stava usando, e mutatis mutandis per le altre tecniche. Qualunque sia la loro origine, queste pratiche spiegano facilmente la convinzione che il fuoco risieda nel legno, così come l’effettiva raccolta del fuoco dai fulmini consolida la convinzione che il fuoco venga dal cielo. Alla base di queste nozioni c’è l’idea generale che il fuoco non si crea, ma si estrae o si libera. Lucrezio esprime ancora oggi ciò che deve aver lasciato perplesso l’uomo per migliaia di anni: “Se nei tronchi si nasconde la fiamma, il fumo e la cenere, bisogna che i tronchi siano composti da cose estranee, da cose estranee che si levano dai tronchi” (De Rerum Natura 1.871-872). Anche gli indiani Warao negano che il fuoco sia stato creato. Esso esisteva da tempo immemorabile ed elaborate mitologie spiegano che alcuni alberi contengono il fuoco e altri no (Wilbert 1967, 21).
Nell’ambito della speculazione religiosa, la distinzione rituale più elementare è quella tra due tipi di fuoco, il “fuoco perpetuo” e il “fuoco nuovo”. Questi due tipi rappresentano i due periodi principali della storia del fuoco: la prima età della raccolta del fuoco e la seconda età della produzione del fuoco. Come abbiamo visto, il trasporto del fuoco divenne un’attività rituale non appena non fu più necessario, cioè non appena furono scoperti i metodi per accendere il fuoco. L’installazione permanente del fuoco su focolari e altari, nelle case e nei templi, assunse un tono altrettanto rituale nello stesso momento e per lo stesso motivo. Questa ritualizzazione spiega anche perché il “fuoco perpetuo” è generalmente considerato più puro del “nuovo fuoco”, che non è altro che un inizio dell’evoluzione dell’uomo. Così il fuoco “puro” deve spesso essere ottenuto da un luogo sacro dove è stato conservato da tempo immemorabile.
L’uomo moderno non percepisce più la distinzione tra diversi tipi di fuoco. Sentiamo che il fuoco è fuoco e, se preferiamo il fuoco del focolare al riscaldamento centralizzato, attribuiamo la nostra preferenza a cose come il movimento luminoso delle fiamme o l’odore della legna bruciata. Durante la maggior parte dell’esistenza della nostra specie, tuttavia, quando il giorno finiva e cominciava a fare freddo e buio, eravamo ansiosi di accogliere il nostro fuoco come un caro amico su cui poter contare. Per l’uomo antico, i fuochi avevano la stessa individualità che riserviamo ad alcune persone e animali. Non comprendiamo facilmente i fuochi rituali fatti in occasioni diverse e ottenuti da luoghi diversi, tenuti separati o mescolati con cura. Noi stessi non sentiamo che se ci aspettiamo il nostro amico, chiunque altro lo farà altrettanto bene. Gli antichi e alcune tribù contemporanee trattano i fuochi con lo stesso tipo di considerazione.
Il fuoco, soprattutto quello perpetuo, era gelosamente custodito e circondato da estreme preoccupazioni per la sua purezza. Nei templi romani di Vesta, il fuoco doveva essere curato da vergini (se si spegneva, le Vestali venivano frustate dal Pontifex Maximus). Gli Ebrei proibivano il “fuoco straniero” e le tribù siberiane sul fiume Amur si dicevano restie a separarsi dal fuoco delle loro capanne. Quando veniva acceso un nuovo fuoco, l’evento era circondato da timore. In genere, tutti i fuochi esistenti dovevano essere spenti per primi. L’accensione del fuoco rituale avveniva a volte con il metodo stike-and-light (i fuochi d’altare di cui si parla nell’Antico Testamento erano installati in questo modo). Il metodo più comune per la preparazione del fuoco rituale, tuttavia, è quello dell’accensione per attrito. Sir J. G. Frazer lo ha riportato per tutta l’Europa e W. H. Gil bert per le Americhe.
La maggior parte dei miti sul fuoco ne attribuisce l’origine al cielo, il che sembrerebbe avvalorare l’idea che il fuoco sia stato originariamente ottenuto da un fulmine. Molti miti antichi raccontano che il fuoco fu portato dal cielo da un uccello. Questo uccello era spesso considerato un ladro, ed è diffusa anche la leggenda di un ladro di fuoco umano. Il suo prototipo nella cultura occidentale è il mito di Prometeo, che rubò il fuoco dal cielo e lo donò agli uomini. Zeus lo punì incatenandolo alle montagne del Caucaso, dove un’aquila raccolse il suo fegato in continua crescita. Prometeo è considerato l’inventore della civilizzazione umana, l’emblema della ribellione contro la tirannia e, in ultima istanza, il simbolo dell’umanità stessa. Nel “Prometeo legato” di Eschilo (436-471, 467-506) Prometeo si vanta delle sue invenzioni: Ho trovato uomini privi di senno, ho dato loro l’uso dell’ingegno e li ho resi padroni della loro mente. . . . Non sapevano costruire case con mattoni per affrontare il sole; non sapevano lavorare il legno. Vivevano come formiche brulicanti in buchi nel terreno, nelle caverne senza sole della terra. . . . Fui io che per primo aggiogai per loro le bestie nei gioghi e feci di quelle bestie gli schiavi delle catene e delle selle da soma, perché fossero il sostituto dell’uomo nei compiti più duri; e le imbrigliai alla carrozza, perché amassero le briglie, i cavalli, il fiore all’occhiello del lusso del ricco. Sono stato io, e nessun altro, a scoprire le navi, i carri trainati da vele che il mare buffetta…. Sotto la terra, la benedizione nascosta dell’uomo, il rame, il ferro, l’argento e l’oro: qualcuno affermerà di averli scoperti prima di me? Nessuno, ne sono certo, che voglia parlare veramente e con cognizione di causa. Una breve parola dirà tutto: tutte le arti che i mortali hanno derivano da Prometeo (traduzione di David Grene 1959, 327-329).
Il nome greco προμηϑενς generalmente interpretato come “prudente, con lungimiranza”, in relazione al verbo προμηϑεομ𝜶ι , “prevedere”. Il Dizionario Etimologico di Mayrhofer lo mette in relazione con il sanscrito pra-math, da math, “rubare, rapinare, portare via”. Nel ṛgveda 3.38.5, vastra-mathi è usato in relazione a un ladro che ruba i vestiti (vastram), e in 8.66.8 urā-mathi è applicato a un lupo che porta via le pecore (urā). Quest’ultimo termine ricorre ancora una volta, nel vādhula śrauta sūtra 28a, dove è applicato alle stagioni che portano via i riti. Fin dall’antichità il verbo math è stato confuso con manth, “mescolare, sfornare”, a cui potrebbe non essere etimologicamente legato. Questo termine è usato nel mito indù del rimescolamento dell’oceano mondiale. L’attività di agitazione di dèi e demoni ha fatto sì che l’acqua salata producesse latte, burro, vino, veleno e infine soma, elisir dell’immortalità (cfr. Gonda 1954, 128-129; O’Flaherty 1975, 273-280; ecc.). Il sostantivo manthana è usato non solo per riferirsi alla zangolatura, ma è anche il termine generale per indicare l’accensione del fuoco per attrito. In un commento al kātyayāna śaruta sūtra, il suo derivato pra manthana è definito come “il pezzo di legno che esce dal blocco di accensione superiore (uttarāraṇi), con il quale si accende il fuoco”. Nel suo libro sulla discesa del fuoco e la bevanda divina (Die Herabkunft des Feuers und des Gottertranks: 1859, 15-18), Adalbert Kuhn ha collegato pramanthana al nome di Prometeo, considerando quindi Prometeo non solo come rappresentante del furto del fuoco dal cielo (che corrisponde all’età della raccolta), ma anche dell’accensione del fuoco per attrito (età della produzione). Purtroppo questa etimologia è difficile da mantenere. Il collegamento corretto è con mathnāti, “ruba”, come ha dimostrato Johanna Narten (1960).
Se il fuoco segna l’origine della civiltà e il fuoco rituale l’inizio della religione, il fuoco rituale è anche collegato all’atletica. Dopo la battaglia di Plataea (479 a.C.), quando i Greci sconfissero i Persiani, Apollo ordinò la consacrazione di un altare di fuoco per Zeus, il liberatore. Come racconta Plutarco nella sua Vita di Aristide (cap. xx), tutti i fuochi esistenti erano stati inquinati dai barbari persiani e dovevano quindi essere spenti. Bisognava procurarsi un fuoco fresco e puro dal santuario di Apollo a Delfi, a una distanza di oltre 60 miglia. Un giovane atleta, Euchidas, si offrì volontario. Partì all’alba, corse nudo fino all’altare di Apollo a Delfi, dove “si purificò cospargendosi di acqua santa e si incoronò di alloro”. Prese il fuoco sacro su una torcia, corse indietro e arrivò a Plataea prima del tramonto. Lì consegnò il fuoco sacro ai suoi compatrioti, crollò per la stanchezza e morì (cfr. Sechan 1951, 2-3).
Mentre la corsa con la fiaccola, spesso corsa a staffetta, divenne una caratteristica prominente dei giochi greci, acquisì anche un significato simbolico. Platone (Leggi 776 b) dice che i genitori procreano e nutrono i figli, “maneggiando la vita come una fiaccola”. Nell’India antica, una pratica simile deve far pensare a metafore simili. Al centro del buddismo c’è la dottrina della rinascita e della trasmigrazione senza che nulla trasmigri. Nel II secolo a.C., il re greco Menandro (Pāli: Milinda) portò avanti il dominio greco in Bactria fondato da Alessandro Magno. Incuriosito dalla dottrina buddista, pose la domanda al saggio-monaco Nāgasena, chiedendogli di fornire alcune illustrazioni. Nāgasena iniziò la sua risposta dicendo che la rinascita avviene senza che nulla trasmigri, esattamente come una fiamma viene accesa da un’altra fiamma senza che il fuoco venga trasmesso (Milindapañha 71.16).
Come vedremo nella sezione dedicata al soma, gli indiani vedici credevano che il fuoco fosse portato dal cielo da un uccello rapace (śyena), che portava anche il soma, l’elisir dell’immortalità, sulla terra. I collegamenti tra il fuoco, un uccello e l’immortalità si trovano in tutto il mondo, ma assumono forme molto diverse. L’uccello solare egiziano benu e la fenice dell’antichità classica occidentale, poi adottata dal cristianesimo, rappresentano un tipo diverso, in cui la morte e la rinascita sono al centro del mito. Entrambi gli uccelli sono collegati alla vita dopo la morte. Nelle fonti classiche, l’enfasi era posta sulla generazione spontanea dell’uccello. Nel cristianesimo, la fenice è diventata un simbolo di resurrezione. Il legame con il fuoco non è noto in Egitto, ma si è sviluppato in Occidente. Secondo questa tradizione, l’uccello fenice, sapendo che si sta avvicinando il momento della sua morte, brucia insieme al suo nido, acceso dal calore del sole. Dalle sue ceneri nasce una nuova fenice (Van den Broek 1972, capitolo VI).
Il feng 鳳 cinese o feng huang 鳳凰 è stato chiamato fenice, ma non ha quasi nulla in comune con la sua controparte occidentale. Non crema da solo, e nessun nuovo uccello nasce dalle ceneri del vecchio. In tempi molto antichi, il feng era un uccello del vento, e il suo nome è legato alla parola cinese che significa “vento”, feng 風. In seguito è diventato un uccello di buon auspicio, successivamente identificato con il simbolico “uccello rosso” del sud. Infine, si è trasformato nell’uccello fantastico dell’arte e della decorazione (Edward Schafer, comunicazione personale; cfr. Sowerby 1940, 21, 101).
Nessuno di questi uccelli sembra strettamente connesso con il sanscrito śyena, l’avestico saēna o altri parenti indoeuropei. È possibile, tuttavia, che vi siano connessioni storiche con il culto sciamanico dell’aquila, piuttosto diffuso in Asia centrale e settentrionale. Presso diversi popoli siberiani, l’aquila è considerata il maestro del fuoco, che ha dato il fuoco all’uomo. L’aquila è anche la fondatrice della civiltà (er ist vorherrschend Kulturbringer: Findeisen 1956, 79). L’aquila è un uccello totemico, da cui traggono origine diverse tribù (ad esempio, gli Yakut). È considerata il primo sciamano dai Buriati e dagli Ostyak dello Yenisei. Solo chi discende da un’aquila può eseguire determinati rituali del fuoco. Idee simili si trovano nelle Americhe, ad esempio in Perù (Sternberg 1930, 192, 132-133, 142-143; Findeisen 1956, 74-80; Anisimov 1963, 191). Come totem, l’aquila è inviolabile. Uccidere un’aquila è un peccato capitale (Sternberg 1930, 132). Questo ricorda il voto (vrata) che deve essere osservato da ogni esecutore dell’agnicayana; la taittirīya saṃhita 5.7.6.1 afferma che: “Se colui che prepara il fuoco sacrificale (agnicit) mangiasse un uccello, mangerebbe fuoco e andrebbe in rovina. Dovrebbe osservare questo voto per un anno, perché nessun voto va oltre un anno”. śatapatha brāhmaṇa 10.1.4.13 è più clemente:
Dicono: “Colui che ha costruito l’altare di fuoco non deve mangiare alcun uccello, perché colui che costruisce l’altare di fuoco assume la forma di un uccello. Potrebbe ammalarsi. Perciò l’agnicit non deve mangiare alcun uccello”. Tuttavia, chi sa questo può mangiare tranquillamente. Perché chi costruisce un altare assume la forma di agni e tutto il cibo qui appartiene ad agni. Chi sa questo saprà che tutto il cibo gli appartiene.
È opportuno menzionare le prime imitazioni di uccelli, che hanno un aspetto tecnico e religioso. Non mi riferisco agli aeroplani, ma all’arte dell’aquilone. Si è spesso affermato che l’aquilone è stato inventato dal filosofo greco Archytas di Tarentum, ma si tratta di un vecchio errore (cfr. Chadwick 1931, 487, nota 4). Gli aquiloni sono stati probabilmente inventati in Cina. Sebbene possano esserci riferimenti precedenti, la prima menzione inequivocabile del volo degli aquiloni risale al II secolo a.C. In Cina, gli aquiloni erano usati per segnalare e per testare il comportamento dei venti (Needham 1959 III, 477; IV. 2, 576-579). In un primo momento, il volo degli aquiloni divenne uno sport. Spesso tabù per le donne, continua a essere praticato non solo dai bambini ma anche dagli adulti, ad esempio in Asia centrale: “Si dice che i negozianti di Yarkand amino far volare gli aquiloni mentre siedono fuori dai loro negozi” (Chadwick 1931, 483, dopo E. Breck). Il volo degli aquiloni è comune in Cina, Corea, Giappone, Sud-est asiatico, Melanesia e Polinesia. In Polinesia, le funzioni religiose dell’aquilone sono combinate con i suoi usi in meteorologia e navigazione. L’aquilone rappresenta l’anima dell’aquilonista. Gli aquiloni venivano mandati in cielo come rito religioso, con l’accompagnamento di canzoni di aquiloni. In Nuova Zelanda, i membri dell’importante famiglia Tawhaki sono descritti come se salissero al cielo a bordo di aquiloni. Rehua, dio del cielo più alto, è indicato come uccello sacro e antenato dell’aquilone. In tutto il Pacifico, gli uccelli sono considerati mezzi di comunicazione tra gli dei e gli uomini. Il volo degli aquiloni è una forma di religione che permette all’uomo di accedere al cielo (Chadwick 1931).
In India l’aquilonismo è ancora praticato da persone di tutte le età. La stagione inizia nella seconda metà di novembre e continua fino alla metà di gennaio. Mujumdar (1950, 71-77) cita molti tipi di aquiloni. In un contesto così vario e mondiale, non sorprende che l’altare di agnicayana sia stato costruito a forma di uccello rapace (śyena). Tuttavia, come vedremo (pag. 124), l’altare rappresenta un uomo cosmico e quindi ci si potrebbe aspettare che sia costruito in forma di uomo. Ne esistono tracce nelle descrizioni dell’altare che mescolano le caratteristiche di un uccello con quelle di un uomo (cfr. śatapatha brāhmaṇa 10.4.5.2; Van Buitenen 1962, 30; Dumont 1951). I dizionari forniscono una varietà di traduzioni per il sanscrito śyena e il relativo avestano saēna. Mayrhofer, ad esempio, elenca: “uccello da preda, aquila, falco, sparviero”. Nella maggior parte di questo libro ho mantenuto la traduzione “aquila” o “uccello da preda”. Sembra probabile che gli indiani vedici avessero in mente un uccello più specifico. L’unico studioso che ha dedicato una seria attenzione all’identificazione di śyena è Schneider (1971, 31-37). Basandosi sul ṛgveda, in particolare su 4.26-27 (vedi sotto, pp. 111-113), ritiene che l’uccello fosse caratterizzato in primo luogo dalla velocità, perché si avvicinava al soma in rapida discesa. Inoltre, conosceva la paura (4.26.5; cfr. 1.32.14) e probabilmente beveva il sangue della sua preda, poiché mordicchiava il gambo del soma e ne beveva il succo. Nel ṛgveda, inoltre, non viene mai definito forte o grande, e quindi non poteva essere né l’uno né l’altro (“Sicher kann man daraus den Schluss ex silentio ziehen”: pagina 33). Schneider ha concluso da queste osservazioni che śyena non poteva essere un “uccello miracoloso” (Wunder vogel) o un’aquila, ma era probabilmente un falco. Egli conclude la sua analisi con un riferimento alla falconeria, che molto probabilmente era conosciuta in India in un periodo molto precoce. Le espressioni iṣitaḥ “scaricato” (ṛgveda 9.77.2 e 10.11.4) e asarji (aoristo di √sṛj-) “lasciato andare, liberato, lasciato libero” (shot forth) (4.26.5) ricordano un falco lasciato libero.
Ritengo che queste osservazioni siano eccellenti, ma non è necessario che la conclusione sia conseguente, e altre prove puntano in un’altra direzione. Perché non ipotizzare che la forma dell’altare a forma di uccello dell’agnicayana preserva alcune caratteristiche della forma dell’uccello originale? Almeno fornisce un’immagine, il che è più di quanto si possa dire di qualsiasi testo. Considerato come una rappresentazione schematizzata di un uccello reale, il diagramma dell’altare (Figura 7, pagina 66) presenta tre caratteristiche: la coda è piccola, le ali sono grandi e le ali sono larghe sia alla punta che alla base.
Vediamo ora gli uccelli rapaci, o Falconiformi (se escludiamo i gufi). Questi comprendono poiane, aquile, falchi, albanelle, falchi e avvoltoi (Lloyd 1971, 4). Limitandoci alle ali e alle code, scopriamo che aquile e falchi hanno code lunghe e ali strette o affusolate, con punte strette. Le ali lunghe e dalla punta stretta consentono loro di volare molto velocemente in cerca di prede; le code lunghe permettono loro di virare rapidamente. Gli unici uccelli caratterizzati come gruppo da una coda corta e da ali lunghe, larghe e senza punta sono gli avvoltoi. Non possono virare rapidamente, ma “si librano facilmente e poi planano per grandi distanze con un battito d’ali molto ridotto” (Lloyd, 23). Il motivo è che possono volare per più di duecento miglia al giorno alla ricerca di animali morti e non hanno bisogno di inseguire prede in rapido movimento. Sono equipaggiati per voli a lunga distanza, non per inseguimenti a breve distanza.
Nel ṛgveda 4.26-27, il soma doveva essere catturato rapidamente, ma, essendo una pianta, non doveva essere inseguito rapidamente. Un avvoltoio è perfettamente attrezzato per questo compito. Possiede le proprietà elencate da Schneider, che sono in realtà comuni ai Falconiformi: velocità, capacità di incutere paura e di bere il sangue della preda. Infine, alcuni sono grandi e altri piccoli. Ma a differenza di Schneider, non credo che l’argumentum ex silentio dimostri nulla. Inoltre, la saēna iranica era sicuramente grande (Martin Schwartz, comunicazione personale).
Per restringere le possibilità, dobbiamo prendere in considerazione la geografia. Il Dipartimento di Ornitologia di Berkeley mi ha fornito un elenco di cinquantacinque specie di Falconiformi, che oggi vivono nell’India nordoccidentale o nell’Asia centrale o nelle sue vicinanze. Secondo Mercedes S. Foster e Steve Bailey, membri dello staff del Museo di Zoologia dei Vertebrati di Berkeley, è impossibile determinare con precisione le specie coinvolte a partire dal diagramma dell’altare di agnicayana della Figura 7. Tuttavia, ci sono sei specie che considerano le candidate più probabili:
Gyps bengalensis, Avvoltoio indiano dalla schiena bianca Gyps indicus, Grifone indiano Gyps himalayensis, Grifone dell’Himalaya Gyps fulvus, Grifone euroasiatico
Sarcogyps calvus, Avvoltoio calvo Aegypius monachus, Avvoltoio monaco
Sebbene si tratti solo di probabilità, è possibile ridurre ulteriormente questo elenco. La śyena ha portato il fuoco e il soma giù dal cielo, quindi ci si aspetta che si sposti per lunghe distanze e che viva ad altitudini elevate. Questi requisiti sono soddisfatti dai grifoni, che sono “grandi avvoltoi che vivono in colonie in zone montuose”. Tra i quattro grifoni presenti nell’elenco, il fulvus è presente dalla Spagna all’India settentrionale, mentre il bengalensis e l’indicus vivono soprattutto in India, Birmania e Malesia. La specie visivamente più interessante è l’himalayensis. È originario dell’Asia ed è il secondo rapace più grande del Vecchio Mondo. Come altri grandi avvoltoi, la sua vita può arrivare a sessant’anni. Questi uccelli superano di gran lunga i nomadi umani per quanto riguarda le distanze che percorrono per migrare. Molti rapaci migrano ogni anno dall’Asia settentrionale all’India e al Sud-Est asiatico. Attraversano l’Himalaya in autunno e ritornano in primavera (Lloyd 1971, 8, 18, 87-88).
Il grifone dell’Himalaya è “un enorme uccello bianco-marrone con un’apertura alare di circa nove piedi” (Lloyd 1971, 22, 87). Vedere un simile uccello volare nei cieli dell’Himalaya deve essere uno spettacolo impressionante. È probabile che gli Harappan l’abbiano visto e che il loro segno , con le ali larghe e la coda corta, si riferisca ad esso (cfr. Parpola, c.s., 1970, 29). È ancora più probabile che l’abbiano visto i nomadi vedici, quando hanno attraversato l’Himalaya occidentale. In attesa di prove migliori, sarei propenso a credere che la śyena vedica fosse originariamente il Gyps himalayensis.
LA SCOPERTA CHE molte delle lingue indiane (tra cui il vedico e il sanscrito) sono imparentate con la maggior parte delle lingue europee (tra cui il greco, il latino e i suoi derivati romanzi, il germanico e lo slavo) ha portato alla creazione di una famiglia di lingue, la famiglia indoeuropea. Le lingue di questo gruppo si sono diffuse più di quelle di qualsiasi altra famiglia linguistica. Prima del 2.000 a.C., le lingue indoeuropee erano parlate da popolazioni seminomadi che vagavano nelle steppe che si estendono dalla Polonia all’Asia centrale. Questi nomadi avevano addomesticato il cavallo, che utilizzavano per trasportare carri leggeri con ruote a raggi. Intorno alla fine del terzo millennio, cominciarono a spostarsi verso ovest, sud e est, entrando nelle zone dell’Asia e dell’Europa più vicine ai delta dei fiumi e agli oceani. Alcune di queste aree, in particolare il Medio Oriente, erano abitate da popolazioni sedentarie che avevano sviluppato un livello di civiltà molto più avanzato. Le lingue indoeuropee si affermarono e fiorirono in Europa, Iran e India. Una lingua indoeuropea, il tochariano, si conservò nel Turkestan cinese fino all’ottavo secolo d.C., quando fu definitivamente sostituita dalle lingue turche. (Vedi mappa A)
Userò il termine “nomadi vedici” per riferirmi a persone che parlavano una lingua indoeuropea, che provenivano dall’Asia interna e che entrarono nel subcontinente indiano intorno al 1.500 a.C. Non abbiamo prove materiali inequivocabili che tale invasione sia effettivamente avvenuta, e potrebbe esserci stata più di un’ondata. Ma la lingua vedica del ṛgveda, nata intorno al 1.200 a.C. nel nord-ovest del subcontinente indiano (forse fino all’attuale Afghanistan), è chiaramente indoeuropea e questo fatto costituisce di per sé una prova sufficiente dell’esistenza di questa migrazione. Sebbene il vedico sia imparentato con le altre lingue della famiglia europea, è particolarmente vicino all’avestano, parlato nell’Iran orientale nel periodo tra il 1.000 e il 500 a.C., e all’antico persiano, la lingua delle iscrizioni cuneiformi dei re achemenidi (ca. 500-330 a.C.). A parte questi fatti linguistici, sappiamo poco dell’antropologia e dell’identità dei popoli che parlavano il vedico. Non sappiamo esattamente da dove provenissero, né se arrivassero in gruppi poco collegati tra loro durante un periodo relativamente breve, o separatamente e ripetutamente durante periodi diversi.
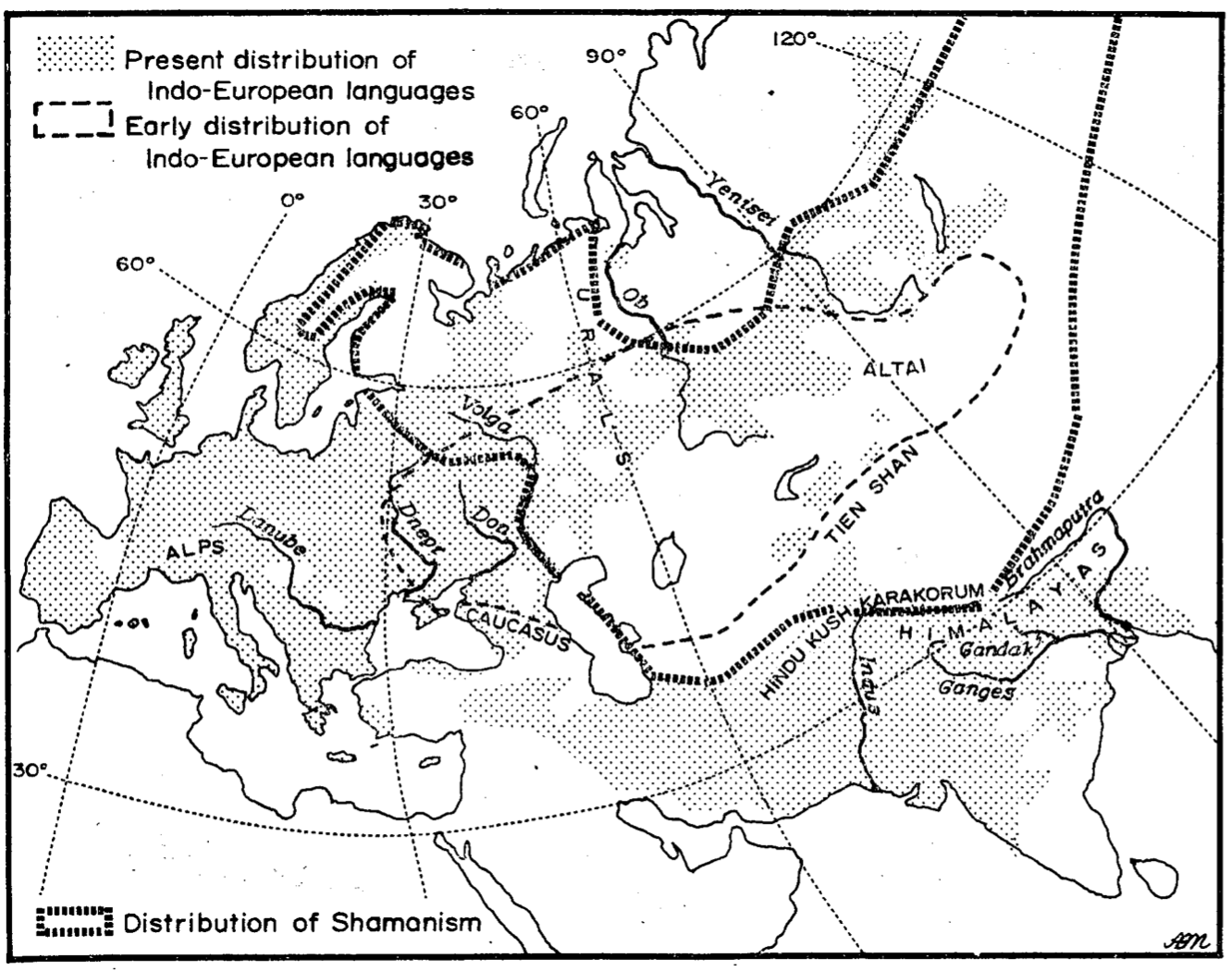
Le correlazioni tra dati linguistici e archeologici cominciano solo ora a essere tracciate (si vedano Parpola e Thapar nelle sezioni iniziali della Parte III).
La cultura del ṛgveda condivide caratteristiche con altre culture indoeuropee, ma possiede anche caratteristiche in comune solo con gli iraniani e altre caratteristiche che non si trovano altrove nella famiglia indoeuropea. È consuetudine riferirsi a queste ultime caratteristiche come “indiane”, e non c’è nulla di male nel farlo, purché non si evochino associazioni sbagliate (come spesso accade). La visione di ari alti, biondi e con gli occhi azzurri, che importano la loro cultura in un’area arretrata abitata da indigeni scuri e con il naso all’insù, com’è stata per alcuni studiosi occidentali, è stata ampiamente ribaltata. Oggi sappiamo, soprattutto dopo gli scavi di Harappa, Mohenjo-daro e di numerosi altri siti, che molto prima del 1.500 a.C. nella parte nord-occidentale del subcontinente fioriva una cultura cittadina molto evoluta, come in Medio Oriente. Sebbene le città e i villaggi più grandi di questa civiltà dell’Indo possano essere scomparsi prima dell’avvento dei nomadi vedici - probabilmente a causa di calamità naturali - è quindi più corretto dire che gli indoeuropei, pur importando la loro lingua, incontrarono i resti di una civiltà per molti aspetti superiore alla loro.
Che i nomadi semibarbarici abbiano importato la loro lingua non è sorprendente, ma l’impatto di questa importazione è a dir poco stupefacente. Mentre il vedico fu parlato solo nel nord-ovest per alcuni secoli, il sanscrito fu adottato in tutto il subcontinente. Codificato dal grammatico Pāṇini intorno al 500 a.C., si affermò come lingua della civiltà per i successivi 2.500 anni. Le lingue che successivamente sono sorte nell’India settentrionale (pracriti medio-indiani e i moderni hindi, panjabi, gujarati, marathi, bengalesi, oriya, ecc.) sono tutte indoeropee Non è facile spiegare questo straordinario sviluppo. Senza dubbio, gli invasori nomadi erano ottimi combattenti. La forza della civiltà dell’Indo era già stata spezzata e “le città pacifiche e conservatrici della Valle dell’Indo non potevano né resistere né assorbire gli invasori” (Basham 1954, 29). È altrettanto rilevante considerare che i nomadi vedici, nonostante il livello relativamente basso della loro cultura materiale, possedevano tecniche poetiche molto avanzate e avevano una straordinaria devozione per la lingua e il potere della lingua, che chiamavano brahman. La loro superiorità era accettata almeno in parte perché si riteneva che avessero un’influenza sugli dèi, a sua volta attribuita al potere dei loro mantra vedici. Questa credenza nella lingua si ritrova anche tra gli altri popoli che parlano una lingua indoeuropea. In realtà, tutte le civiltà superiori dell’umanità sono caratterizzate da una fede esagerata nel potere del linguaggio. Nella cultura vedica, questa fede sembra non avere limiti. È possibile che il culto del linguaggio provenga dall’Asia centrale. Il potere magico delle canzoni è ancora molto pronunciato nello sciamanesimo (si veda, ad esempio, Eliade 1964, 201). Qualunque sia la sua origine, gli sviluppi successivi hanno rafforzato la convinzione delle qualità soprannaturali del vedico e del sanscrito e della loro superiorità rispetto ad altre lingue. Questa convinzione è rimasta nell’Induismo, che è pervaso dalla credenza nell’efficacia dei mantra, spesso presunti vedici. Questa convinzione ha avuto un ruolo nella diffusione dell’induismo in tutto il subcontinente indiano. Questo è stato notato non solo dagli studiosi, già professionalmente ossessionati dalla lingua, ma anche dai funzionari pubblici britannici. Logan, Collettore di Malabar, ad esempio, nel suo Malabar Manual del 1887 ipotizzò l’avvento dei bramini Nambudiri nei seguenti termini:
Si presentavano ai rudi capi tribù con cui entravano in contatto come “venditori di Dio”. I loro mantram e incantesimi sonori potevano costringere gli dèi a portare direttamente in cielo i fantasmi erranti anche degli uomini peggiori (citato in Padmanabha Menon 1924, I, 51-52).
Gli stretti legami tra gli indiani vedici e i loro contemporanei in Iran giustificano la creazione di un sottogruppo indoiranico all’interno dell’indoeuropeo. L’esistenza di questo gruppo è dimostrata principalmente dalle strette somiglianze linguistiche (nella fonologia, nella sintassi, nel vocabolario e nello stile) tra il vedico, il sanscrito, l’avestico, l’antico persiano e diverse lingue successive, senza che vi siano controparti in altre lingue indoeuropee. L’esistenza dell’indo-iranico si basa anche su caratteristiche comuni di religione e civiltà. Nell’ambito del vocabolario, ad esempio, l’avestano airya, haoma e zaota corrisponde al vedico ārya, soma e hotā. Al di là della corrispondenza delle parole, troviamo che gli iraniani si definiscono airya, “di nobile nascita” (da cui deriva “Iran”), allo stesso modo in cui gli indiani vedici si definiscono ārya (da cui “ariani”). La credenza e il culto degli haoma nell’Avesta sono per molti aspetti simili ai corrispondenti concetti e rituali vedici. Lo zaota è il sacerdote principale del rito haoma. Sebbene l’hotā, nel rituale śrauta classico, si occupi quasi esclusivamente della recitazione e non dell’esecuzione di atti rituali, che sono di competenza dell’adhvaryu, ciò potrebbe essere stato diverso in origine. Il termine hotā deriva dal verbo hu-, “fare un’oblazione”, e non da hū-, “invocare” (Renou 1947, 8-9; 1958, 59-60; cfr. Minard 1949, 123, n. 346a). Lo stesso vale per zaota. È possibile che, in una fase iniziale dello sviluppo del rituale del fuoco, l’hotā facesse l’oblazione nel fuoco che agni trasmetteva agli dèi. In una fase successiva dello sviluppo, agni divenne il messaggero che portava gli dèi sulla terra. L’hotā fungeva quindi da invocatore (Schneider 1971, 73).
Il rituale del fuoco iraniano è per molti aspetti simile a quello vedico. I fuochi sono installati su tre altari. L’altare domestico è circolare, quello delle offerte è quadrato. Da parte iranica sembra esserci una prova migliore rispetto ai veda per l’opinione di Dumézil secondo cui i tre fuochi sono collegati alle tre principali suddivisioni della società: i contadini sono rappresentati dal fuoco domestico, i sacerdoti dal fuoco delle offerte e i soldati dal terzo, che allontana le influenze maligne. Questa affermazione non ci sorprende, perché Dumézil spesso esagera (per una critica recente, si veda Gonda 1974). In Iran si trasportavano anche i fuochi. Ad esempio, davanti all’esercito dell’ultimo Dario, nel 331 a.C., furono trasportate le braci di un fuoco di Vərəthragna (Boyce 1975, 459; Vərəthragna corrisponde al vedico vṛtrahan, “uccisore del demone vṛtra”, cioè indra).
Alcune di queste strutture non sono solo Indo-Iraniane, ma anche Indo-europee. I Romani avevano un altare domestico circolare per Vesta (aedes rotunda), e anche templa quadrata. In latino, focus o foculus (a differenza di āra) si riferisce a un focolare facoltativamente mobile. In umbro, la parola per “focolare mobile” è ahti (Nagy 1974, 89-92).
In Iran, molte caratteristiche del culto del fuoco sono sopravvissute in tempi successivi, il che è in gran parte dovuto al fatto che Zarathustra (intorno al 600 a.C.?) le ha mantenute e sviluppate. Ciò contrasta in qualche misura con lo sviluppo indiano, poiché i resti del culto vedico del fuoco sono confinati nelle case degli bramini āhitāgni, in un relativo isolamento dallo sviluppo dell’induismo. Anche al di fuori della tradizione brahminica, tuttavia, le oblazioni al fuoco (homa) sono rimaste comuni in India. In Iran si tende a identificare ogni tempio pre-islamico come un tempio del fuoco. In realtà, i templi del fuoco non sembrano essere anteriori al IV secolo a.C. e potrebbero essere stati costruiti come reazione al culto templare di altre divinità rappresentate da icone (Boyce 1975). Solo molto più tardi, nel periodo sassanide (226-650 d.C.), i templi del fuoco divennero i principali centri religiosi. Erano quadrati, con un tetto a forma di cupola e realizzati in pietra. C’erano anche altari mobili. Il re portava con sé il suo fuoco personale su un altare di questo tipo quando partiva per una campagna (Widen gren 1965, 273).
Durante lo sviluppo del culto del fuoco in Iran, il fuoco è stato chiamato ātur. L‘āgnīdhra, sacerdote accenditore del rituale vedico, ha come controparte iranica il sacerdote ātravaxš. Il termine agni può essere presente in iranico antico nel nome personale Ag-nu-par-nu (trovato in una lettera indirizzata ad Assurbanipal tra il 650 e il 640 a.C.), e ancora una volta in avestano dāštayni, di significato incerto e quindi incerto come testimonianza (Wikander 1946, 35, 102-103).
I rituali del fuoco iranici e vedici riflettono il carattere nomade degli indo-iraniani. A differenza dei templi del successivo Induismo e della precedente civiltà dell’Indo (Wheeler 1968, 52-53; cfr. Parpola, c.s., 1969, 5), nel rituale vedico non ci sono templi. I riti vedici si svolgono all’interno di strutture temporanee, costruite e consacrate all’inizio del rituale e bruciate al suo termine. Gli strumenti rituali sono fatti di materiali deperibili come legno e argilla. Anche questi strumenti vengono poi bruciati o immersi nell’acqua. Caland ha osservato che “il rituale era spesso assimilato metaforicamente a una marcia, a un viaggio, a una spedizione, e comportava di fatto un gran numero di movimenti simili a una processione” (Caland e Henry 1906, 450; citato da Wasson 1972, 14, che lo paragona a un “viaggio”). Anche il nome del sacerdote capo del rituale, l’adhvaryu, ricorda questo background nomade: è legato ad adhvan, “via, strada, percorso”. La parola correlata adhvara, “rituale”, potrebbe originariamente significare “viaggio cerimoniale” (Mayrhofer: feierlicher Gang). Queste sopravvivenze della via nomade in India sono parallele alla via del taoismo in Cina, che analogamente incorpora resti della cultura nomade dell’Asia interna (cfr. Staal 1975, 204).
Come gli invasori nomadi dell’Europa e del Vicino Oriente, i nomadi vedici importarono i loro cavalli e carri, nonché strumenti e armi superiori a quelli usati nelle civiltà sedentarie che incontrarono. Sia che abbiano trasportato il fuoco attraverso le montagne dell’Hindukush e dell’Himalaya occidentale è una questione aperta alla quale l’archeologia deve ancora dare una risposta. Basham (1954, 27) ha osservato che:
A Chanhu Daro, sul basso corso dell’Indo, gli Harappā erano sostituiti da abusivi, che vivevano in piccole capanne con focolari, un’innovazione che suggerisce che provenissero da un clima più freddo.
Mentre è noto il debito dei nomadi vedici nei confronti della cultura dei loro antenati indoeuropei, i loro legami con le tendenze culturali dell’Asia centrale rimangono relativamente inesplorati. Per quanto riguarda la lingua, esistono prove di un contatto tra indoeuropeo e ugro-finnico, ma la sua interpretazione è controversa. In tempi successivi, l’ugro-finnico ha preso in prestito un numero considerevole di parole dall’indo-iranico (Burrow 1973, 24). Come mostra la mappa A, l’attuale distribuzione dello sciamanesimo (secondo Findeisen 1957) copre gran parte della stessa area in cui un tempo si parlavano le lingue indoeuropee. Non sorprende trovare legami tra lo sciamanesimo e la cultura dei nomadi vedici. Nel campo della religione, diverse caratteristiche del rituale vedico sono state caratterizzate come sciamaniche. Eliade (1964, 403 ss.) ha evidenziato le somiglianze in quelli che ha definito “riti ascensionali”. Per raggiungere il cielo e gli dèi, lo yajamāna sale su una scala appoggiata allo yūpa, o palo sacrificale ricavato da un albero. Quando raggiunge la cima della scala, allarga le braccia come un uccello apre le ali. Anche gli sciamani siberiani si arrampicano sugli alberi e inviano i sacrifici facendo passare un albero o un palo attraverso il foro a raggiera delle loro capanne. Sono anche paragonati agli uccelli, in particolare alle aquile. In entrambi i casi, il palo rappresenta l’axis mundi. Sebbene Eliade consideri questi riti come caratteristici del rituale vedico in generale, essi si verificano solo nel rituale vājapeya (e si possono vedere nel filmato di van Buitenen della sua rappresentazione del 1955), il che non diminuisce comunque il significato del parellelismo. Il volo estatico ricorre, inoltre, nel ṛgveda 10.136 (cfr. Staal 1975, 197-198, 204-208), che ha altre sfumature sciamaniche.
Oltre all’importanza dell’uccello da preda per la cultura sciamanica e vedica, gli sciamani eseguivano anche un sacrificio di cavalli che potrebbe essere collegato all’aśvamedha o sacrificio vedico del cavallo (Eliade 1964, 199). Infine, esiste un’analogia nella funzione di alcuni sciamani e di uno dei sacerdoti vedici. Lo sciamano ugriano partecipa ai sacrifici solo indirettamente: “Si limita a pregare e a guidare le anime delle vittime verso le rispettive divinità. . . . Anche quando partecipa ai sacrifici, lo sciamano svolge più che altro un ruolo ‘spirituale’.” (Eliade 183). Questo ricorda, come ha osservato Eliade, il ruolo del sacerdote brahmano nei rituali vedici (vedi sopra, pagina 46).
Le analogie tra sciamanesimo e buddismo sono più evidenti. Le affronterò nella prossima sezione. La stessa parola sciamano è stata fatta derivare da un derivato prakrit del sanscrito śramaṇa, un termine che indica asceti e monaci (non vedici), in particolare monaci buddisti. Questa etimologia rimane controversa. Esistono anche somiglianze tra lo sciamanesimo e lo yoga (si veda, ad esempio, Ruben 1940; cfr. anche Nolle 1953). Sembra probabile che molte di queste somiglianze possano essere spiegate in termini storici. Tuttavia, per il momento, mancano dettagli sulle connessioni storiche perché la maggior parte dei dati sullo sciamanesimo sono relativamente recenti.
Torniamo ai nomadi vedici e alle loro avventure in Asia meridionale. Sul suolo indiano, gli invasori proseguirono la loro rotta in direzione est. Durante l’ultimo periodo vedico, la migrazione predominante è quella da ovest verso est: “Da ovest si va verso est, conquistando terre” (kāṭhaka saṃhitā. 26.2, citato in Rau 1957, 13). Questo spostamento verso est rimase confinato alle pianure a nord del Gange, che fu attraversato solo molto più tardi. Oggi solo la riva sinistra del Gange è considerata pura e sacra. Ogni visitatore di Varanasi (Banaras) ricorderà che di fronte alla città, sulla sponda opposta del fiume, c’è una landa desolata e disabitata. Non tutti i turisti sanno che, al mattino presto, gli ortodossi attraversano il fiume su piccole barche per svuotare le loro viscere su questo lato infausto. Così un gigantesco bagno pubblico ricorda le terre non arianizzate del passato.
Il fatto che il movimento verso sud sia iniziato solo molto più tardi è coerente con la generale infaustività del sud, citata in molte fonti vediche. Il sud è la regione della morte e degli antenati. La testa di un cadavere dovrebbe generalmente essere rivolta verso sud (Caland 1896, 16, 39). nirṛti, dea della catastrofe, è propiziata a sud della Old Hall (sotto, pagina 343). L’offerta havis non può essere spostata a sud (taittirīya brāhmaṇa 2.1.3.4, citato in Mylius 1972, 370). Questo orientamento rimane una caratteristica dell’induismo e sopravvive fino ai giorni nostri. śiva come precettore divino (dakṣiṇāmūrti) è rivolto a sud perché gli insegnamenti tradizionali provengono da nord (Staal 1975, 145). In alcuni templi non bramini dell’India meridionale, le divinità e i riti vegetariani, che provengono dal nord, si trovano sul lato settentrionale, mentre le divinità e i riti non vegetariani si trovano sul lato meridionale (Dumont 1953, 264).
Muoversi verso est e poi verso sud significa anche muoversi con il sole. Si ritiene che questo porti alla vittoria e a tutto ciò che è di buon auspicio. Si riflette nella circumambulazione in senso orario (pradakṣiṇa) di un’area o di un oggetto sacro, che viene tenuto alla destra (dakṣiṇa) del viandante. Il termine pradakṣiṇa compare per la prima volta nella letteratura dei sūtra e rimane il movimento di buon auspicio predominante della religione indiana, indù, buddista e jaina (in contraddizione con la religione tibetana Bön, dove la circumambulazione di buon auspicio è in senso antiorario). Questo movimento in senso orario si è diffuso in tutta l’Asia e si ritrova anche altrove (si veda, ad esempio, Seidenberg forth coming).
Idealmente, l’uomo è rivolto verso est. Per questo il sanscrito dakṣiṇa, “sud”, significa anche “destra”; uttara, “nord”, significa anche “sinistra”; e pratyañc, “ovest”, significa anche “dietro”. Ruben (1939, 288) ha richiamato l’attenzione sui paralleli dell’Asia centrale. Secondo Thomsen (1924, 134), tra i popoli turchi la direzione principale è l’est. Perciò l’est è chiamato “davanti”; l’ovest “dietro”; il sud “destra” e il nord “sinistra”. Questa testimonianza di scritture turche su pietra, rinvenute in Mongolia, è relativamente tardiva (VIII secolo d.C.), ed è possibile che sia un prestito dagli indo-iraniani, come altri prestiti lessicali (cfr. ad es. Burrow 1973, 24). Che la sua origine sia turca o indo-iranica, i nomadi vedici devono aver trovato questo orientamento in accordo con la direzione delle loro migrazioni nel subcontinente indiano.
Le marce verso est dei nomadi vedici erano accompagnate da battaglie, razzie di bestiame e incendi di foreste. Secondo Kosambi, non sarebbe stato possibile disboscare la terra vicino al Gange bruciandola; la giungla rivierasca era ancora troppo fitta per un insediamento agricolo. “I principali insediamenti ari si estesero quindi verso est in una catena, una linea sottile lungo le pendici dell’Himalaya fino al Nepal meridionale”. L’espansione originaria era limitata alle colline pedemontane a ovest del fiume Gandak (Kosambi 1972, 90).
Nella pianura settentrionale del Gange, i fiumi scorrono approssimativamente da nord a sud. Questo interruppe l’incendio delle foreste da parte di agni. Questi eventi sono citati in un famoso passo del śatapatha brāhmaṇa (1.4.1.14-17), in cui il sadānīrā è probabilmente lo stesso del moderno fiume Gandak:
- Videgha Māthava si trovava a quel tempo sul fiume sarasvatī. Da lì, egli (agni) bruciò lungo questa terra, verso est. Gotama Rāhūgaṇa e Videgha Māthava lo seguirono mentre bruciava. Bruciò tutti questi fiumi. Il sadānīrā, che scorre dalla montagna settentrionale, non lo bruciò mai. Anticamente i bramini non lo attraversavano mai, pensando: “Non è stato bruciato da agni vaiśvānara”.
- Ma ora ci sono molti bramini a est di essa. Allora la terra era selvaggia e paludosa, non assaggiata da agni vaiśvānara.
- Ora è coltivata, perché i bramini hanno fatto in modo che agni la assaggiasse attraverso i rituali. Ma anche alla fine dell’estate, il fiume quasi infuria, tanto è freddo, mai bruciato da agni vaiśvānara.
- Videgha Māthava allora disse (ad agni): “Dove devo vivere?”. “La tua casa è a est”, rispose. Ancora oggi questo fiume è il confine tra i Kosala e i Videgha, che sono i discendenti di Māthava.
Weber, che è stato il primo a richiamare l’attenzione su questo passaggio (1850, 170-172), ha anche sostenuto che Śāṇḍilya, autore dell’agnirahasya, “Segreto dell’altare di fuoco” (śatapatha brāhmaṇa libro, X), apparteneva al nord-ovest. Una ragione da lui addotta è che i libri VI-X si riferiscono solo ai popoli del nord-ovest. Mylius (1972, 373) lo ha confermato richiamando l’attenzione sul śatapatha brāhmaṇa 9.1.2.26, che descrive il clima come “gelido” (praśīta), una condizione più facilmente applicabile al Panjab che a quello che oggi è chiamato Uttar Pradesh. Secondo Weber, la preoccupazione per un culto del fuoco è anche più comprensibile nel nord-ovest, a causa della relativa vicinanza degli iraniani. A sostegno di questa tesi ha fatto riferimento a un termine per misura di lunghe, vitasti, che si trova nell’Avesta e nel libro X del śatapatha brāhmaṇa (Weber 1873, 266-267). Questo punto di vista potrebbe necessitare di una modifica a causa degli scavi successivi. Il nord-ovest era anche il punto di forza della civiltà dell’Indo ed è molto probabile che vi fosse un culto indigeno del fuoco. I libri da VI a X del śatapatha brāhmaṇa sono più tardivi degli altri (come dimostrato da Minard 1936, 96, 104, che estende le precedenti indagini di Brunnhofer). Sembra probabile che questa interpretazione dell’agnicayana, composto nel nord-ovest, fosse una risposta a un culto del fuoco in digeno, con il quale era in parte integrato. Troveremo prove dettagliate a sostegno di questa tesi (sotto le pagine 154-162). C’è un’altra caratteristica degli abitanti del nord-ovest su cui Weber ha richiamato l’attenzione. Quando le tribù nomadi si spinsero più a est, il sistema delle caste iniziò a diventare più ramificato. In seguito, i nordoccidentali vennero guardati con disprezzo proprio perché non possedevano le caratteristiche di un sistema di caste sofisticato (Weber 1850, 220).
Non bisogna visualizzare questi movimenti esclusivamente in termini di invasione su larga scala. Ci furono frequenti incursioni, che si riflettono nei rituali, come ha dimostrato Heesterman. I riti delle “offerte di aggiogamento” (prayujāṃ havīṃṣi), ad esempio, si riferiscono al popolo kuru-pañcāla, noto per il suo zelo ritualistico. Essi marciavano verso est durante la stagione fredda, coglievano il raccolto di orzo, nutrivano uomini e animali e tornavano prima delle piogge (cfr. Rau 1957, 15; Heesterman 1957, 211; 1962, 15). Si può notare che non c’è motivo di supporre che il clima fosse molto diverso da quello attuale (cfr. Raikes e Dyson 1962 per la regione occidentale; Mylius 1972, 373-374 per la pianura superiore e media del Gange).
Spedizioni simili si riflettono negli yātsattra, rituali di soma che richiedono ai partecipanti di spostarsi ogni giorno di un tiro di śamyā (il śamyā è un piolo di legno, usato per fissare un giogo). Così gli invasori si spostarono lungo i fiumi sarasvatī e dṛṣadvatī, compiendo ogni volta un rituale (Heesterman 1962, 34-35). Si muovevano in direzione nord-est (jaiminīya brāhmaṇa 2.297) e quindi a monte (pañcaviṃśa brāhmaṇa 25.10.12), poiché il sarasvatī scorre a sud-ovest. I capanni havirdhāna e sadas venivano spostati su ruote. Poiché il termine havirdhāna si riferisce in primo luogo al carro di soma e in secondo luogo al capanno in cui sono installati due carri di soma (in seguito chiamato più esplicitamente: havirdhāna-maṇḍapa), ciò suggerisce che durante queste esecuzioni il soma veniva generalmente trasportato su un carro. Il carro di soma del rituale non è un carro con ruote a raggi, ma ha ruote piene (vedi Foto 3). Pur conoscendo le ruote a raggi, i nomadi vedici adottarono il miglior mezzo di trasporto della cività dell’Indo, contemporanea ai Sumeri: un carro a ruote piene. Tutti i nomadi compiono razzie, soprattutto di bestiame. Ci sono prove di razzie di bestiame nel neolitico nell’India meridionale e il furto di bestiame è rimasto uno dei grandi temi della prima letteratura tamil (Allchin 1963, 172).

Il carro di soma Il soma viene trasportato su un carro dopo essere stato acquistato e prima di essere installato su un trono e venerato come Re soma. Sebbene i nomadi vedici conoscessero carri con ruote a raggi, il carro di soma ha ruote solide.
Che i nomadi vedici si dedicavano a tali incursioni non è sorprendente. Ciò che è interessante è che queste incursioni, come il movimento verso est di agni, si riflettevano e si conservavano nel rituale vedico.
Un passo del jaiminīya brāhmaṇa (2.299) mostra che i nomadi non erano sempre vittoriosi: durante uno yātsattra, il capo fu ucciso dalle cacciatrici (vyādhinī) dei Trikarta o dei Salva (tribù che vivevano nella regione intorno all’attuale Lucknow). Quando i membri della spedizione si persero d’animo, uno dei sacerdoti li ammonì: “Coloro che sono stati uccisi sono andati in paradiso (perché si trattava di un sacrificio), e quelli che sopravvissero sono ora i più degni di lode, perché all’inizio erano tutti dei miserabili”. Come in altri tempi e in altre terre, la religione era a portata di mano laddove gli obiettivi mondani fallivano. L’incendio delle foreste crea pascoli e apre la strada all’agricoltura. I Veda pullulano di bestiame e menzionano spesso l’agricoltura (kṛṣi; per i dettagli, si veda Rau 1957, 25-26). Anche il rituale abbonda di riferimenti al bestiame: esso costituisce la miglior dakṣiṇā e ci si aspetta che i mattoni dell’altare del fuoco si trasformino in mucche. L’agricoltura si riflette in numerosi riti, ad esempio quelli che prevedono l’uso dell’aratro (sīra). Il campo per agni viene arato prima della costruzione dell’altare. I riti di aratura sono ricchi di simbolismi legati all’agricoltura, alla fertilità e alla sessualità (cfr. Dange 1970, 73-74; 1971, cap. V, che tratta di ṛgveda 10.101). Così come il fuoco può essere installato dopo la fine dell’aratura, ci sono molte feste in cui viene fatto un falò dopo l’aratura (per l’India meridionale, si veda Allchin 1963, 133-135). Poiché l’abbruciamento delle foreste porta a nuovi pascoli e all’agricoltura, le feste del fuoco sono generalmente collegate al bestiame e alla fertilità (per l’Europa e l’Iran, cfr. Allchin 1963, 136-142; per la Grecia, Nilsson 1923). In tutto il rituale troviamo espressioni del desiderio di spazio e della preoccupazione per il l’habitat (lebensraum). Nei rituali di soma, quando agni e soma vengono trasportati in direzione est verso il nuovo altare dell’offerta, l’adhvaryu recita: “Questo agni deve creare spazio per me, deve andare davanti distruggendo i nemici; arroventato deve conquistare i nemici, alla conquista del bottino deve conquistare il bottino” (taittirīya saṃhitā 1.3.4.1 c, citato da Heesterman 1962, 35). Durante questo trasporto del fuoco (agnipraṇayana) vengono invocate anche altre divinità. Quando l’adhvaryu arriva al fuoco dell’offerta, offre un cucchiaio di burro chiarificato e recita: “viṣṇu, fai un ampio passo. Fai ampio spazio per noi per vivere” (taittirīya saṃhitā 1.3.4.1 d). Lo stesso mantra viene recitato durante il sacrificio animale, quando viene fatta un’offerta per il palo sacrificale. Il sacrificio animale stesso è caratterizzato nei seguenti termini: “Coloro che compiono il sacrificio animale, conquistano tutti i mondi” (āpastamba śrauta sūtra 7.1.1.). I termini “vasto” (uru) e “mondo” (loka) sono spesso combinati, dal ṛgveda in poi. L’espressione uruṃ lokaṃ kr- significa: “fare ampio spazio, stanza” (Gonda 1966, 23). Il termine loka è indoeuropeo e l’originale ricostruito *louko indica uno “spazio più o meno aperto a cui ha accesso la luce del giorno” (Gonda 1966, 9). In latino, una simile radura era chiamata lucus, che in seguito significò “boschetto”. I Romani e gli Umbri ponevano il fuoco in tale boschetto (Nagy 1974, 91). Questi termini sono legati al latino lux, all’inglese “light”, ecc. Secondo Gonda, un significato intermedio potrebbe essere il vedico roka, che significa “luce, lucentezza, luminosità” ed è anche un attributo di agni. Possiamo fare un passo avanti e supporre che sia agni il responsabile di queste radure nella foresta? Gonda fa riferimento, in una nota a piè di pagina, alla creazione di radure nella foresta mediante l’incendio, ma questo va presumibilmente letto insieme al solenne avvertimento che aveva lanciato qualche pagina prima:
A questo punto ci si chiede fino a che punto l’importanza del concetto vedico di loka possa essere vista come un’universalizzazione di situazioni sociali, economiche, politiche e psicologiche concrete in cui o pacifiche popolazioni pastorali e di allevatori di bestiame sono state minacciate dalle incursioni di tribù nomadi e private dei loro luoghi di residenza, o i nomadi non sono riusciti a trovare nelle giungle, nelle foreste e nelle montagne infinite un Lebensraum (habitat) sufficiente per il loro numero crescente. Sebbene si possa facilmente ammettere che l’incessante lotta per i mezzi di sussistenza, e in particolare per una sufficiente disponibilità di campi e pascoli, non può non lasciare un’impronta sulla visione della vita di una comunità, bisogna guardarsi da qualsiasi esagerazione.
Finora molto di ciò che ho detto è riassunto nelle parole del ṛgveda (1.93.6): “agni e soma! Rafforzato da brahman, avete fatto ampio spazio al rito”. Geldner commenta questo passo dicendo che riflette la diffusione del culto aryo (das heisst sie haben den arischen Kult ausgebreitet). Parole simili sono rivolte a indra e a viṣṇu (ṛgveda 7.99.4). Gonda interpreta questi passaggi in senso più ampio, sottolineando l’implicazione generale che il rituale debba avere successo (Gonda 1966, 21). Questo è senza dubbio il senso che hanno acquisito nel contesto del rituale, che non sarebbe potuto sopravvivere se fosse stato solo una celebrazione di battaglie e raid. Ciò a cui assistiamo qui, tuttavia, è una transizione significativa che è caratteristica del rituale in generale. Abbiamo incontrato questa transizione per la prima volta in questo libro, quando abbiamo osservato che il trasporto del fuoco diventava rituale quando non era più funzionale, perché l’arte di fare il fuoco era stata eliminata. Allo stesso modo, c’è stato sicuramente un tempo in cui i nomadi vedici facevano spedizioni accompagnate da battaglie, razzie di bestiame, incendi di foreste, canti e recitazioni, trasporto rituale del fuoco e celebrazioni rituali del soma. Ma quando i nomadi cominciarono a stabilirsi nel subcontinente e a stabilire relazioni durature con gli abitanti indigeni, le spedizioni passarono in secondo piano e le attività che le accompagnavano persero la loro funzione di accompagnamento. Quando anche il soma divenne sempre più raro (cfr. sezione successiva), il carattere rituale di tutte queste attività divenne predominate, e il successo del rituale stesso divenne la preoccupazione principale dei partecipanti. Così il rituale era l’unico sopravvissuto e tutte le altre attività erano ritualizzate.
I rituali tendono ad assorbire tutto ciò che è stato fatto in precedenza e hanno perso la loro funzione originale. Anche le divinità precedenti vengono incorporate. Il termine uru, “ampio”, è spesso associato alle attività onnipervadenti di viṣṇu (Gonda 1954, 68-71). viṣṇu è stato anche collegato con un geometra e i suoi tre passi possono essere letti in un’iscrizione harappica (Parpola 1976, 147-148). Nel ṛgveda, viṣṇu è descritto mentre compie tre passi, il che potrebbe indicare che in origine era un terzo indipendente (independent third ) e l’anello di congiunzione tra dei e demoni e tra cielo e terra (Kuiper 1962). Sebbene abbia perso questa funzione, i tre passi sono sopravvissuti nel rituale, dove lo yajamāna compie tre passi al termine della sua consacrazione. Durante le cerimonie di matrimonio vediche, il numero viene aumentato: la sposa e lo sposo fanno sette passi verso nord-est. Anche il Buddha fece sette passi (subito dopo la sua nascita), e lo stesso fanno gli sciamani dell’Asia interna (Eliade 1964, 405- 406). soma è chiamato urugavyūti, “con ampio pascolo” (ṛgveda 9.90.4). Ma il dio più strettamente legato alla battaglia è indra, la divinità principale del ṛgveda. Con viṣṇu, indra condivide la caratteristica di “fare spazio” (Gonda 1966, 21). Come agni, è aggressivo e vittorioso. Nel rituale del soma, prima che agni e soma vengano portati avanti insieme (agniṣomapraṇayana), agni viene portato avanti da solo (agnipraṇayana), come nel sacrificio animale. Durante questa processione l’adhvaryu recita mantra per agni, indra e altre divinità, chiedendo forza e ricchezza per lo yajamāna ed esprimendo la speranza che i suoi nemici vengano uccisi (taittirīya saiṃitā 4.6.3). Se il rituale del soma include un agnicayana, durante il trasporto di agni si aggiunge un’altra recitazione: il “secondo hotā” (uno degli altri sacerdoti: si veda la nota di Caland all’āpastamba śrauta sūtra 17.14.7) recita un lungo inno a indra, l’apratiratha o “Canto al guerriero irresistibile” (taittirīya saiṃitā 4.6.4). I versi di questa recitazione del taittirīya corrispondono in gran parte a un inno tardo del ṛgveda (10.103), attribuito al “figlio di indra, apratiratha”, che è, secondo le parole di Geldner, “un vigoroso canto di battaglia rivolto ai soldati in partenza per una campagna” (ein urwuchsiges … Schlacht lied, das den ausziehenden Soldaten nachgesungen wird). Il resto della taittirīya saiṃitā 4.6.4 è costituito da versi di un altro inno ṛgvedico (6.75) che glorifica la battaglia. Nella recitazione dell’apratiratha, lo sfondo della cerimonia dell’agnipraṇayana diventa esplicito. indra è invocato come un guerriero o eroe vittorioso, “amante del massacro, disturbatore di popoli”, che con l’aiuto delle sue frecce, dei carri e delle truppe distrugge i nemici. Quando il secondo hotā recita: “Compagni, seguite le orme di indra!”, non sembra tanto un sacerdote officiante quanto un capo banda o un comandante in capo. Questo inno di battaglia fa riferimento di sfuggita alla dakṣiṇā, al sacrificio e a soma, che erano chiaramente associati alla spedizione, accanto alle razzie di bestiame, all’uccisione dei nemici e alla fornitura di lebensraum (habitat) (“Il vostro sarà uno spazio più ampio non solo ampio!”).
Se è vero che c’è stata una prima fase di sviluppo, durante la quale le battaglie e le vittorie erano reali, e una fase successiva, in cui erano diventate rituali, dovrebbe essere possibile determinare - se non in termini assoluti, almeno con riferimento ai nostri testi - quando la prima fase è stata completata e la seconda è iniziata. Sembrerebbe probabile, ad esempio, che la letteratura saṃhitā precedente riflettesse battaglie reali che, al momento degli sūtra rituali, erano diventate pienamente rituali. Tuttavia, questo non è il caso. Ciò che troviamo è invece una miscela inestricabile. Nella saṃhitā incontriamo frasi che, nonostante il loro significato militare, sono già ritualizzate. Nei sūtra śrauta ci sono, accanto alle descrizioni rituali, passaggi che possono avere senso solo in un contesto bellico.
Un esempio del primo è il mantra della taittirīya saṃhitā 1.3.1.1 c: “Colui che ci odia e che noi odiamo, qui gli taglio il collo”. Ciò è riportato in diversi brāhmaṇa (taittirīya saṃhitā 6.1.8.4; cfr. 6.2.10.2; 6.3.9.2), ad es: “Ci sono due persone: una che egli odia e una che lo odia. Sicuramente dovrebbe tagliare il collo di entrambi, in successione”. Questo mantra, che viene recitato spesso, ha un uso puramente rituale: viene recitato quando si prepara il terreno per il sacrificio con l’aiuto di un attrezzo rituale, il coltello di legno (sphya). Questo rito è messo in prospettiva da un altro brāhmaṇa (taittirīya saṃhitā 2.6.4.3), che spiega che il nemico deve essere escluso dall’altare, aggiungendo che la costruzione di un altare è un atto crudele.
Sebbene la descrizione degli śrauta sūtra riguardi il rituale, ci sono occasionali riferimenti ai nemici in carne e ossa. Quando si raccoglie l’argilla per il vaso ukhā, l’adhvaryu dovrebbe recitare, tra gli altri, un mantra dal suono molto innocente: “Sulla via degli aṅgiras, stiamo andando a prendere agni nascosto nel fango” (taittirīya saṃhitā 4.1.2.2 g). Quando si deve recitare questo mantra? Quando si incontra un nemico (dveṣya) sul cammino (āpastamba śrauta sūtra 16.2.6, con nota di Caland; cfr. Heesterman 1967, 37; Keith 1914, 290, nota 5). Allo stesso modo, quando si prepara il terreno per l’altare di fuoco, l’adhvaryu getta grumi di argilla intorno, girando in senso orario e prendendo l’ultimo grumo dalla direzione del suo nemico (āpastamba śrauta sūtra 16.20.6; cfr. Keith 1914, 318 nota 9). In questo caso il corrispondente brāhmaṇa (taittirīya saṃhitā 5.2.5.6) afferma semplicemente che la persona che si trova in quel quartiere ha fame. Questi riferimenti ai nemici negli śrauta sūtra non sono nemici rituali o demoni, come gli studenti di religione potrebbero aspettarsi. Questi nemici sono persone reali, appartenenti alla popolazione originaria. Heesterman ha stabilito il significato di diversi passaggi, sui quali tornerò in una sezione successiva.
Rau (1957, 31) ha qualcosa da dire su molti pregiudizi diffusi nei confronti degli indiani vedici. La vita a quei tempi non era facile, né per i nomadi vedici né per le persone che incontravano. I testi vedici affermano ripetutamente che il più grande nemico dell’uomo è la fame. La lotta per la terra e il lebensraum (habitat) era una lotta per la sopravvivenza. Rau conclude che non ci sono prove a sostegno dell’idea che gli indiani vedici “vivessero in una terra di abbondanza e non avessero niente di meglio da fare che sdraiarsi sotto gli alberi, in un bel contesto naturale, meditare su questioni metafisiche e inginocchiarsi davanti ai fiori di loto come persone gentili e belle” (lebten … in einem Schlarajfenland and hatten nichts anders zu tun, als in landschaftlich lieblichen Gegenden, unter Baumen gelagert, den Problemen der Metaphysik nachzusinnen oder als schone, stille Menschen vor Lotusblumen zu knien).
Non sorprende che il rituale non sia semplicemente paragonato a un carro, ma che gli strumenti rituali siano considerati armi (Heesterman 1962, 35). Come abbiamo già visto, le recitazioni rituali del ṛgveda erano chiamate śastra, un termine derivato dal verbo śaṃs-, “recitare”, che è omonimo con śastra, “spada”, da śas-, “tagliare”. I nomadi vedici combattevano battaglie a più livelli.
Finora abbiamo incontrato il soma in diversi contesti. Abbiamo visto che gli indiani vedici hanno sviluppato una gerarchia di rituali di soma. In ognuno di essi, agni e soma sono le principali dramatis personae. Questi due elementi sono presenti anche presso gli antichi iraniani. In India, un agnicayana può essere costruito facoltativamente al posto dell’altare delle offerte per il fuoco āhavanīya di un rituale di soma. In questo libro, l’agnicayana riceverà maggiore attenzione rispetto ai rituali di soma, in parte per limiti di spazio e in parte perché il prototipo dei rituali di soma, l’agniṣṭoma, è stato descritto in modo completo da Caland e Henry. Tuttavia, non si può non concordare con Wasson sul fatto che “non si può negare che la cultura vedica con il soma non identificato sia il dramma di Amleto senza Amleto” (Wasson 1968, 7).
Abbiamo visto che il soma è un dio, una pianta e il liquido estratto da quella pianta. Dal brāhmaṇa in poi, i ritualisti hanno fatto uso di sostituti del soma originale. Tra questi vi sono l’efedra, la sarcostemma e altri rampicanti e piante senza proprietà particolarmente rilevanti. Attualmente esistono due teorie serie sull’identità del soma originale: Quella di Wasson, secondo cui si tratterebbe del fungo allucinogeno Amanita muscaria (Wasson 1968), e quella di Flattery, secondo cui si tratterebbe della pianta allucinogena Peganum harmala, o ruta selvatica (Flattery, di prossima pubblicazione). Il libro di Wasson è ampiamente disponibile e il signor Flattery mi ha dato accesso al manoscritto del suo libro prima della sua pubblicazione. Non è questa la sede per giudicare tra le due teorie, che sono entrambe presentate e argomentate con grande abilità e con una considerevole quantità di prove (per lo più indiane nel caso di Wasson, e iraniano nel caso di Flattery). Sebbene il lavoro di Flattery non sia stato pubblicato prima dell’uscita del presente lavoro, quello di Wasson è già stato ampiamente discusso. L’identificazione di Wasson è stata accettata o considerata probabile da alcuni studiosi di sanscrito (Kuiper 1970, Ingalls 1971) e respinta da almeno un altro (Brough 1971), ed egli ha risposto ai suoi critici (Was son 1970, 1972). La tesi di Wasson implica, ma non è implicita, una tesi più debole, ossia che il soma vedico originale fosse una pianta allucinogena. Ritengo che questa sia la parte più importante dell’ipotesi di Wasson, la parte, inoltre, che a mia conoscenza non è stata messa seriamente in discussione. È certamente accettata da Flattery. Penso, infatti, che la validità di questa tesi più debole possa essere considerata assodata.
Una delle argomentazioni di Wasson a sostegno dell’idea che il soma fosse l’agarico mosca è l’uso sciamanico dell’amanita muscaria come allucinogeno in diverse parti della Siberia. Sebbene Brough abbia escluso il valore probatorio di tali parallelismi (Brough 1971, 332), non si può negare che anche le prove indiziarie di questo tipo siano ovviamente delle prove (come Brough accetta almeno in pratica). Inoltre, nell’ambito di un’ipotesi storica, non possiamo aspettarci nulla di simile a una prova definitiva; abbiamo a che fare con gradi di probabilità. Anche l’adulazione ha fatto riferimento a parallelismi, senza nemmeno attribuire possibili connessioni storiche. Il principale principio attivo del Peganum harmala è l’harmina, che è anche il principale principio attivo della Banisteriopsis, lo yajé dell’alta Amazzonia (Flattery, §§ 36-38). Le connessioni tra le credenze dei nomadi vedici e le credenze sciamaniche, a cui ho fatto riferimento più volte, aumentano la plausibilità dell’ipotesi di Wasson, ma sostengono anche la teoria di Flattery: Il Peganum harmala è disponibile, anzi è molto diffuso, in tutta la “Grande area iranica”, cioè “a ovest della Cina, a nord dell’India, a est delle civiltà della Mesopotamia…”. . . e a sud delle foreste subartiche della Siberia” (Flattery, §§ 28, 42-45).
Come l’uso e il culto del fuoco, anche l’uso e il culto degli allucinogeni ci riportano alla preistoria e alla prima storia dell’umanità. Sebbene le prove archeologiche dell’uso degli allucinogeni siano scarse, sono disponibili prove storiche provenienti da varie aree e le prove antropologiche sono abbondanti. La somma delle prove indica un’esperienza umana antica e diffusa quasi quanto l’esperienza del fuoco. Il fatto che questo argomento sia stato trattato solo di recente è dovuto a mode recenti, ma anche alla scarsità di prove materiali in combinazione con il pregiudizio della nostra cultura, che considera le prove materiali più evidenti di quelle psicologiche.
L’uso dei funghi è attestato fin dal Neolitico (Boletes nelle culture lacustri svizzere). Abbiamo già notato gli antichi usi dei funghi come esca nel processo di produzione del fuoco. Le “pietre-fungo” dei Maya, negli attuali Messico e Guatemala, costituiscono la più antica testimonianza del culto di un fungo allucinogeno. Le prime pietre risalgono al XIII-X secolo a.C., le ultime all’800-900 d.C.
Le pietre-fungo Maya rappresentano generalmente un fungo sopra un animale e sono alte dai 20 ai 35 centimetri (Heim 1963, 206).
L’idea di un’erba dell’immortalità, molto probabilmente un allucinogeno, è antica almeno quanto l’epopea sumera di Gilgamesh, che ci riporta a circa il 2.000 a.C. Wasson ha suggerito che la credenza taoista nei “funghi magici” costituisce una prova dell’uso sistematico di sostanze allucinogene nei rituali, e Needham ha appoggiato questa opinione (Needham 1974, V, 121). Needham suggerisce anche che i taoisti generassero fumi allucinogeni nei loro bruciatori di incenso (ibid., 150-154). In tempi recenti, l’uso di allucinogeni di origine vegetale è stato riscontrato in tutte le parti del mondo, soprattutto in America (per una rassegna si veda Schultes 1969). Oltre ai funghi (si veda in particolare Heim 1963), questi includono cactus, arbusti, varie leguminose e semi che vengono mangiati, bevuti, fumati o annusati. Molte di queste piante sono considerate sacre. Gli indiani messicani le consideravano mediatrici con gli dei. Gli indiani Chontal di Oaxaca chiamano il loro arbusto allucinogeno “foglia di Dio” e gli Aztechi si riferiscono al fungo sacro come “carne di Dio” (Schultes 1969, 254; Wasson 1972, 47). In un caratteristico rovesciamento, gli invasori cristiani del Messico chiamarono l’ololiuqui azteco (Morning Glory) un “seme diabolico” (Schultes 252).
Uno dei migliori argomenti a favore del carattere allucinogeno del soma è la distinzione vedica tra gli effetti del soma e quelli della surā, una bevanda fermentata. Mentre il soma porta all’“estasi”, alla “felicità” o al “rapimento” (mada, sumada), la surā produce una “intossicazione malvagia” (durmada). O’Flaherty fa riferimento a questo proposito al śatapatha brāhmaṇa 5.1.2.10: “soma è verità, prosperità, luce; e surā verità, miseria, oscurità” (Wasson 1968, 95, 137, ecc.). La bevanda surā è usata in alcuni dei rituali vedici classici, ad esempio nel vājapeya e nel sautrāmaṇī.
Nei rituali vedici, il soma viene introdotto nel recinto sacrificale durante la cerimonia del somakraya, “acquisto del soma”. Il mercante di soma e l’adhvaryu (per conto dello yajamāna) si impegnano in una contrattazione rituale sul prezzo, ma alla fine gli steli di soma vengono portati via con la forza e il canto di soma viene picchiato con un bastone e allontanato. Secondo Renou, queste cerimonie dimostrano che un tempo il traffico di soma poteva essere illegale. Allo stesso tempo ci ricordano che il soma, come agni, era considerato rubato al cielo e nuovamente rubato ai demoni (O’Flaherty 1976, 99-104).
Secondo il ṛgveda, il soma è l’elisir di lunga vita, indispensabile sia per gli uomini che per gli dei. È l’amṛtam, la bevanda dell’immortalità. Questo termine è lndo-europeo: amṛtam (inglese “immortalità”) corrisponde, ad esempio, al greco ἀμβροσία (per lo sviluppo di queste e di altre parole affini in sanscrito e in greco, si veda Thieme 1952, 15-34). indra è particolarmente affezionato a soma. soma e agni sono in molti modi collegati, come abbiamo visto. soma ha diverse proprietà in comune con altre divinità vediche. Viene trattato come un re e invocato come un dio combattente, un comandante valoroso, un eroe e un dio che si è fatto strada, distruttore di nemici (Gonda 1965, 52). soma, anche sotto questo aspetto simile ad agni, veniva fatto scendere dal cielo da un uccello rapace (śyena).
Le testimonianze iraniane sembrano suggerire che l’haoma fosse abbastanza comune. Secondo il ṛgveda, la pianta del soma cresceva sulle montagne e il soma migliore proveniva dal monte Mūjavant (che probabilmente corrisponde al Muñjavant dell’epica successiva). Le montagne a cui si fa riferimento sono presumibilmente quelle dell’Himalaya occidentale e dell’Hindukush. Il fatto che soma, secondo il ṛgveda, crescesse sulle montagne è coerente con l’ipotesi di Wasson. Sebbene la mosca agarica cresca a livello del mare nell’Eurasia settentrionale, si trova a sud dell’Oxus e in India solo a grandi altezze, tra gli 8.000 e i 16.000 piedi (Wasson 1968, 23, riferendosi a betulle e conifere, con cui la mosca agarica cresce in relazione micorrizica). Se avessimo qualche mezzo per identificare le rotte percorse dagli indo-irani, varrebbe la pena di cercare lì, anche attualmente, l’Amanita muscaria e altre piante allucinogene. In realtà, qualche prova ce l’abbiamo, a patto di ipotizzare che gli indoeuropei abbiano seguito alcune delle stesse antiche rotte commerciali che il buddismo ha percorso due millenni dopo in direzione opposta.
La relativa facilità con cui il buddismo è entrato in Asia centrale e vi è stato accettato può farci riflettere sul significato di queste aree montuose dove è cresciuto il soma. La cultura vedica viene generalmente affrontata da due prospettive: una prospettiva linguistica che sottolinea lo sfondo indoeuropeo e una prospettiva religiosa che sottolinea il seguito indù. La storia dell’India e dell’Asia centrale mostra che queste etichette sono fuorvianti e che le migrazioni buddiste sono parte della storia. Non solo il buddismo centro-asiatico, ma il buddismo in generale, contiene molti elementi sciamanici. È sempre più chiaro che i nomadi vedici introdussero in India elementi sciamanici. Sebbene il buddismo sia generalmente caratterizzato come una reazione contro la religione vedica, si tratta di una generalizzazione piuttosto ampia. Un’analisi più attenta dei fatti dimostrerebbe che c’è stata almeno tanta continuità quanta opposizione. I miti di indra e le leggende del Buddha, ad esempio, hanno molte caratteristiche in comune. Le tecniche di immortalità, che si sono evolute nelle upaniṣad a partire da un background rituale, sono simili allo yoga e alle tecniche buddiste. Molte di queste nozioni contengono elementi sciamanici che i nomadi vedici portarono dall’Asia centrale all’India e che i buddisti ripresero 2.000 anni dopo. Dal punto di vista dell’Asia centrale, queste idee e pratiche sciamaniche, che continuavano a esistere nella loro terra d’origine, sono semplicemente tornate dopo una lunga vacanza in India. Le etichette che attribuiamo alle principali civiltà e religioni dell’area nascondono il fatto che la realtà sottostante è probabilmente meglio descritta come un continuo scambio di persone, beni e idee tra India e Asia centrale.
L’India è spesso immaginata come un Paese isolato, separato dal resto del mondo da una formidabile barriera di montagne. Anche se questo spesso porta all’inutile presupposto che l’India sia una terra misteriosa, c’è del vero nell’osservazione geografica. Allo stesso tempo, non bisogna esagerare. La via occidentale che collega l’Indo e l’Oxus, passando per l’Afghanistan nord-orientale, sebbene lunga, non è molto ardua. Più a est, la valle dell’Indo superiore nell’attuale Ladakh (India nord-occidentale) e il bacino del Tarim nell’attuale Sinkiang (Cina occidentale) sono separati da circa 250 miglia di piste montuose. Anche con un passo di 18.000 piedi sul percorso, una tale distanza può essere coperta a piedi in meno di un mese, almeno durante l’estate.
Seguiamo ora la storia del soma dopo il suo ingresso nel subcontinente indiano. Il soma originale andò presto perduto. A partire dal periodo dei brāhmaṇa, fu rimpiazzato da sostituti, perché i nomadi vedici avevano lasciato le montagne (Wasson), o comunque la “Grande area iranica” (Flattery), e il soma non cresceva nelle pianure indiane. È significativo che con la graduale scomparsa del soma originario i rituali siano diventati sempre più complessi. Circostanze simili prevalgono altrove. Il Peyote migliore proviene dalla Valle del Rio Grande, dove cresce anche più abbondantemente. Gli indiani delle tribù del sud fanno viaggi cerimoniali di raccolta per procurarselo. Gli indiani delle tribù del nord, invece, sono più lontani, devono rifornirsi per posta e incorporano meno Peyote nelle loro cerimonie. Allo stesso tempo, iniziano le loro cerimonie con la purificazione attraverso purghe, bagni di sudore e digiuni. Fischer (1958, 401) ha suggerito che queste cerimonie aggiuntive, insieme alle quantità più limitate di Peyote, hanno lo scopo di produrre un’esperienza di intensità simile a quella evocata unicamente da dosi maggiori di Peyote. Heim (1963, 211) riferisce che i messicani eseguono due tipi di rituali in relazione alle loro stanze della poltiglia allucinogena: in uno si consumano solo funghi; nell’altro si consumano funghi, ma si distribuiscono anche chicchi di mais. Questa seconda varietà è imprégné de processus magique. Più vicino a noi, gli annunci di concerti rock vantano che il pubblico si sballerà senza l’uso di droghe. In tutti questi casi, il rituale subentra laddove l’allucinogeno stesso è limitato o del tutto assente. ṛgveda 7.26.1 afferma che gli effetti del soma non dipendono dalla semplice ingestione: “Il soma non spremuto non ha mai inebriato indra, né il succo spremuto non accompagnato da inni sacri”. Sembra quindi probabile che la crescente complessità dei rituali del soma sia una diretta conseguenza della minore disponibilità del soma originale (cfr. Staal 1975, 182-183). Anche in questo caso assistiamo a un’evoluzione simile a quella riscontrata in precedenza. Questa volta una sostanza non più disponibile viene conservata, ma solo ritualmente.
Un semplice esempio di questa ritualizzazione è il rito di Apyayana. Dal momento in cui il soma viene acquistato e intronizzato a sud del (vecchio) altare delle offerte fino al giorno della spremitura del soma, questo rito viene eseguito due volte al giorno, al mattino e alla sera prima del Pravargya. Per prima cosa l’agnīdh fa bollire l’acqua. Tutti i sacerdoti, tranne i sāmavedin, si lavano le mani in quell’acqua. Poi, uno per uno, in piedi a ovest del fascio di soma, toccano il re soma e recitano (vedi foto 38D, F, 55): “Stelo per stelo, O dio soma, gonfiati per indra che ottiene la sua parte di ricchezza. Lascia che indra si gonfi per te e tu per indra” (taittirīya saṃhita 1.2.11.1 a). Lo yajamāna aggiunge: “Fa’ che i tuoi amici si gonfino con il bottino e l’abilità; possa io realizzare con successo la tua pressione, O dio soma” (ibid. b). Dalla prima volta che viene eseguito questo rito fino al momento in cui soma e agni vengono portati sul nuovo altare delle offerte, i sacerdoti devono lavarsi le mani solo con acqua bollita.
I testi menzionano un’alternativa alla semplice recitazione di questi mantra: la recitazione può essere accompagnata dall’aspersione del fascio di soma con la stessa acqua calda che era stata bollita. Qui sta l’origine del rito. Le piante di soma erano essiccate al momento dell’acquisto e dovevano gonfiarsi assorbendo gradualmente l’acqua. Nel corso del processo di ritualizzazione, il soma non viene più cosparso di acqua, ma di mantra. Questa è una caratteristica del rituale vedico e riflette la fiducia vedica nel potere del linguaggio. Per la maggior parte dei rituali, l’esecuzione di un atto a parole vale quanto la sua esecuzione. In tempi successivi, i riti vengono interamente sostituiti da recitazioni e, in ultima istanza, da meditazioni inudibili.
Il rito āpyāyana supporta l’ipotesi di Wasson in modo diretto. Due dei principi attivi psicotropi dell’Amanita muscaria sono l’acido ibotenico e il muscimolo:
Quando l’agarico si asciuga, l’acido ibotenico si disintegra e scompare. Viene sostituito dal muscimolo, che è almeno cinque volte più potente. Abbiamo quindi una situazione unica in cui un agente psicotomimetico si converte, attraverso la semplice essiccazione, in un altro agente attivo di gran lunga più potente e più stabile (Wasson 1972, 12).
La quantità di muscimolo così raggiunta rimane costante quando la sostanza viene nuovamente mescolata con acqua, latte, cagliata o altri liquidi. È probabile che il trattamento preciso che i sostituti del soma ricevono nel processo rituale che porta all’estrazione del succo getti ulteriore luce sull’identità del soma originale. Tali manipolazioni sarebbero state conservate nel rituale anche se non erano più funzionali, poiché, come abbiamo visto più volte, la conservazione di caratteristiche che hanno cessato di essere funzionali è una delle caratteristiche principali del rituale. Le quantità e le proporzioni esatte utilizzate nelle miscele sono inoltre importanti per determinare le proprietà psicotrope degli allucinogeni (Waser 1967, 435, ad esempio, riporta notevoli differenze quando gli effetti di 10 mg. di muscimolo vengono confrontati con quelli di 15 mg.) È quindi importante determinare come il soma sia stato misurato e mescolato con altre sostanze. Mentre l’origine geografica del soma si trova sulle alte montagne dell’Himalaya occidentale, la sua origine mitica si trova in cielo. Questa credenza esprime il carattere divino di soma e lo collega direttamente ad agni. Qui il retroterra non è solo sciamanico (come ha dimostrato Wasson), ma anche indoeuropeo, essendo le due cose probabilmente correlate (cfr. carta A). Nel suo famoso libro sulla discesa del fuoco e della bevanda divina (1859, già citato), Adalbert Kuhn ha dimostrato che in tutte le principali lingue indoeuropee - tra gli indiani, i greci, i romani e i tedeschi - si trovano idee simili sull’origine celeste del fuoco e della bevanda dell’immortalità. Entrambi hanno origine principalmente nelle nuvole, da cui scendono fulmini e pioggia. Anche il fuoco celeste è legato al sole ed è concepito in termini di accensione per attrito. Il bastone di accensione è la folgore, conosciuta con vari nomi: vajra tra gli indiani, κεραυνός tra i greci, cuneus tra i romani e Donnerkeil tra i tedeschi. Il carattere fallico di questi oggetti, anche se non sottolineato da Kuhn, salta agli occhi.
La bevanda dell’immortalità (amṛta, ἀμβροσία) scende dal cielo in modo simile. I miti indiani della zangolatura dell’oceano mostrano che la produzione di questo elisir è pensata in termini simili alla produzione del fuoco per attrito. L’uccello rapace - un’aquila, un avvoltoio o un falco - che porta la corrente e il fuoco sulla terra, è associato a un albero celeste in cui ha il suo nido e i cui rami forniscono la torcia in cui il fuoco viene trasportato. In Europa l’albero celeste è spesso un frassino. Come abbiamo visto, il furto del fuoco e del soma è generalmente attribuito a un uccello, ma può anche essere attribuito a un personaggio come Prometeo, il cui nome Kuhn ha messo in relazione con il bastone per l’accensione (pramanthana).
Il ṛgveda racconta come l’uccello portò soma sulla terra da una montagna. Poiché soma è una persona, questo atto ha il carattere di un’abduzione, come ha sottolineato Schneider (1971). L’uccello aiutò indra a ottenere soma ed entrambi si vantarono della loro abilità, come fece Prometeo (sopra, pp. 84-85). In generale, queste leggende si intrecciano con riferimenti a numerose altre storie. Alcune di queste non sono più comprensibili e non cercherò di renderle intelligibili. Nei due inni seguenti, tratti dall’Igveda, viene menzionato un demone, Sambara, che era interessato al soma e cercava di impedire all’uccello di ottenerlo. Il principale nemico di Sambara era Divodasa Atithigva. PuraQidhi, forse “che dà pienezza”, si riferisce all’uccello.
ṛgveda 4,26 è pronunciato da indra (la traduzione segue per lo più Schneider 1971):
aham manurabhavam sūryaścāham kakṣīvām̐ ṛṣirasmi vipraḥ ǀ aham kutsamārjuneyam nyṛñje’ham kaviruśanā paśyatā mā ǁ Sono diventato manu e sūrya; sono kakṣivat, il saggio veggente; ho invitato kutsa, il figlio di arjuna; sono l’ispirato uśanas - guardatemi!
aham bhūmimadadāmāryāyāham vṛṣṭim dāśuṣe martyāya ǀ ahamapo anayam vāvaśānā mama devāso anu ketamāyan ǁ Ho dato la terra agli ārya; ho dato la pioggia al mortale che offre sacrifici. Ho portato le acque tonanti; gli dèi seguono il mio scopo.
aham puro mandasāno vyairam nava sākam navatīḥ śambarasya ǀ śatatamam veśyam sarvatātā divodāsamatithigvam yadāvam ǁ Estasiato da soma, frantumai le novantanove fortezze di śambara tutte in una volta, e infine la sua cittadella come la centesima, aiutando divodāsa atithigva.
pra su ṣa vibhyo maruto virastu pra śyenaḥ śyenebhya āśupatvā ǀ acakrayā yatsvadhayā suparṇo havyam bharanmanave devajuṣṭam ǁ O Marut, fa’ che l’uccello dalle belle ali sia al di sopra di tutti gli uccelli, il falco dal volo veloce al di sopra di tutti i fachi, poiché con la sua stessa potenza motrice, che non ha bisogno delle ruote del carro, ha portato a manu l’oblazione offerta agli dei.
bharadyadi virato vevijānaḥ pathoruṇā manojavā asarji ǀ tūyam yayau madhunā somyenota śravo vivide śyeno atra ǁ Tremando, se potesse abbatterlo, l’uccello veloce come il pensiero si lanciò per l’ampio sentiero; rapidamente il falco arrivò con il miele di soma e si guadagnò la fama per questo.
ṛjīpī śyeno dadamāno aṃśum parāvataḥ śakuno mandram madam ǀ somam bharaddādṛhāṇo devāvāndivo amuṣmāduttarādādāya ǁ Volando dritto, reggendo il germoglio, il falco portò la bevanda inebriante e allietante; l’uccello, compagno degli dei, strinse forte il soma mentre lo prendeva da quel cielo superiore.
ādāya śyeno abharatsomam sahasram savām̐ ayutam ca sākam ǀ atrā puraṃdhirajahādarātīrmade somasya mūrā amūraḥ ǁ Quando il falco ebbe preso il soma, lo portò, mille e diecimila pressioni sacrificali in una volta sola; puraṃdhi (generosità, gentilezza) lasciò indietro i nemici; estasiato dal soma, il saggio lasciò gli sciocchi.
L’inno successivo, ṛgveda 4.27, è pronunciato da soma:
garbhe nu sannanveṣāmavedamaham devānām janimāni viśvā ǀ śatam mā pura āyasīrarakṣannadha śyeno javasā niradīyam ǁ Mentre ero ancora nel grembo di mia madre, conoscevo tutte le generazioni successive degli dei. Cento fortezze di ferro mi proteggevano, ma io e il falco volammo via rapidamente.
na ghā sa māmapa joṣam jabhārābhīmāsa tvakṣasā vīryeṇa ǀ īrmā puraṃdhirajahādarātīruta vātām̐ ataracchūśuvānaḥ ǁ Non mi trascinò via contro la mia volontà, perché lo superai in energia e forza. In un lampo, puraṃdhi si lasciò alle spalle i nemici e superò i venti, gonfio di soma.
ava yacchyeno asvanīdadha dyorvi yadyadi vāta ūhuḥ puraṃdhim ǀ sṛjadyadasmā ava ha kṣipajjyām kṛśānurastā manasā bhuraṇyan ǁ Mentre i falchi scendevano strillando dal cielo, o da qui, portavano puraṃdhi. Mentre l’arciere kṛśanu, con un rapido pensiero, allentava la corda dell’arco e gli tirava contro.
ṛjipya īmindrāvato na bhujyum śyeno jabhāra bṛhato adhi ṣṇoḥ ǀ antaḥ patatpatatryasya parṇamadha yāmani prasitasya tadveḥ ǁ Il falco, allungandosi in un rapido volo, portò soma dalle grandi altezze all’accampamento di indra, così come gli āśvin portarono bhujyu dal mare; all’interno cadde una piuma d’ala dell’uccello, mentre manteneva la rotta del suo volo.
adha śvetam kalaśam gobhiraktamāpipyānam maghavā śukramandhaḥ ǀ adhvaryubhiḥ prayatam madhvo agramindro madāya prati dhatpibadhyai śūro madāya prati dhatpibadhyai ǁ Il calice bianco traboccante di soma mescolato con latte di mucca, il succo limpido offerto dagli adhvaryu, il miele più fine, ora lascia che il generoso indra lo sollevi per bere fino all’estasi del soma; lascia che l’eroe lo sollevi per bere fino all’estasi del soma.
La convinzione di base che sta alla base dei rituali del soma è la convinzione che bere il soma porti all’immortalità. Questa convinzione è ancora viva. Nel corso di un’intervista sul significato del rituale, Cherumukku Vaidikan, principale organizzatore del rituale del 1975, ha recitato il relativo versetto del ṛgveda (8.48.3; cfr. sotto, pagina 617):
apāma somamamṛtā abhūmāganma jyotiravidāma devān ǀ kim nūnamasmānkṛṇavadarātiḥ kimu dhūrtiramṛta martyasya ǁ Abbiamo bevuto il soma, siamo diventati immortali, siamo venuti alla luce, abbiamo trovato gli dei. Che cosa può fare l’inimicizia, che cosa può fare l’intrigo di un qualsiasi mortale a noi, o immortale?
EGGELING (1897, IV, xiv-xv) è stato probabilmente il primo a suggerire che l’agnicayana è collegato a un inno tardivo del ṛgveda, il puruṣasūkta o “Inno dell’Uomo Cosmico” (ṛgveda 10.90). Questo inno è relativamente recente perché si trova nel decimo e ultimo libro del ṛgveda e perché si riferisce per nome ai tre Veda (ṛk, sāman e yajus) e (per la prima e unica volta nel ṛgveda) alle quattro classi (brāhmaṇa, rājanya, vaiśya e sūdra). Il puruṣasūkta è attribuito a un veggente chiamato nārāyaṇa ed è composto da sedici versi3:
- sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt ǀ
sa bhūmim viśvato vṛtvātyatiṣṭhaddaśāṅgulam ǁ
puruṣa aveva mille teste, mille occhi, mille piedi.
Ricopriva tutta la terra da ogni parte e la superava ancora di dieci dita’.- puruṣa evedam sarvam yadbhūtam yacca bhavyam ǀ
utāmṛtatvasyeśāno yadannenātirohati ǁ
purusa è tutto questo universo, sia ciò che è stato, sia ciò che deve ancora essere.
Egli è anche il signore degli immortali che fa crescere sempre di più con il cibo sacrificale.- etāvānasya mahimāto jyāyāṃśca pūruṣaḥ ǀ
pādo’sya viśvā bhūtāni tripādasyāmṛtam divi ǁ
Tale come è stata detta è la grandezza di puruṣa, ma lui è più grande di questa sua grandezza:
un quarto di lui sono tutti gli esseri, tre quarti di lui costituiscono l’immortalità in cielo.- tripādūrdhva udaitpuruṣaḥ pādo’syehābhavatpunaḥ ǀ
tato viṣvaṅvyakrāmatsāśanānaśane abhi ǁ
Per tre quarti puruṣa si è levato in alto; un quarto di lui si è trasformato negli esseri.
Da qui si è disteso in tutte le direzioni, verso ciò che mangia e verso ciò che non mangia.- tasmādvirāḷajāyata virājo adhi pūruṣaḥ ǀ
sa jāto atyaricyata paścādbhūmimatho puraḥ ǁ
Da lui nacque virāj, da virāj puruṣa.
E, una volta nato, superò la terra a oriente e a occidente.- yatpuruṣeṇa haviṣā devā yajñamatanvata ǀ
vasanto asyāsīdājyam grīṣma idhmaḥ śaraddhaviḥ ǁ
Quando gli dèi celebrarono il sacrificio con puruṣa come oblazione,
la primavera fu il burro fuso, l’estate la legna da ardere, l’autunno l’offerta.- tam yajñam barhiṣi praukṣanpuruṣam jātamagrataḥ ǀ
tena devā ayajanta sādhyā ṛṣayaśca ye ǁ
Quel puruṣa, nato ai primordi, essi lo aspersero come vittima sacrificale sullo strame d’erba.
Con lui gli dèi, i sādhya e i veggenti compirono il sacrificio.- tasmādyajñātsarvahutaḥ sambhṛtam pṛṣadājyamǀ
paśūntāṃścakre vāyavyānāraṇyāngrāmyāśca ye ǁ
Da quel sacrificio completamente offerto fu raccolto il burro coagulato:
esso divenne gli animali, quelli che stanno nell’aria, quelli che stanno nella foresta e quelli che stanno nei villaggi.- tasmādyajñātsarvahuta ṛcaḥ sāmāni jajñire ǀ
chandāṃsi jajñire tasmādyajustasmādajāyata ǁ
Da quel sacrifìcio completamente offerto nacquero il ṛgveda e il sāmaveda;
da quello nacquero i metri; da quello nacque lo yajurveda.- tasmādaśvā ajāyanta ye ke cobhayādataḥ ǀ
gāvo ha jajñire tasmāttasmājjātā ajāvayaḥ ǁ
Da quello nacquero i cavalli e tutti gli altri animali che hanno denti incisivi sia sopra che sotto,
da quello nacquero le vacche, da quello nacquero le capre e le pecore.- yatpuruṣam vyadadhuḥ katidhā vyakalpayan ǀ
mukhām kimasya kau bāhū kā ūrū pādā ucyete ǁ
Quando smembrarono puruṣa, in quanti parti lo divisero? Che cosa divenne la sua bocca?
Che cosa le sue braccia? Come sono chiamate ora le sue cosce? E i suoi piedi?- brāhmaṇo’sya mukhāmāsīdbāhū rājanyaḥ kṛtaḥ ǀ
ūrū tadasya yadvaiśyaḥ padbhyām śūdro ajāyata ǁ
La sua bocca diventò il brahmano, le sue braccia si trasformarono nel guerriero,
le sue cosce nel vaiśya; dai piedi nacque lo śudra.- candramā manaso jātaścakṣoḥ sūryo ajāyata ǀ
mukhādindraścāgniśca prāṇādvāyurajāyata ǁ
Dalla sua mente nacque la luna, dagli occhi nacque il sole;
dalla bocca indra e agni; dal respiro nacque il vento.- nābhyā āsīdantarikṣam śīrṣṇo dyauḥ samavartata ǀ
padbhyām bhūmirdiśaḥ śrotrāttathā lokām̐ akalpayan ǁ
Dal suo ombelico ebbe origine l’atmosfera; dalla testa si produsse il cielo,
dai piedi la terra; dalle orecchie i punti cardinali. Così gli dèi formarono il mondo.- saptāsyāsanparidhayastriḥ sapta samidhaḥ kṛtāḥ ǀ
devā yadyajñam tanvānā abadhnanpuruṣam paśum ǁ
Sette furono i legni di contorno, tre volte sette furono i legni da bruciare posti sul fuoco,
quando gli dèi, celebrando il sacrificio, legarono puruṣa come vittima sacrificale.- yajñena yajñamayajanta devāstāni dharmāṇi prathamānyāsan ǀ
te ha nākam mahimānaḥ sacanta yatra pūrve sādhyāḥ santi devāḥ ǁ
Con questo sacrificio gli dèi fecero un sacrificio al sacrificio: queste regole furono le prime.
Questi poteri raggiunsero il firmamento dove stanno i sādhya, che furono i primi, e gli dèi.
In altre culture, simili giganti primordiali sono considerati l’origine e la causa materiale dell’universo. Nell’ambito della famiglia indoeuropea, un simile gigante è presente nella mitologia norrena, dove è chiamato Ymir, e in quella iranica, dove è chiamato Gayōmart. Per quanto riguarda le somiglianze mitiche tra Gayōmart e puruṣa, “sembrano esserci tutte le ragioni per credere che si tratti di un caso di influenza indiana sul pensiero iranico” (Zaehner 1955, 137). Secondo Norman Brown (1931), il puruṣa del ṛgveda 10.90 non trae la sua importanza, né genetica né ideologica, da alcun legame con tali parenti indoeuropei. Brown (1931, 114) ha sostenuto che puruṣa è “soprattutto una derivazione secondaria da nozioni stabilite in precedenza nel ṛgveda”. In particolare, puruṣa è una combinazione di caratteristiche derivate da agni, sūrya (il Sole) e viṣṇu. Per una dimostrazione dettagliata di questo punto di vista, nonché per commenti dettagliati sui singoli versi dell’inno del puruṣa, si rimanda il lettore allo studio di Brown.
L’idea di un sacrificio cosmico, in cui una persona primordiale crea il mondo attraverso il proprio sacrificio e smembramento, è la teoria di base del rituale adottata nei brāhmaṇa. Qui prajāpati prende il posto di puruṣa. Abbiamo già visto come śāṇḍilya abbia espresso queste idee con particolare riferimento all’agnicayana (sopra, pagine 65 e 67). Diverse caratteristiche specifiche dell’agnicayana si riferiscono al puruṣa. La più importante è il puruṣa dorato (hiraṇmayapuruṣa), che viene sepolto sotto il primo strato. Quando viene deposto, si canta il puruṣa-sāman. Sebbene questo sāman provenga dalla sezione araṇyageyagāna del sāmaveda (che consiste in “canti da intonare nella foresta”), e consista quasi interamente di stobha (sillabe prive di significato), la parola sahasra, “mille”, vi compare e ci ricorda l’inno del puruṣa. Quando l’altare è completato e lo yajamāna sta per desiderare che i mattoni si trasformino in mucche, l’adhvaryu mette mille pezzi d’oro sull’altare recitando la taittirīya saṃhitā 4.4.11.30: “Tu sei la misura di mille, tu sei l’immagine di mille, tu sei la dimensione di mille, tu sei la replica di mille, tu sei di mille, tu per mille!”. Questo ricorda anche ṛgveda 10.90. Inoltre, nel sacrificio della capra per prajāpati nell’agnicayana, il numero di ceppi di legna da ardere prescritto è di ventuno o ventiquattro, in accordo con il versetto 15 dell’inno puruṣa (cfr. taittirīya saṃhitā 5.1.8.5; anche il numero di chicchi messi nelle aperture della testa umana è ventuno).
Il termine puruṣa ricorre in altri quattro inni del ṛgveda, una volta in senso generale e tre volte in un contesto di agni (Brown 1931, 108-109). Anche prajāpati, “signore delle creature” (in origine “signore della prole”? Oldenberg 1919, 27) compare quattro volte nel ṛgveda, tutte nel decimo libro. Un passaggio potrebbe essere stato aggiunto in seguito come risposta alla parte precedente dell’inno con il suo ripetuto ritornello: “Chi è il dio che adoreremo con le oblazioni?”. La risposta è: prajāpati (ṛgveda 10.121.10). L’inno di puruṣa ricorre nell’atharvaveda (Renou 1955a, 436- 438) e altrove nella letteratura vedica. puruṣa viene successivamente identificato con viṣṇu e nārāyaṇa (Shende 1965).
prajāpati come dio creatore incorpora le idee precedenti di creazione nel ṛgveda. La mitologia di yama, la “Morte”, è ricca di nozioni di creazione e auto-immolazione (Dandekar 1945). Il complesso dei miti ṛgvedici che descrivono la lotta tra indra e il demone vṛtra può essere interpretato in termini di miti della creazione (indoeuropei) (ad esempio, Brown 1942). Ma questa mitologia ammette anche un’interpretazione più specifica. In una nota a un passo in cui indra viene descritto mentre libera i fiumi per l’uomo (ṛgveda 1.165.8), Geldner fa riferimento all’invasione ariana. Kosambi (1956, 70-71), seguendo l’analisi di Renou e Benveniste sul significato di vṛtra come “ostacolo”, “sbarramento” o “bloquage”, interpreta l’uccisione di vṛtra come la rottura delle dighe. Secondo Kosambi, la lotta non è con i demoni, ma dimostra che gli ārya hanno distrutto il sistema di dighe da cui dipendevano l’irrigazione e l’agricoltura indigene. indra, in questo caso, non è il creatore dell’universo, ma il creatore del lebensraum per i nomadi vedici.
Nello yajurveda, nell’atharvaveda (cfr. Renou 1955, 31-48) e in molti brāhmaṇa, prajāpati è diventato dio creatore, dio del sacrificio e sacrificio stesso. Dopo aver procreato gli esseri che compongono questo mondo, egli è esaurito e vuoto, e deve essere nuovamente rafforzato attraverso il rituale. Questo viene elaborato in vari miti, sui quali Keith commenta con la sua caratteristica carità: “i dettagli di questi stupidi miti sono del tutto privi di importanza” (Keith 1925, 442).
Sylvain Levi ha notato che l’attività creativa di prajāpati è generalmente espressa dal verbo sṛj/sarj, “emettere, scaricare”, e spesso da nir-mā, “tracciare, misurare, costruire” (1898 = 1966, 18; per il seguito si veda Levi 1898, 13-35, e Oldenberg 1919, 26-32). Abbiamo già visto che potrebbe esserci un riferimento alla misurazione del terreno. Gli stessi termini sono comunque utilizzati quando l’adhvaryu misura la mahāvedi. Ci sono altri resoconti dello smembramento di prajāpati e delle sue parti che diventano parti dell’universo. Altrove, la sua attività creativa è descritta in termini sessuali. Poiché è il padre, questo comporta l’incesto, in particolare con la figlia. Si unisce anche a vāc, “parola, linguaggio”, perché l’atto della creazione è inseparabile dal linguaggio creativo come l’atto rituale lo è dal mantra.
prajāpati ha creato gli dèi, che poi lo hanno ricomposto attraverso il sacrificio. agni nasce per primo, dalla bocca di prajāpati. Ma poiché agni è un mangiatore di cibo, cioè un divoratore di tutto, prajāpati rifletté: “Qui non c’è altro cibo all’infuori di me, ma sicuramente non mi mangerebbe mai”. Ma agni, il bambino ingrato, si rivolse a lui con la bocca spalancata e prajāpati, terrorizzato, poté salvarsi solo riproducendosi. Lo riferisce il śatapatha brāhmaṇa 2.2.4 commentando il rituale dell’agnihotra: chi esegue l’agnihotra, sapendo questo, “si riproduce con la prole proprio come prajāpati si è riprodotto; e si salva da agni, la Morte, che sta per divorarlo” (śatapatha brāhmaṇa 2.2.4.7). Per questo motivo, la rinascita e la rigenerazione sono cicliche e prajāpati è identificato con l’anno, o con il tempo. Egli è anche “definito e indefinito”, o solo “definito”; e “limitato e illimitato”, o solo “illimitato”.
Nonostante le vaghe somiglianze con il Kronos greco e lo Zurvan iraniano, entrambi legati al tempo, sembra giusto dire che prajāpati, anche se coerente con altre nozioni ṛgvediche, non ha chiare controparti indo-europee o addirittura indo-iraniane. Il suo legame con il rituale del soma è piuttosto debole: “Gioca solo un ruolo molto poco importante nella sequenza dei rituali del soma, che sono stati relativamente ben fissati fin dai primi tempi. Indubbiamente, i riferimenti a lui sono stati inseriti in modo superficiale dopo i rituali” (In dem von altersher vergleichweise fest geordneten somaopfer spielt er nur eine ganz nebensächliche Rolle. Unzweifelhaft sind die Beziehungen auf ihn da nur nachträglich und oberflächlich eingefügt: Oldenberg 1919, 31). L’idea di un dio che si sacrifica è conservata nel rituale: il sacrificatore, o yajamāna, è talvolta identificato con la vittima sacrificale. Coomaraswamy (1942) ha raccolto alcuni dei passaggi rilevanti (fornendo loro interpretazioni che Gonda (1960, 193 nota 24), definisce “confuse e discutibili nei loro dettagli”: verworren und in Einzelheiten anfechtbar). L’idea del sacrificio di sé è fondamentale per la cosmologia di prajāpati e per la conquista ciclica della morte attraverso la rinascita, che caratterizzano il rituale śrauta in generale e l’agnicayana in particolare. Quando gli uomini parlano di autosacrificio, c’è un riferimento implicito al sacrificio umano. Secondo Eggeling (commentando il śatapatha brāhmaṇa 1.2.3.5), i sacrifici animali sostituiscono quelli umani, così come le oblazioni vegetali (in particolare le torte puroḍāśa)) sostituiscono o rappresentano i sacrifici animali. In precedenza, Weber aveva dedicato uno studio speciale ai sacrifici umani nel periodo vedico (Weber 1864, 262-287 = 1868, 54-89), in cui dimostrava che nella letteratura rituale ci sono echi inequivocabili di sacrifici umani, ma che i ritualisti classici spesso li cancellavano. Le osservazioni di Weber sono state sviluppate e modificate in diverse pubblicazioni successive, ad esempio Rönnow(1929), Mus (1935) e Heesterman (1967). Esaminerò alcune osservazioni con particolare riferimento all’agnicayana. Sarà utile, però, tenere a mente una giusta osservazione di Macdonald (1952, 337 = 1975, 8):
È a causa di idee preconcette sulla pratica e sullo sviluppo dell’idea del sacrificio sostitutivo che i ricercatori hanno la tendenza a ricondurre ogni sacrificio a un sacrificio umano.
Weber inizia il suo studio con una citazione dal śatapatha brāhmaṇa, seguendo il passaggio che ha portato all’osservazione di Eggeling sopra citata:
All’inizio gli dei offrivano un uomo come vittima. Quando fu offerto, il succo sacrificale uscì da lui. Entrò nel cavallo. Offrirono il cavallo. Quando fu offerto, il succo sacrificale uscì da lui. Entrò nel bue. Offrirono il bue. Quando fu offerto, il succo sacrificale uscì da esso. Entrò nella pecora. Offrirono la pecora. Quando fu offerta, il succo sacrificale uscì da essa. Entrò nella capra. Offrirono la capra. Quando fu offerta, il succo sacrificale uscì da essa (śatapatha Brahma a 1.2.3.6).
Le cinque teste sepolte sotto l’altare di agnicayana sono di un uomo, un cavallo, un toro, un ariete e un caprone. La testa umana, che può essere ottenuta in vari modi, deve essere di un vaiśya (“uomo della tribù”) o di un rājanya (“capo tribù”). Weber ha concluso che un sacrificio umano faceva parte dell’agnicayana. Giunse a conclusioni simili per quanto riguarda il rājasūya (“consacrazione reale”) e l’aśvamedha (“sacrificio di cavalli”), e infine descrisse l’unico rituale śrauta che è esplicitamente chiamato puruṣamedha, “sacrificio umano”. In questo rituale, la vittima umana, un brāhmaṇa o un kṣatriya, viene trattata bene per la durata di un anno intero, come il cavallo dell’aśvamedha. Al termine, viene adornata, decorata e uccisa. La moglie principale dello yajamāna si sdraia sotto il cadavere. Seguono scambi osceni e indovinelli, come nell’aśvamedha. Quando la vittima viene uccisa, il sacerdote udgātā canta un sāman per yama e l’hotā recita l’inno puruṣa dal ṛgveda.
Il fatto che questo puruṣamedha sia descritto solo in alcuni sūtra rituali ha portato a ritenere che si tratti di un’estensione tardiva e puramente teorica del sacrificio del cavallo. Keith (1925, 347-348) ha negato l’esistenza del sacrificio umano nell’India vedica. Gonda (1960, 187, nota 25) non è “convinto” di Karmarkar (1942, 91-93), secondo il quale lo stesso inno puruṣa si riferiva al sacrificio umano. Secondo Thite, i brāhmaṇa conoscono i riti che accompagnano l’uccisione di vittime umane, ma non prescrivono l’uccisione vera e propria (Thite 1975, 27). Non c’è consenso tra gli studiosi se i puruṣamedha è un’imitazione (“upgrading”: Puhvel 1970, 163) del sacrificio del cavallo, o viceversa, nel qual caso potrebbe trattarsi di un’antica sopravvivenza (un’opinione difesa da Kirfel 1951), o se i due sacrifici siano esistiti insieme fin dall’inizio. Rönnow (1929) ha tentato di dimostrare che il sacrificio umano prevaleva in una religione pre-vedica, “asurica”, di cui rimangono tracce nei rituali pravargya, agnicayana e sautrāmaṇī. La vittima umana è rappresentata dal demone makha, che viene successivamente identificato con il sacrificio stesso. Il pravargya è chiamato la testa del sacrificio, senza il quale è incompleto, così come il recipiente del mahāvīra è considerato la testa del makha. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per il vaso ukhā dell’agnicayana. Mentre il vaso ukhā, con la testa umana all’interno, è sepolto sotto l’altare dell’agnicayana, gli strumenti pravargya, compresi i vasi mahāvīra, sono posti sull’altare in una configurazione speciale che ricorda la forma di un uomo. Che le torte puroḍāśa, che sostituiscono le vittime animali, siano in realtà collegate al sacrificio umano, secondo Rönnow è dimostrato dal fatto che vengono offerte su “frammenti di mattone” (kapāla). Il termine kapāla significa anche (secondo Rönnow, in origine) “ossa del cranio”. I successivi asceti kāpālika, che portano con sé un teschio, prendono il nome da esso (cfr. Lorenzen 1972). Il collegamento è fatto nel śatapatha brāhmaṇa (1.2.1.2): “La torta puroḍāśa è la testa del sacrificio: infatti quei frammenti di mattone (kapālāni) sono ciò che sono le ossa del cranio (śīrṣṇaḥ kapālāni), e il riso macinato non è altro che il cervello” (cfr. Eggeling, 1885, xxviii). Quando la vittima umana viene uccisa, il suo succo (rasa) fluisce nella terra, dove cresce il riso con cui si preparano i dolci puroḍāśa. Nello yajurveda bianco, le teste delle cinque vittime dell’agnicayana sono conservate nel sacrificio, ma i corpi sono gettati nell’acqua che viene mescolata con l’argilla con cui sono fatti alcuni dei mattoni per l’altare.
La tesi di Rönnow, secondo cui questi sacrifici riflettono una religione “asurica”, si basa principalmente su testi del periodo brāhmaṇa. Nel rituale śrauta classico c’è il divieto di utilizzare alcune parti della vittima animale, come la testa. Questo è spiegato dal śatapatha brāhmaṇa 3.8.3.29: “Gli asura hanno fatto porzioni della testa, delle spalle, del collo e delle zampe posteriori; quindi non si faccia porzioni di queste!”. Secondo Rönnow, la decapitazione della vittima era la forma di sacrificio tipica tra i nativi pre-vedici “asurici”. Queste pratiche furono allineate alle usanze brahmaniche quando furono incorporate nel rituale classico. Nel pravargya e nell’agnicayana sopravvive la tendenza a conservare il corpo della vittima, in modo che il sacrificatore possa assorbirne il potente succo rasa. Questo liquido viene successivamente collegato e identificato con le bevande sacrificali come il soma e il gharma, il latte bollito del pravargya.
Estendendo queste idee al rituale di sautramaṇī, Rönnow giunse alla conclusione che si possono distinguere tre fasi nello sviluppo del primo rituale indiano. Le prime due sono pre-vediche: (1) un rituale relativo a namuci (secondo il ṛgveda, un demone ucciso da indra e dagli aśvin), caratterizzato da un sacrificio umano in cui si beve il sangue viene bevuto insieme alla surā alcolica; (2) un rituale in cui fanno la loro apparizione le nuove divinità sarasvatī e gli aśvin e durante il quale si consumano latte e miele; e infine (3) un rituale vedico-brahmanico, in cui il soma è la bevanda rituale.
La tesi di Rönnow, secondo cui gli asura rappresenterebbero una religione indiana pre-vedica, non è stata generalmente accettata. La ragione di tale scetticismo è semplice: in origine, gli asura erano chiaramente esseri indo-iraniani, chiamati ahura in Iran. In indo-iranico, come nel più antico ṛgveda, gli dèi (deva, in iraniano daeva) e gli asura / ahura sono più o meno alla pari. In Iran prevalevano gli asura. Nei Veda, i Deva prevalgono e gli asura diventano loro nemici. Nonostante l’origine indo-iranica della parola asura, è quindi possibile che Rönnow abbia ragione e che i riferimenti agli asura nella letteratura vedica più tarda indichino pratiche e credenze indigene e pre-vediche. Accetterò questa come ipotesi di lavoro, perché ha senso, come vedremo.
Mus (1935) ha trattato l’agnicayana nelle prime parti di una monografia che porta a un’interpretazione di Borobudur, il monumento buddista di Java. Secondo Mus, il mito dello smembramento di puruṣa/prajāpati non è di origine ārya. Non ci sono riferimenti ad esso nei Veda precedenti, ma è comune “nell’etnografia religiosa del Sud-Est asiatico e delle sue dipendenze nel Pacifico”. Mus osserva anche che è “attestata, parallelamente al mito, la pratica di mettere a morte un essere umano per il profitto collettivo di coloro che lo hanno offerto, un sacrificio che è seguito da uno smembramento, o addirittura dallo smembramento della vittima mentre è ancora viva”. E aggiunge:
È nota la forma crudele che il sacrificio di meriah assumeva, poco più di un secolo fa, presso alcune tribù primitive dell’India. L’uomo veniva legato al palo e ognuno gli strappava un pezzo di carne finché non ne rimaneva più nulla. Poi i partecipanti andavano a seppellire la propria parte nel loro campo migliore (Mus 1935, *116).
Così il sacrificio, impregnando la terra con parti della vittima umana, contribuiva alla fertilità del suolo.
Mus vede tracce di queste idee e pratiche in una grande varietà di contesti. Uno di questi è la credenza nelle reliquie. Nel buddismo si attribuisce molta importanza alla distribuzione delle reliquie del Buddha e alla loro deposizione in uno stūpa. Il Buddha è identificato con queste reliquie e con lo stūpa, così come nell’agnicayana lo yajamāna è identificato con l’uomo d’oro e con l’altare stesso. Le cronache singalesi si riferiscono alle reliquie come alla vita (jīvita) della stūpa (Mus 1935, 75-77). La diffusione delle immagini del Buddha, e di fatto l’origine stessa del culto degli idoli, potrebbe avere origine in questo contesto.
Nell’agnicayana, una tartaruga viva (kūrma) viene seppellita sotto l’altare. Dumont (1957, 16-18) ha dimostrato che la tartaruga è stata scelta come simbolo dei tre mondi (terra, cielo e atmosfera) a causa della sua forma a cupola. La tartaruga era inoltre considerata come il succo o la linfa vitale (medhā nella taittirīya saṃhitā 5.2.8.5, erroneamente tradotto da Keith come se dicesse medha, “intelligenza”) della terra: quando prajāpati creò la terra e la gettò nelle acque, il succo che ne scaturì divenne una tartaruga.
Biardeau (1976, 18) ha ricordato che l’importanza della tartaruga (kūrma) risiede anche nella sua presunta connessione etimologica con il verbo kṛ “fare, realizzare” (cfr. śatapatha brāhmaṇa 7.5.1.5-6). Un altro termine per indicare la tartaruga, kaśyapa, è un nome di prajāpati. Ruben (1939, 241-243) ha fatto riferimento a numerose leggende delle tribù indiane, ma anche dell’Asia centrale e della Cina, in cui la tartaruga viene descritta come sostegno del mondo e collegata alla sua origine. In tempi successivi, la tartaruga divenne un avatara di viṣṇu, e nel mito del rovesciamento dell’oceano mondiale, il bastone o l’asse del mondo poggia su una tartaruga (cfr., ad esempio, Gonda 1954, 126-129). Nella bhagavad gītā (2.58), il saggio viene descritto mentre ritira i suoi sensi dagli oggetti esterni come la tartaruga ritira i suoi arti. Sembra probabile, in base a quanto abbiamo visto prima, che la forma di vita della tartaruga sia un resto della linfa vitale o del sangue della vittima sacrificale che fertilizza il terreno. Le indagini di Ruben (1939) sono per molti aspetti simili a quelle di Rönnow (1929), al quale non fa riferimento. Ruben si è spinto oltre e ha suggerito che gli asūr, una tribù che oggi vive nell’India centrale, possano essere ricondotti a tribù più antiche con nomi simili che gli indiani vedici interpretarono come riferiti agli asura. Questo potrebbe aver portato allo sviluppo degli asura indo-iraniani negli asura demoniaci dei tempi successivi. Improbabile, senza dubbio, ma non impossibile.
Macdonald (1952 = 1975) ha collocato le idee di Mus in una prospettiva più ampia, fornendo ulteriori prove etnografiche provenienti dall’Asia meridionale, sudorientale, orientale e centrale. Ha anche sottolineato che la vittima maschile è simbolicamente accoppiata alla terra femminile. Ciò è supportato dai primi riferimenti vedici a un cinghiale sacrificale che si accoppia con la terra, il che è coerente con il fatto che puruṣa/prajāpati è maschio, come la maggior parte delle vittime animali (non è supportato dal romantico frontespizio di una vittima femminile in Campbell 1864). Riferendosi al lavoro di Verrier Elwin, Macdonald ha richiamato l’attenzione sul fatto che il palo a cui veniva legata la vittima di meriah era biforcuto e che “la testa della vittima veniva talvolta tirata indietro attraverso la forcella” (cfr. Camp bell 1864, 113). Secondo Maconald questa forma rappresenta il sesso femminile. Lo sostiene, ad esempio, la pratica degli Angami Nagas, come riportato da Hutton (1921, 231-232), che “diffondono la prosperità” per mezzo di due pali, uno biforcuto e uno dritto, “il primo rappresenta “gli organi riproduttivi della donna e l’altro l’organo maschile”” (Mac donald 1952, 333 = 1975, 6). Si può notare che il sacrificio animale vedico richiede forchette a una punta (eka-śūla) e a due punte (dvi-śūla). Macdonald ritiene che il mito dello smembramento non sia, o non sia semplicemente, un rito agrario, come aveva suggerito Mus, ma che risalga a un periodo precedente l’inizio dell’agricoltura. Descrive o fa riferimento a vari rituali in cui la vittima animale viene ripartita tra i membri della comunità in modo da stabilire o ristabilire la posizione di ciascun membro nella gerarchia sociale:
L’animale sacrificato era senza dubbio quello catturato durante la caccia. La carne, il prodotto per eccellenza della caccia, era un bene raro per molti membri della comunità primitiva; il fatto che la spartizione di questo bene avvenisse in modo diseguale non sorprende affatto. L’uomo forte, il cacciatore esperto, il sacerdote dalle cui attività dipende il regolare susseguirsi delle stagioni, il costruttore di armi o di strumenti, non riceveranno la stessa porzione dell’adolescente non qualificato. . . . prajāpati è il maschio; la caccia è essenzialmente l’occupazione, l’attività dei maschi della comunità. Sono i maschi a fissare i ranghi in questi momenti di incontro che sono segnati dai banchetti comunitari (Macdonald 1952, 335, 338 = 1975, 7,8).
Se Macdonald ha ragione, questo non solo fornirebbe lo sfondo per il ṛgveda 10.90.12, in cui le caste derivano da parti del puruṣa primordiale, ma getterebbe luce su molti modelli di distribuzione gerarchica, tra lo yajamāna e i suoi sacerdoti, di offerte e oblazioni di parti della vittima animale, di torte sacrificali e di bevande sacrificali come il soma. Anche la dakṣiṇā o “dono sacrificale” è distribuito gerarchicamente: i quattro sacerdoti principali (hotā, adhvaryu, brahman, udgātā) ricevono il doppio rispetto ai quattro successivi (maitrāvaruṇa, pratiprasthātā, brāhmaṇācchaṃsin, prastotā), che a loro volta ricevono il doppio dei quattro successivi (acchāvāka, neṣṭā, āgnīdhra, pratihartā), che ricevono il doppio dei quattro rimanenti (grāvastut, unnetā, potā, subrahmaṇya). Lo yajamāna si fa carico del costo del rituale, che i sacerdoti eseguono per suo conto. Nei rituali sattra lo yajamāna è stato eliminato e i sacerdoti eseguono i riti tra di loro. In tempi recenti, quando viene eseguito un rituale di soma, la relazione tra lo yajamāna e i suoi sacerdoti è come quella che si trova in un rituale sattra: tutti sono scelti dallo stesso gruppo di vaidika, e i ruoli possono essere distribuiti in modo diverso in una performance successiva. Si tratta di un’istituzionalizzazione della distribuzione ciclica della ricchezza, che Heesterman (1959) considerava caratteristica della dakṣiṇā.
Malamoud (1976, 197-198) ha richiamato l’attenzione su un’altra caratteristica della dakṣiṇā: l’analogia tra una performance rituale e un trattamento medico, in particolare la psicoanalisi. Il rapporto tra lo yajamāna e i suoi sacerdoti è analogo a quello tra un paziente e il suo analista. In entrambi i casi, è necessario il pagamento delle quote, senza il quale la performance potrebbe non concludersi. Come sottolineava Freud, il trattamento gratuito produce un aumento della resistenza. Allo stesso modo, senza dakṣiṇā il rituale sarebbe incompleto.
Heesterman (1967) non respinge le conclusioni di Rönnow riguardo all’agnicayana e al sacrificio umano che ne è alla base, ma le colloca in una prospettiva diversa. Secondo lui ci sono diverse contraddizioni insite nei rituali śrauta, alle quali i manuali hanno dato varie soluzioni. Cercando le origini di queste contraddizioni possiamo ricostruire in parte un rituale “preclassico”. All’inizio dell’agnicayana, per esempio, si parla della preparazione delle cinque teste, ma ci sono anche le alternative del sacrificio di una capra per prajāpati o per vāyu. Nel rituale preclassico, gli animali (compresa la vittima umana) venivano macellati, mentre nel rituale classico le vittime devono essere uccise per strangolamento fuori dal recinto sacrificale. Il fatto che gli animali venissero originariamente macellati nel momento in cui venivano legati al palo sacrificale deriva dai riti di espiazione prescritti nel caso in cui il sangue fosse stato erroneamente versato sul palo. Il ṛgveda l.162.9, inoltre, fa riferimento a porzioni di carne attaccate al palo.
Forse il modo particolare in cui l’animale viene legato al palo va nella stessa direzione: la corda viene fissata al piede destro, passa intorno al lato sinistro del collo e viene poi avvolta intorno al corno destro e infine fissata al palo. In questo modo si lascia spazio al coltello del macellatore (Heesterman 1962, 18).
Secondo Heesterman, in questi casi la preoccupazione è quella di rimuovere ciò che è impuro e infausto dal luogo del sacrificio (ibid., 19) e di creare un mondo idealmente ordinato di sacrifici razionalizzati (1967, 43), impermeabile alla morte.
Conclusioni più specifiche possono essere tratte dai riti introduttivi dell’agnicayana. Secondo lo śrauta sūtra di baudhāyana, la testa del vaiśya deve essere ottenuta in battaglia, in altre parole, è la testa di un nemico conquistato in battaglia. Quando si deve ottenere l’argilla per la preparazione del vaso di ukhā, una processione si avvia verso la cava di argilla. Lungo la strada si imbattono in un formicaio con un vaiśya appostato a sud per sorvegliarlo. L’argilla che cercano, in cui si suppone sia nascosto agni, viene chiamata puriṣa, un termine legato al bestiame (cfr. anche Gonda 1965a, 224-225). Secondo Heesterman, è qui che si tocca “il fondo della realtà”. Il vaiśya o il rivale non sorveglia tanto un formicaio o una fossa di terriccio, per quanto importante sia il loro valore simbolico, ma la sua stessa testa, il suo bestiame e i suoi campi” (1967, 40). In realtà, la frase di baudhāyana “lo custodisce (cioè il formicaio) da sud” (tāṃ dakṣiṇato gopāyann āste) potrebbe essere interpretata come: “si mantiene a sud di esso agendo come un mandriano” (ibid. nota 52a). In altre parole, torniamo alle razzie di bestiame e alle simili spedizioni di razzia dei nomadi vedici, di cui si è parlato in precedenza (sopra, pp. 97-105; cfr. Vol. II, p. 485).
Il gruppo dei vaiśya, il cui dominio è chiamato viś, è composto principalmente da agricoltori e allevatori di bestiame. In contrapposizione, i kṣatriya o rājanya, il cui dominio è kṣatra, rappresentano i militari, la nobiltà e il potere secolare.
Mylius (1974) ha richiamato l’attenzione su un gran numero di passaggi della letteratura brāhmaṇa e rituale in cui i vaiśya sono descritti come il principale oggetto di sfruttamento: sono ādya, “da mangiare”. I loro principali sfruttatori (attṛ) sono gli kṣatriya, assistiti dai bramini. Ad esempio: “la viś è cibo per glii kṣatriya” (śatapatha brāhmaṇa 3.3.2.8); “lo stato (rāṣtra) mangia la viś” (13.2.9.8); “egli pone il mestolo di juhū in alto e gli altri mestoli di sruc in basso, perché juhū. è il kṣatra e gli altri mestoli di sruc sono la viś. Così rende il kṣatra superiore alla viś” (1.3.4.15); “pone il soma sulle pietre di pressatura; il soma è il kṣatra e le pietre di pressatura sono la viś. Così egli fa sì che kṣatra sia superiore a viś” (3.9.3.3.); ecc.
Ci sono anche passaggi che affermano esplicitamente che i bramini cercavano di mettere kṣatra e viś l’uno contro l’altro, ad es: “Un’offerta su undici cocci per indra e su sette cocci per i marut dovrebbe essere fatta da qualcuno che vuole creare conflitti tra viś e kṣatra” (maitrāyaṇī saṃhitā 2.1.9).
A partire dall’Uomo cosmico, abbiamo trovato nozioni di sacrificio umano legate all’agnicayana. Nel caso della testa del vaiśya, l’uccisione non è sacrificale, ma riflette semplicemente le consuete incursioni e spedizioni dei nomadi vedici. È possibile che la nozione di sacrificio umano sia intrinsecamente legata allo smembramento di un gigante primordiale. Sauvé (1970) ha dimostrato che le due cose ricorrono insieme nella mitologia indiana e scandinava. Ma il sacrificio umano in Scandinavia, come descritto da Sauvé, è quasi totalmente diverso dal sacrificio vedico. Non c’è quindi alcuna ragione convincente per far derivare entrambi da un prototipo indoeuropeo. Non sorprende che gli studiosi vedici siano riusciti a mettere insieme puruṣa e prajāpati a partire dal materiale vedico precedente. Si tratta di un esercizio di genuinità, almeno in parte. I Veda stessi non sono isolati; siamo noi che ignoriamo la maggior parte del loro contesto e dei loro dintorni. La comparsa relativamente tardiva del puruṣasūkta nei ṛgveda e la diffusa presenza di nozioni di sacrificio umano nell’Asia meridionale e sudorientale supporterebbero ugualmente l’ipotesi che l’Uomo cosmico sia un fenomeno pre-vedico. Più probabile di queste due teorie è l’ipotesi che i nomadi vedici e gli indiani pre-vedici avessero ciascuno una nozione di Uomo cosmico le cui caratteristiche potrebbero essere state combinate nell’agnicayana. Allo stato attuale delle nostre conoscenze sarebbe azzardato cercare di trarre una conclusione più precisa.
I collegamenti tra il puruṣasūkta e l’agnicayana spiegano l’importanza del numero 1.000 nella costruzione dell’altare di fuoco. Secondo gli śūlba sūtra, che trattano specificamente della costruzione dell’altare, si dovrebbero usare 1.000 mattoni per la costruzione dell’altare alla prima rappresentazione di un agnicayana. Questo altare viene poi impilato in cinque strati di 200 mattoni ciascuno. Il numero cinque era già un numero importante, e l’agnicayana sembra averlo reso ancora più importante. I gruppi di cinque sono molto diffusi nei veda e nell’induismo classico (si veda, ad esempio, Knipe 1972, 28-32; 1975, 1-7). La costruzione dell’altare, tuttavia, è un argomento a sé stante e merita una sezione a parte.
Prima di affrontare la costruzione del grande altare in mattoni a forma di uccello che è il segno distintivo del rituale agnicayana, torniamo ancora una volta alla cultura dei nomadi indo-iraniani prima del loro ingresso nel subcontinente indiano. La descrizione di Mary Boyce è suggestiva:
La religione indo-iranica si è formata, a quanto pare, nel corso di millenni di vagabondaggio nelle steppe dell’Asia interna e, di conseguenza, era materialmente di estrema semplicità. Il culto veniva offerto agli esseri divini senza l’ausilio di templi, altari o statue, e tutto ciò che serviva per solennizzare gli alti rituali era un pezzo di terra pulito e piatto, che poteva essere delimitato da un solco ritualmente tracciato. Le offerte consacrate in quel luogo erano fatte non solo agli dei invisibili, ma anche al fuoco e all’acqua, che potevano essere rappresentati correttamente dal fuoco domestico e dalla sorgente domestica più vicina, anche se un fuoco rituale era sempre presente all’interno del recinto stesso, bruciando in un basso braciere. (Il fuoco era posto in un contenitore basso all’interno del recinto rituale perché il sacerdote celebrante stesso sedeva a terra a gambe incrociate). A giudicare dalla pratica successiva, questo fuoco rituale veniva acceso per l’occasione, oppure era costituito da braci portate dal focolare più vicino. L’unico fuoco a fiamma continua conosciuto dagli indo-iraniani era evidentemente il fuoco del focolare, acceso quando un uomo costruiva la sua casa e mantenuto acceso finché viveva, una divinità all’interno della casa. Era curato con cura e riceveva regolarmente una triplice offerta di legna secca, incenso e grasso dell’animale sacrificale. Questo fuoco domestico poteva essere facilmente trasportato in una pentola durante le peregrinazioni nomadi, per continuare a bruciare ovunque la famiglia piantasse la sua tenda (Boyce 1975, 455).
Molte caratteristiche di questa descrizione sono ancora applicabili al rituale vedico. A parte i suoi elaborati altari, l’agnicayana include semplici riti che richiedono oblazioni fatte in un fuoco installato su una semplice pezzo di terreno ritualmente delimitato. (vedi foto 4) Una questione interessante riguarda la forma di questi altari di terra indo-iraniani, e in particolare se fossero quadrati o rotondi. Come abbiamo visto, il contrasto tra un altare domestico rotondo e un altare per le offerte quadrato si ritrova tra gli indiani vedici, gli iraniani e anche i romani (sopra a pagina 93). I Greci avevano un altare domestico rotondo, generalmente di piccole dimensioni, sul quale venivano fatte offerte di miele e latte, e un altare quadrato, generalmente di grandi dimensioni, utilizzato per i sacrifici di animali.

Prima di costruire gli altari, i nomadi iraniani installavano il fuoco su un terreno pianeggiante, dopo aver dissodato il terreno e averlo delimitato ritualmente. L’agnicayana include le oblazioni nei fuochi installati in questo modo semplice. Nella foto 4 lo yajamāna versa del burro nel fuoco dal suo mestolo juhū durante il sacrificio animale per vāyu il primo giorno (episodio 2). Il fuoco è il “fuoco della nuova offerta”, installato all’estremità orientale dello spazio del Grande Altare (mahāvedi). Sono visibili parti della sagoma a forma di trapezio del mahāvedi. Il “vecchio fuoco dell’offerta”, che arde su un altare di argilla, è sullo sfondo (si vedano anche le figure 3 e 22).
La rotondità dell’altare domestico è stata messa in relazione con il grembo materno. L’altare circolare rappresentava la permanenza, l’immutabilità e la casa. In quanto immobile, era considerato il principio del movimento (Vernant 1965, 99, 122, 142-143), come il dio di Aristole, “il primo motore immobile”.
L’altare domestico greco era spesso curato dalle donne ed era sacro a una dea, Hestia (εστία, “focolare”). L’altare quadrato, che è anche il focolare del fabbro, è legato al dio maschile Hephaistos, in origine un demone del fuoco dell’Asia Minore. Nel rituale vedico, l’altare domestico rotondo è anche paragonato a un grembo materno, mentre l’altare sacrificale quadrato rappresenta il mondo appena creato per gli dèi. Tutti questi fatti sembrano collegati e ammettono una generalizzazione. Mentre il rotondo e il quadrato - come forme di altari, templi, case e città - si trovano separatamente o in varie combinazioni in tutto il mondo (si veda, ad esempio, Seidenberg, di prossima pubblicazione), il contrasto specifico tra altari rotondi e quadrati è con ogni probabilità indoeuropeo.
I tumuli (smaśāna) dell’epoca vedica potevano essere quadrati o rotondi (Caland 1896, 141). La forma quadrata sembra essere stata quella preferita. Secondo il śatapatha brāhmaṇa (13.8.1.5; cfr. 13.8.2.1), i tumuli delle persone divine (daivyaḥ prajāḥ) sono a quattro angoli (catuḥ-srakti), mentre quelli degli “asura, orientali e altri” sono rotondi (parimaṇḍala). Il quadrato o quadrangolo sembra quindi essere la forma vedica, il tondo quella degli abitanti originari. È stato suggerito che la forma circolare, “nativa”, sopravviva negli stūpa rotondi del buddismo, che sono tumuli sepolcrali nella misura in cui contengono reliquie. La preferenza vedica per la sepoltura quadrata potrebbe essere legata al background centro-asiatico dei nomadi vedici. Anche nell’Asia settentrionale, dove il cadavere è posto su una piattaforma, questa è quadrata o almeno rettangolare. Tra i popoli altaici, che eseguono un sacrificio di cavalli, le ossa del cavallo sono poste su una piattaforma quadrata (Nachtigall 1953, 54). Altrove troviamo un misto di fosse funerarie quadrate e circolari (come tra i Lepcha nel Sikkim: Nebesky de Wojkowitz 1951, 31). Ma tutto questo dovrebbe solo metterci in guardia sul fatto che questi parallelismi non possono essere presi troppo sul serio. L’altare principale dell’agnicayana funziona sotto diversi aspetti come una tomba: l’uomo d’oro e le cinque teste delle vittime sacrificali sono sepolte sotto di esso. Nell’altare dell’agnicayana, il quadrato prevale decisamente sul cerchio. I mattoni sono quadrati o hanno forme derivate dal quadrato, come rettangoli e triangoli (vedi Figura 9 a pagina 198). È possibile che un’eco di mattoni rotondi sopravviva nei cosiddetti maṇḍaleṣṭakā, “mattoni a cerchio”, ma questi sono generalmente considerati mattoni su cui è inciso o disegnato un cerchio. Nella rappresentazione del 1975 si trovavano nel primo, terzo e quinto strato, uno sopra l’altro. I cerchi composti da quadrati sono presenti nell’altare di agnicayana in due modi. Nella parte centrale del primo, terzo e quinto strato dell’altare a forma di uccello, i mattoni possono essere disposti a forma di cerchio. Questo è descritto nel śatapatha brāhmaṇa (per le illustrazioni si veda Eggeling 1897, IV, 17, 48 e 98). Oppure, come forma speciale, l’intero altare può essere costruito a forma di ruota di carro (rathacakra; per le illustrazioni si veda van Gelder 1963, 311, 313). Come vedremo, l’altare può anche essere costruito a forma di uccello “quadrato” (pīṭhan) (cfr. volume II, pagine 351-357).
La predominanza del quadrato nell’altare principale dell’agnicayana deriva dalla quadratura (squareness) dell’altare delle offerte. La rotondità è il segno distintivo dell’altare domestico. Sembra contraddittorio che nell’agnicayana il nuovo altare domestico sia costruito in forma quadrata, ma non è difficile da spiegare. Nei rituali śrauta più complessi, la sfera domestica si è ritirata ulteriormente sullo sfondo. Più si sale nella gerarchia dei rituali, più le caratteristiche śrauta diventano predominanti e quelle gṛhya più recessive. Il nuovo altare domestico dell’agnicayana, seguendo questa tendenza, è diventato un quadrato.
È chiaro che non sarebbe corretto affermare che i nomadi vedici avessero solo altari quadrati. Essi consideravano il quadrato più sacro e ne facevano la forma dell’offerta e dell’altare divino. Il loro altare domestico circolare, tuttavia, presentava la forma di base. Ciò è in accordo con i dati di altre culture indoeuropee ed è evidente dal rituale. Ad esempio, il fuoco per l’altare dell’offerta quadrato viene acceso dall’altare domestico circolare. È possibile che gli indiani pre-vedici avessero altari circolari, nel qual caso i nomadi vedici ottennero due punti allo stesso tempo quando iniziarono a costruire il loro nuovo altare domestico a forma di quadrato: da un lato si spostarono ulteriormente nella sfera divina, dall’altro misero gli abitanti indigeni più in basso. Queste mosse a doppio taglio sono abbastanza coerenti con il carattere generale del rituale vedico.
Nel ṛgveda sono menzionati tre altari, ma la forma di un altare è menzionata solo una volta, e indirettamente. ṛgveda 10.114.3 è un indovinello che menziona una ragazza con quattro ciuffi (catuṣkaparda) che ha la faccia di burro (ghṛtapratīka). La menzione del burro chiarisce che ci si riferisce a un fuoco (cfr. ṛgveda 5.11.1, sopra pag. 74), e l’indovinello implica che l’altare su cui era installato questo fuoco era quadrangolare (cfr. Potdar 1953, 73). Il fatto che il ṛgveda non faccia esplicito riferimento ad altari rotondi non può ovviamente essere interpretato come un’argomentazione per cui non esistevano tali altari nel periodo ṛgvedico. Alla luce degli sviluppi successivi, è più probabile che si intendesse che l’altare domestico fosse circolare.
Il śatapatha brāhmaṇa 13.8.2.1 è un altro passaggio che contrappone i tumuli dei nomadi vedici a quelli degli abitanti originari. In esso si afferma che i primi sono vicini al terreno, mentre i secondi sono separati dal terreno “su un camū o qualcosa di simile”. Eggeling considera il camū come “una base di pietra bassa o un abbeveratoio, solido o costituito da muratura (mattoni) alla maniera delle nostre tombe rivestite di pietra” (1900, V, 430, nota 1). Tuttavia, il termine camū indica generalmente un recipiente o una pentola. Sembra più probabile che questo camū fosse usato come bara, nel qual caso il riferimento è alle sepolture in urna. Sepolture a urna preistoriche sono state trovate in diverse parti del subcontinente indiano (si veda, ad esempio, Longhurst 1936, 9-10 e Figura 8). Poiché il funerale vedico prevedeva la cremazione, esisteva un’area in cui veniva installato il fuoco. Se questo è il luogo specificamente descritto come vicino al suolo, sembrerebbe che i nomadi vedici non avessero raggiunto quello stadio di sviluppo in cui il fuoco viene installato a una certa altezza in modo da beneficiare delle correnti d’aria. Questo corrobora ulteriormente l’immagine dell’altare indo-iranico come semplice pezzo di terra delimitato.
Esiste un divario molto ampio tra i semplici altari degli indo-iraniani e del ṛgveda e quelli descritti nello yajurveda. I testi dello yajurveda descrivono l’altare per l’agnicayana come un’enorme struttura impilata con almeno un migliaio di mattoni cotti al forno. Il termine usato per indicare i mattoni, iṣṭaka o iṣṭika, compare per la prima volta nella taittirīya saṃhitā e si ritrova successivamente negli altri rami e testi dello yajurveda. In questi testi troviamo anche elaborati riferimenti alla cottura del vaso ukhā, che non è menzionata in nessun testo precedente. La taittirīya saṃhitā 4.1.6 fornisce i mantra che accompagnano i riti durante i quali il vaso viene modellato con l’argilla e affumicato, dopodiché viene scavata una fossa, il vaso viene posto al suo interno, coperto dal fuoco e cotto per tre giorni. Tutte queste cose sono fatte, secondo i mantra, “alla maniera di aṅgiras” (aṅgirasvat). Il baudhāyana śrauta sūtra 10.6 (vedi Volume II, pagina 495) afferma che un secondo e un terzo vaso ukhā (ovviamente di riserva), cinque mattoni chiamati ṛṣabha (“toro”) e tre mattoni chiamati maṇḍaleṣṭaka (i mattoni già citati, che hanno un cerchio inciso o disegnato sulla superficie) devono essere trattati allo stesso modo. I termini dhūpayate (“fumigare”) e sudhūpita (“ben fumigato”) compaiono per la prima volta in questo contesto. Il verbo usato per “cuocere”, pacati, è comune dal ṛgveda in poi per cucinare, cuocere, arrostire o bollire, ma è usato per la prima volta in questi contesti yajurvedici per la cottura dei mattoni. Il senso tecnico di “fumigare” non è chiaro, a meno che non si riferisca alla riduzione (cfr. Saraswati e Behura, 1966, 128-129).
In un importante articolo, Converse (1974) ha sostenuto la tesi dell’autoctonia indigena della costruzione agnicayana, perché l’arte di cuocere i mattoni, sconosciuta ai nomadi vedici, era praticata dai ben più antichi Harappani:
Gli Harappani usarono milioni di mattoni cotti in forno e innumerevoli mattoni cotti al sole…. I mattoni della civiltà Harappa nella sua fase matura erano di ottima fattura, ben cotti e di dimensioni standardizzate. La dimensione di base dei mattoni era di 11,5 pollici di lunghezza, 5,3/4 pollici di larghezza e due o tre pollici di spessore. Esistevano anche mattoni doppi di 11 pollici quadrati e mattoni speciali per le coperture dei pozzi, per gli scarichi, per gli angoli, ecc. Ora, in tutto il ṛgveda non c’è alcuna parola per mattone, né alcuna frase descrittiva per i mattoni. Finora non sono state trovate rovine di abitazioni in mattoni che possano essere attribuite agli ārya all’inizio del periodo ṛgvedico. I riferimenti ṛgvedici alle case indicano che erano fatte di legno deperibile e paglia. I mattoni non facevano quindi parte delle realizzazioni tecniche o rituali dei ṛgvedici. Non ci sono riferimenti ai mattoni nemmeno nei brāhmaṇa del ṛgveda e, al di fuori delle sezioni agnicayana del saṃhitā e dei brāhmaṇa della tradizione yajurveda, non ci sono riferimenti significativi ai mattoni in questi o nei brāhmaṇa del sāmaveda. Così, nei brāhmaṇa, quando iniziano a comparire riferimenti ai mattoni, il loro uso è limitato a un rito specializzato, e il rito stesso si trova solo nella tradizione yajurveda. Gli altari di fuoco negli altri riti erano fatti di terra imballata, non di mattoni. La dimensione dei mattoni da utilizzare nel rito era di un piede quadrato, e dovevano essere utilizzati anche mezzi mattoni (SB vii, 5,3,2; viii, 7,2,17). Queste dimensioni e forme corrispondono molto da vicino a quelle dei mattoni di Harappa descritti in precedenza. L’assenza di mattoni nella prima tradizione vedica e la presenza di mattoni in gran numero e delle stesse dimensioni nell’adiacente territorio indigeno della Black-and-Red Ware suggeriscono che la cultura Black-and-Red Ware sia la fonte delle abilità di fabbricazione dei mattoni di agnicayana. Anche la parola “mattone” suggerisce un’origine probabilmente non ārya. Come parola sanscrita, iṣṭakā si riferisce all’uso rituale dei mattoni come oblazione, un iṣṭi, e non al loro carattere generale come materiale da costruzione. Ciò suggerisce che i mattoni siano entrati nell’uso vedico grazie a questa funzione rituale, piuttosto che alla loro consueta funzione edilizia. Al contrario, le parole “mattone” nelle lingue dravidiche come il tamil sono descrittive dell’uso primario dei mattoni per la costruzione. Per esempio, una parola tamil per mattone è cengal; cennu significa rettilineità e kal o gal significa pietra o argilla. Un’altra parola tamil per mattone bruciato (cotto) è cuṭakal, suṭakal; ancora una volta kal significa argilla o pietra, e cuṭu, suṭu significa bruciare, cuocere, bruciare mattoni. È possibile che una prima forma di suṭakal sia stata la base fonetica straniera di ciò che viene sanscritizzato in iṣṭakā: un’inversione (non rara nell’incorporazione di parole dravidiche in sanscrito) di s e la u, e l’abbandono della forma finale l come conforme alle terminazioni sanscrite, darebbe uṣṭaka; l’uso dei mattoni come iṣṭi tenderebbe a portare al cambiamento dalla u iniziale (non comune in sanscrito) alla più comune i. Qualunque fosse la parola di partenza, era il significato sanscrito della traslitterazione approssimativa della parola indigena a essere enfatizzato, e questa parola sanscrita, iṣṭaka, non riflette in alcun modo la funzione costruttiva dei mattoni, ma solo il loro uso rituale (Converse 1974, 83-85).
Le argomentazioni archeologiche di Converse sono forti. Va notato, tuttavia, che le dimensioni dei mattoni, pur avendo forse in pratica i lati di più o meno mezzo piede, un piede o un piede e mezzo di lunghezza, non era una misura assoluta, ma relativa alla taglia del sacrificatore. Questo è chiaro dalla letteratura sūtra e viene menzionato nel śatapatha brāhmaṇa (10.2.2.6): “Misura l’altare dal sacrificatore con le braccia tese”.
Le argomentazioni linguistiche di Converse sono meno forti delle prove archeologiche e richiedono qualche commento. Un’origine dravidica per l’iṣṭakā è improbabile o impossibile su basi etimologiche (Emeneau, comunicazione personale; Emeneau sottolinea anche che ceṅ-kallu significa “pietra rossa”). Inoltre, l’iṣṭakā non è solo indiana, ma anche indo-latina. Il Dizionario Etimologico di Mayrhofer riporta il corrispondente iraniano ištya con lo stesso significato, “mattone”. Questo termine è attestato solo due volte (Martin Schwartz, comunicazione personale): entrambe le occorrenze sono nel videvdād (vendidad), 8.8 e 8.10, un testo tardo avestano, non anteriore al III secolo a.C. In entrambi i testi, i mattoni o la polvere dei mattoni o delle pietre sono usati per coprire un cadavere, non per la costruzione di un tumulo funerario, ma per proteggerlo temporaneamente, in caso di maltempo, prima di darlo agli uccelli e agli altri animali. Anche nell’antico persiano išti ricorre e significa “mattone” (presumibilmente essiccato al fuoco). Si trova, ad esempio, in un’iscrizione di Dario da Susa (frammento 29). Si riferisce ai mattoni utilizzati per la costruzione del palazzo di Dario. L’iscrizione ci informa che i babilonesi erano impiegati come fabbricanti di mattoni. Anche nel persiano moderno sono comuni i derivati dalla stessa radice.
In iraniano, quindi, il termine “mattone” è usato in senso generale e non è limitato alla costruzione di un altare o a un uso sacro. Ciò non invalida l’opinione di Converse secondo cui iṣṭakā nei testi dello yajurveda si riferisce solo ai mattoni rituali. Nella cultura vedica, i mattoni non venivano mai utilizzati per la costruzione di edifici ordinari: l’emploi en est limité à l’“empilement” de l’autel du feu (agnicayana) – et accessoirement des dhiṣṇya (“foyers”) annexes (Renou 1939, 504, nota 1). Nell’architettura indiana (vāstuvidyā), i mattoni compaiono solo molto più tardi (Bhattacharyya 1948, 249-258).
Il termine “mattone” potrebbe essere stato preso dagli indiani dagli iraniani, o dagli iraniani dagli indiani, o da entrambi da una fonte precedente. È possibile che sia derivato da una radice indo-iranica, ma è lecito dubitarne. Il termine iṣṭi, che indica l’oblazione rituale di una sostanza vegetale e i riti che l’accompagnano (vedi sopra, pagg. 46-48), deriva dalla radice yaj-, “sacrificare, compiere un rito”, con il participio passato passivo iṣṭa, “sacrificato”. Il śatapatha brāhmaṇa 6.2.1.10 adotta questa etimologia per iṣṭaka: “In quanto li ha visti sacrificare (iṣṭvā) sono chiamati mattoni (iṣṭakā)”. La radice iṣ-, “desiderare”, ha anche un participio passato passivo iṣṭa, “desiderato, gradito, gradevole”. Quindi iṣṭakā potrebbe alternativamente derivare da iṣ-, “desiderare”, nel qual caso potrebbe indicare un oggetto desiderato, ad esempio una “pietra dei desideri” (come il nostro “osso dei desideri”). Ciò è in accordo con un’importante caratteristica dei mattoni dell’agnicayana: non appena l’altare è completato, lo yajamāna cosìdesidera che i mattoni si trasformino in mucche, dicendo: “agni, che questi mattoni siano mucche per me” (me agna iṣṭakā dhenavaḥ santu: taittirīya Saṃhitā 4.4.1l.3p.) (FOTO 80) Se si ritenesse che questa sia l’importanza principale dei mattoni, essi verrebbero chiamati iṣṭakā, perché sono esauditori di desideri. Ciò si ricollega a un tema comune nei Vedici e nell’Induismo, dove kāmadhenu, “Mucca dell’abbondanza”, soddisfa tutti i desideri. La recita della taittirīya saṃhitā da parte dello yajamāna termina: “agni, possano questi mattoni essere per me delle mucche, gloriose, che danno il latte del desiderio nell’aldilà, nell’altro mondo”. Qualunque sia la sua interpretazione, iṣṭakā non si riferisce sempre ai mattoni, per esempio, nel baudhāyana śrauta sūtra X (sezioni 27, 29, 31, 34, 39) si applica a un pezzo d’oro (hiraṇyeṣṭakā), a una pentola (kumbheṣṭakā) e a tutti i tipi di sassolini. Per il momento possiamo solo dire che il termine iṣṭakā suggerisce un’origine indo-iranica e non dravidica.
Il termine iṣṭakā sopravvive nell’India moderna nel significato di “mattone (cotto)” ed è collegato all’immortalità in un modo che ricorda curiosamente l’agnicayana. Ecco un indovinello hindi: “È nato proprio nell’acqua, ma vedendo l’acqua muore. Fratelli, andiamo a cremarlo; allora sarà immortale (jal hī me paidā bhaī jalai dekh mar jāi; caliyo panco phūk dē pher amar ho jāi). La soluzione è: īṭ, “mattone”. Dundes e Vatuk (1974, 128- 130) lo spiegano come segue:
La produzione di mattoni in India inizia con il prelievo del fango da uno stagno del villaggio. Il fango viene posto in un telaio di legno rettangolare cavo. Dopo aver lisciato la parte superiore, il telaio viene rimosso e il mattone viene lasciato asciugare al sole. Le case dei villaggi sono tipicamente fatte di mattoni essiccati al sole. Purtroppo, se la pioggia cade su questo mattone, si dissolve. Quindi, anche se il mattone è “nato nell’acqua”, può morire quando entra nuovamente in contatto con l’acqua. Esiste tuttavia un modo per evitare questa catastrofe. Cremando o cuocendo il mattone di fango lo si rende resistente all’acqua e quindi immortale. L’idea che la cremazione assicuri l’immortalità è contraria alla teoria escatologica generale, in quanto chiunque muoia diventa immortale. C’è quindi una contraddizione filosofica nella seconda parte dell’enigma. E anche dal punto di vista empirico c’è una contraddizione tra il fatto che un oggetto venga cremato e quindi completamente distrutto e il fatto che quell’oggetto venga reso “immortale” nel senso di esistere e resistere alle forze distruttive.
Converse ha richiamato l’attenzione su una caratteristica particolare della cottura del vaso ukhā, che si applica anche al vaso mahāvīra del pravargya: entrambi sono cotti con il fondo rivolto verso l’alto. FOTO 5,41,42, 46,58, 6oB,7I, 72A, 85 Questo dettaglio è citato da Eggeling tra parentesi nella sua traduzione del śatapatha brāhmaṇa 6.5.4.4: “Poi appoggia la padella del fuoco (con la parte inferiore rivolta verso l’alto)”. Questa informazione non è contenuta nell’originale, che si limita a dire: “appoggia l’ukhā” (ukhām avadadhāti). Eggeling ha probabilmente tratto questa informazione aggiuntiva dal kāyyāyana śrauta sūtra 16.4.11, che afferma che l’adhvaryu posa il vaso ukhā “a testa in giù” (nyubjām).


Per quanto riguarda il vaso mahāvīra e il pravargya, Converse fa riferimento al śatapatha brāhmaṇa 14.1.2.21, che, senza entrare nei dettagli, implica che i vasi ukhā e mahāvīra devono essere trattati in modo simile. Kashikar, in uno studio sulla ceramica vedica, sostiene questa tesi: “Anche se le dimensioni e la forma di questo calderone (ukhā) sono diverse, la procedura di preparazione è per lo più identica a quella prescritta in relazione alla preparazione del mahāvīra” (Kashikar 1969, 19). Questa somiglianza è stata ulteriormente approfondita da Ikari (1975, vol. II, pagg. 168-177) e si accorda bene con le relazioni tra l’agnicayana e il pravargya notate da Rönnow e altri (cfr. sopra pagg. 183-184).
Commenti di Converse sul “a testa in giù”:
Può sembrare un dettaglio insignificante. Ma è proprio grazie a questa tecnica di cottura invertita che la Black-and-Red Ware, tratto distintivo della cultura indigena non vedica, è stata resa nera e rossa! Questa tecnica non è stata utilizzata per la produzione della ceramica grigia, se non in modo molto limitato e in fasi molto avanzate. L’inversione del vaso durante la cottura limita l’ossidazione all’interno del vaso e questa riduzione parziale lascia l’interno nero, mentre il lato esterno brucia in un colore rosso a causa della riduzione completa delle argille e dei lavaggi utilizzati (1974, 85).
Converse ha richiamato l’attenzione su un altro passaggio che suggerisce un’origine pre-vedica per il calderone ukhā: śatapatha brāhmaṇa 6.6.2.6 (erroneamente stampato come “7” a pagina 86 di Converse) cita un mantra con cui viene affrontato questo calderone, e che Eggeling traduce come: “Sei un artificio degli asura, fatto nel modo consueto”. Converse commenta:
Il riferimento al vaso come “artificio asura” e alla tecnica di cottura invertita come metodo abituale o consueto degli asura per la fabbricazione dei vasi riconosce che la fabbricazione del vaso è stata ripresa dalla tradizione indigena nemica. In questo modo il testo avvalora in modo indefinito l’evidenza archeologica secondo cui la tecnica della Black and Red Ware è stata identificata con la cultura indigena non vedica. E questo a sua volta sottolinea la stretta connessione del rito agnicayana con quella cultura (1974, 86).
Queste conclusioni sembrano valide, anche se il testo originale non avvalora del tutto la traduzione di Eggeling. Il mantra citato nel śatapatha brāhmaṇa ricorre nel vājasaneyi saṃhita 11.69 e analogamente nella taittirīya saṃhitā 4.1.9.2 d e nelle altre saṃhitā dello yajurveda. Dice: “Tu sei un trucco asurico (māyā), fatto dal potere di sé (sva-dhayā)” (āsurīi māyā svadhayā kṛtā’ si; Keith traduce: “Tu sei l’astuzia degli asura, realizzata con potere”). La forza magica di māyā è infatti, dal ṛgveda in poi, associata agli asura. È vero che svadhā può significare: “stato abituale” o “abitudine”. Ma in questo contesto è più probabile che il riferimento sia all’idea che il vaso di ukhā sia un prodotto spontaneo che nasce per forza propria, così come il fuoco vi si accende senza essere acceso.
La conclusione di base di Converse rimane inalterata: il vaso ukhā è di origine asurica. Considerando l’ipotesi che i riferimenti agli asura sono spesso riferimenti agli abitanti originari, il vaso ukhā deve avere un’origine indigena. Ciò può valere anche per il vaso mahāvīra. Tuttavia, il carattere non vedico della cerimonia pravargya non deve essere sottolineato troppo. L’offerta di latte caldo (gharma) del pravargya, ad esempio, ha chiaramente origini ṛgvediche. Il termine stesso gharma non significa, nel ṛgveda, semplicemente “calore”, come spesso si è ritenuto. Velankar ha elencato quindici versi ṛgvedici in cui gharma è usato nel senso tecnico di “offerta di latte caldo” (Velankar 1962, 228-237). Sei di questi versi si trovano in inni aśvin, il che è in accordo con il fatto che l’offerta di gharma del pravargya è dedicata ai gemelli aśvin. Nel pravargya, il latte caldo è anche collegato al tapas, al “calore”, e all’eccitazione sessuale, un fenomeno non limitato all’India vedica o pre-vedica (cfr. van Buitenen 1968, 37; Kaelber 1976, 348-349).
Se Rönnow, Ruben e altri hanno correttamente ipotizzato che i riferimenti agli asura spesso indicano pratiche e credenze indigene, pre-vediche, gli stessi sembrano valere anche per gli aṅgiras. Nel brāhmaṇa, gli aṅgiras sono spesso contrapposti agli āditya, i figli d’oro di aditi, che assistono l’uomo nella sua lotta per la libertà. Gli aṅgiras si trovano in un rapporto simile a quello degli asura con gli dèi (Hillebrandt 1927, 181). Hillebrandt fu il primo a richiamare l’attenzione sui numerosi riferimenti agli aṅgiras nel rituale agnicayana (Hillebrandt 1927, 175-176). Come abbiamo visto, la preparazione del vaso ukhā avviene in diverse fasi, ognuna delle quali è percorsa “alla maniera degli aṅgiras” (cfr. Renou 1953, 18).
Chi erano questi aṅgiras, dopo i quali agni è spesso chiamato “ aṅgiras” e “primo aṅgiras?”. Hillebrandt ha concluso, sulla base di un’analisi generale della loro presenza nei ṛgveda, che “gli aṅgiras erano originariamente una famiglia che si trovava piuttosto al di fuori della tradizione vedica principale, come dimostra la loro mancanza di rilievo nei libri ii-ix” (Keith 1925, I, 224). In seguito a questo suggerimento, si è sviluppato un ampio dibattito accademico sulla loro identità e provenienza, nonché sulle possibili etimologie del loro nome. In precedenza, Mac-donnell aveva difeso l’opinione che gli aṅgiras fossero intermediari tra gli dèi e gli uomini e che il loro nome fosse legato al greco αγγελος, “messaggero”, in inglese angel. Le prove del loro status di intermediari, tuttavia, sono scarse e questa tesi è stata generalmente respinta. Più recentemente, la possibilità di questa etimologia è stata ripresa da H.W. Bailey (1957, 52-53), che ha postulato una radice *aṅg, “cantare, enunciare”, che ricorre nella parola vedica āṅgūṣa, “canto di lode”. Schmidt (1968, 51-52) ha però sottolineato che la derivazione di aṅgiras da tale radice presenta diversi problemi (tra cui il fatto che il suffisso -iras non è conosciuto altrove).
Al di fuori del linguaggio, le etimologie dimostrano poco, “perché l’uso è più forte dell’etimologia” (yogād rūḍher balīyastvāt, come dicono i filosofi mīmāṃsā). Anche se una parola è indoeuropea, come asura, ad esempio, potrebbe riferirsi a cose indiane e pre-vediche. È possibile che gli aṅgiras fossero cantori, e ragionevolmente certo che fossero sacerdoti di un culto del fuoco. Sono direttamente collegati agli asura nel ṛgveda 3.53.7 e 10.67.2, dove gli aṅgiras sono chiamati “eroi degli asura” (asurasya vīrāḥ). Seguendo Hillebrandt, non sarebbe inverosimile ipotizzare che gli aṅgiras fossero in origine una tribù o una famiglia indigena, incorporata nel culto vedico in una fase relativamente precoce. È ipotizzabile che l’agnicayana sia stato incorporato nel rituale vedico attraverso il loro intermediario, dal momento che erano principalmente sacerdoti di un culto del fuoco. Quindi la teoria di Kosambi (1950), criticata da Brough (1953, xiv xvi), secondo cui i brahmini vedici furono in gran parte reclutati dalla classe sacerdotale delle popolazioni preariane conquistate, sembrerebbe essere valida almeno nel caso degli Angiras.
In conclusione, le prove disponibili suggeriscono che la costruzione dell’altare dell’agnicayana, così come i vasi ukhā e mahāvīra - i principali vasi rituali rispettivamente dell’agnicayana e del pravargya - sono di origine pre-vedica e dovrebbero essere spiegati dalle tecniche di cottura dei mattoni e dei vasi che erano note alla popolazione indigena e che possono essere ricondotte alla civiltà dell’Indo. In un contesto più ampio, ciò non sorprende. L’uso di mattoni cotti, pur non essendo limitato alla Civiltà dell’Indo, è stato uno dei suoi risultati caratteristici. I mattoni cotti erano usati a Sumer, anche se non in abbondanza. A Mohenjo-daro e Harappā, l’uso di mattoni cotti, piuttosto che di mattoni di fango, era normale (Wheeler 1968, 8, 55). Qualunque sia la spiegazione della sua distribuzione precoce, è probabile che l’arte di cuocere i mattoni sia stata mantenuta dagli abitanti dell’India nord-occidentale anche dopo la scomparsa delle grandi città dell’Indo. In Iran, anche gli invasori nomadi iraniani ereditarono l’arte dalle civiltà sedentarie precedenti. Dario impiegò i babilonesi come costruttori di mattoni e, come mi informa il professor Schwartz, il termine iraniano per forno, tanūra, è di origine mesopotamica. Questo termine mesopotamico sopravvive fino ai giorni nostri nel “pollo-tandoori”.
Sebbene l’altare dell’agnicayana non sia stato incorporato nel Hinduismo, esistono culti indiani successivi che fanno uso di altari di fuoco. Questi culti sono caratterizzati dall’homa, l’atto di offrire un’oblazione (in genere di ghee = ghṛta, “burro chiarificato”) nel fuoco (cfr. hotā: sopra pagina 89). Sebbene non esista praticamente alcuna letteratura al riguardo, il culto dell’homa è presente sia nei templi sia praticato da saṃnyāsin e yogin erranti. È stato incorporato nel buddismo e ha messo radici in Tibet, Cina e Giappone. Nel culto degli ordini giapponesi Shingon e Tendai, gli altari di fuoco svolgono un ruolo preponderante. Questi saranno trattati da Michel Strickmann nel Volume II (pagine 418-455). C’è un grande divario tra questi culti e l’altare del fuoco vedico, e non si sa molto dello sviluppo storico. È chiaro che gli elementi vedici sopravvivono. Non solo la cerimonia del fuoco Shingon è chiamata goma, ma il numero di bastoni di fuoco (samidh) è di ventuno, come nel puruṣa-sūkta (ṛgveda 10.90.15: sopra, pagina 115).
Cavilli a parte, la dimostrazione di Converse ha stabilito al di là di ogni ragionevole dubbio che la costruzione dei due altari principali dell’agnicayana in mattoni cotti deve essere fatta risalire alla precedente civiltà della Valle dell’Indo. Questo non implica che l’intero rituale agnicayana sia un rituale Harappa, né è la fine della storia per quanto riguarda l’altare stesso. L’accatastamento dei mattoni ha molte altre caratteristiche specifiche. I mattoni sono disposti in un ordine particolare, hanno nomi particolari e sono consacrati con mantra particolari. Queste caratteristiche particolari sono fondamentalmente le stesse nelle varie recensioni dello yajurveda, e devono quindi essere antiche (Weber 1873, 270).
Tra i mattoni, ci sono due tipi che meritano una menzione speciale. Si tratta degli apasyāḥ “(mattoni) acquosi” e degli svayamātṛṇṇāḥ, “mattoni pieni di cavità naturali”. I mattoni apasya sono posti vicino alle teste degli animali e si dice che in questo modo l’acqua viene immessa in queste vittime (śatapatha brāhmaṇa 7.5.2.40; le posizioni adottate nel 1975 non erano le stesse, come vedremo, pagine 437-438). Baudhāyana usa il termine apasya per riferirsi a certi ciottoli o pietre che Kātyāyana chiama pariśrit, “coloro che circondano”, e che altrove sono chiamati śarkara. Questi ciottoli sono usati per segnare o delimitare le chiusure degli altari. Sono presenti nella maggior parte dei rituali che iniziano con l’installazione del fuoco (agnyādhāna), nello stesso agnicayana (vedi sotto, pp. 339, 387) e anche nei riti funerari, dove delimitano i tumuli śmaśāna (Caland 1896, 145). È possibile che i mattoni che prendono il nome da questi ciottoli siano resti di un metodo precedente e meno elaborato di delimitazione degli altari. Tali metodi erano probabilmente utilizzati dai nomadi vedici e dai nomadi indo-iraniani prima del loro ingresso nel subcontinente. Confinare il fuoco in un focolare per mezzo di ciottoli o pietre è più o meno universale.
Una simile origine vedica nomade può essere ipotizzata anche per le tre svayamātṛṇṇā, “piene di cavità naturali”, anche se su basi diverse. Un’origine vedica spiegherebbe la straordinaria importanza attribuita a questi mattoni, che a volte sono trattati come ciottoli e che in genere sono avvolti nel mistero. Secondo il śatapatha brāhmaṇa, tre svayamātṛṇṇā dovrebbero occupare il centro del primo, terzo e quinto strato dell’altare. Esse rappresentano i tre mondi: terra (pṛthivī, bhū), aria (antarikṣam, bhuvas) e cielo (dyaus, svar). Permettono all’uomo d’oro, e quindi al sacrificatore, di respirare e di passare alle regioni più elevate (śatapatha brāhmaṇa 6.1.2.31 sq; 6.2.3.1 sq; ecc.). Se una persona che ha già eseguito una volta l’agnicayana desidera eseguire un altro rito del soma, ma non è in grado di ripetere l’intera cerimonia agnicayana, è sufficiente che deponga i tre svayamātṛṇṇā: “Gli basta deporre quelle piene di cavità naturali; perché quelle piene di cavità naturali sono questi mondi; e questo altare di fuoco costruito è lo stesso di questi mondi” (śatapatha brāhmaṇa 9.5.1.58). Così le svayamātṛṇṇā rappresentano l’agnicayana stesso.
Sebbene le svayamātṛṇṇā siano talvolta considerate iṣṭakā (che non significa necessariamente “mattone”, come abbiamo visto), il śatapatha brāhmaṇa (8.7.3.20; 8.7.4.1) afferma specificamente che sono ciottoli o pietre (apasya; śarkara; anche suṣkarāḥ śarkarāḥ “pietre secche”). Un commentatore del vājasaneyi saṃhitā spiega svayamātṛṇṇā come “una pietra forata, trasversalmente forata” (śarkarāṃ chidrāṃ chidrayuktāṃ tiryakchidrām; citato in Weber 1873, 249, nota 4). Le svayamātṛṇṇā erano apparentemente chiamate “perforate naturalmente” o “perforate da sole” (svayam) perché non erano manufatti ma sono stati trovati in natura.
VEDI FOTO 6
Erano quindi indipendenti dall’attività di fabbricazione dei mattoni che caratterizzava il resto della costruzione dell’altare. Infatti, contrastano per la loro naturalezza con le tecniche artificiali di fabbricazione dei mattoni. Ciò indica la loro origine non indiana, cioè vedica.
Si può menzionare di sfuggita che le pietre svayamātṛṇṇā sono le uniche pietre importanti che svolgono un ruolo nel rituale vedico. Le grāvānaḥ dei rituali del soma, che sono generalmente chiamate “pietre per la spremitura” e sono usate per estrarre il succo dagli steli di soma, non devono essere necessariamente pietre, ma sono a volte il mortaio e il pestello (ulūkhala) e a volte di legno (vanaspati) (Oliphant 1920, 230-231).
Coomaraswamy, in un suo articolo suggestivo e speculativo (1939), ha messo in relazione la svayamātṛṇṇā con una grande varietà di fenomeni religiosi in tutto il mondo. Tutti esprimono un’ascesa al cielo (Himmelfahrt). Il passaggio del sacrificatore o dell’uomo d’oro attraverso le pietre perforate e i tre mondi è legato alla scalata rituale di un albero, di un palo sacrificale o dell’axis mundi, alla cui sommità si trova la porta del cielo (janua coeli). Tali nozioni si trovano in tutto il mondo. Si ritrovano altrove nel rituale vedico. In un rito siberiano, lo sciamano si arrampica su una betulla posta all’interno di una yurta, inclinata in modo da lasciare spazio al focolare e con la chioma che si erge sopra il foro del fumo: questa apertura è “un foro attraverso il quale è possibile passare da un mondo all’altro” (Coomaraswamy 1939, 13). In un ultimo paragone, Coomaraswamy mette in relazione il ṛgveda 4.6.2 (in cui agni fissa i suoi raggi, come se stesse piantando un palo, facendo salire il fumo e sostenendo il cielo) con “l’uomo paleolitico, che già possedeva la sua capanna circolare con focolare centrale e un foro nel tetto per la fuoriuscita del fumo”.
Queste speculazioni sostengono l’ipotesi che l’idea di raggiungere un mondo superiore passando attraverso buchi, passaggi e grotte naturali sia stata portata dai nomadi iraniani dall’Asia centrale. Sebbene le speculazioni di Coomaraswamy appaiano inverosimili, e io per primo sono stato a lungo scettico, in realtà esistono numerose prove a sostegno di questa tesi. Alcune prove linguistiche, inconcludenti ma suggestive, possono essere citate per prime. Il termine śarkara, “sabbia, ciottoli, ghiaia”, è probabilmente di origine pre-indoeuropea, anzi caucasica (Hubschmidt, citato nel Dizionario Etimologico di Mayrhofer). Questo termine è anche legato all’arabo sukkar (da cui l’inglese “sugar”) e al latino calculus, una piccola pietra usata per il calcolo con l’aiuto di un abaco.
Nello sciamanesimo siberiano, le pietre bucherellate vengono utilizzate in una varietà di contesti. Sono rappresentazioni in miniatura di rocce con grotte, attraverso le quali lo sciamano entra nell’altro mondo (Eliade 1964, 202). Gli sciamani yakut indossano un simbolo dell’“Apertura della Terra”, chiamato “Buco degli Spiriti” (abassy-oibono: Eliade 234). Gli dei scendono sulla terra attraverso lo stesso buco attraverso il quale gli sciamani volano in estasi (Eliade 259). Pietre perforate, alcune usate come perline, altre di uso incerto, sono state trovate in tutta l’Asia interna. Ecco due esempi riportati da Aurel Stein:
N.xiv, iii.0035. Ornamento circolare in pasta scura. Piatto sul retro e forato. La parte anteriore, dalla quale si sta staccando l’involucro esterno, è ornata da sei strisce radiali gialle, divise da due sottili linee radiali. Tra le strisce, su fondo scuro, cerchi gialli che circondano dischi neri su cui si trovano stelle gialle a sei raggi con centro rosso. Pendant o bottone. Lavoro fine. 1” x 3/8”. Pl. XXIX (Stein 1921, I, 252).
D.K.01. Perlina di pietra a forma di echino, sfaccettata e forata con foro grande. Black stone (?) jet. Ben conservata. Diam. 1/2”, profondità 3/8”. Pl. X. (Stein 1928, I, 133).
Non si sa nulla sull’uso di queste pietre, ma il loro carattere particolare potrebbe far pensare a un uso rituale o magico. Il loro possibile utilizzo come perline deriva probabilmente da questo. Non si sa nulla della loro età, ma in Tibet sono state trovate pietre simili, quasi certamente preistoriche. Queste pietre, chiamate gzi, sono molto apprezzate e di buon auspicio. Presentano complicati motivi di striature e “occhi” (mig) (Nebesky-Wojkowitz 1952). Possono essere usate come perline perché hanno quasi sempre dei fori. I tibetani non li fanno mai, perché le pietre sono considerate troppo dure. Le poche che si trovano senza fori non vengono quindi indossate come perline, ma conservate separatamente (Lama Kunga Losang, comunicazione personale). Ci sono anche paralleli da più lontano che suggeriscono che queste pietre forate, e le idee che le circondano, sono in realtà antiche.
I cinesi si sono a lungo interessati alle pietre forate, che sono rappresentazioni in miniatura di rocce con grotte, e in particolare della Montagna del Mondo. Queste pietre sono a volte collocate in giardini in miniatura che riproducono la stessa corrispondenza generale tra micro e macrocosmo. Le montagne sacre sono considerate le dimore degli spiriti, presiedute da una grande divinità che può essere avvicinata attraverso grotte e tunnel. Allo stesso tempo, le pietre forate sono modelli dei palazzi celesti degli dei.
I loro fori corrispondono alle stelle. L’espressione usata a questo proposito è “cielo-grotta” o “paradiso della grotta”: tung t’ien che significa anche “paese delle fate”, “paradiso”.
Queste grotte o palazzi rupestri cinesi sono concepiti come aree sotterranee in cui dimorano gli immortali e che sono collegate ad altri luoghi simili attraverso una rete di grotte e tunnel. Le grotte sono collegate con le acque sotterranee e con le luci del cielo. Servono come rifugio per gli eremiti che vi meditano o le usano per i riti di iniziazione. Le sue menti hanno anche il potere di ricreare questi mondi nel cosmo in miniatura dei giardini con le rocce. Le pietre presenti in natura, che presentano le caratteristiche richieste, possono essere calcari erosi, lava o rocce fossili (per ulteriori dettagli si veda Soymie 1954; Stein 1942; Schafer 1961).
Nel Taoismo, le rocce sono state a lungo considerate simboli di longevità. Se lo sfondo magico-religioso delle grotte di roccia in miniatura e delle pietre per forate è stato sviluppato principalmente nel Taoismo, in tempi successivi ha acquisito una dimensione estetica. Secondo Schafer, “la creazione di una montagna in miniatura in un giardino risale alla prima parte del periodo delle Sei Dinastie, probabilmente addirittura agli Han” (1961, 5). In epoca T’ang, la raccolta di pietre fantastiche era il passatempo preferito dei gentiluomini colti, che rivaleggiavano tra loro nell’allestimento di lapidari e diventavano i primi conoscitori di pietre.
Questa mania, non rara, si diffuse tra i più altolocati del Paese. L’ultimo dei sovrani Sung del Nord, Hui Tsung, era un noto collezionista. Il suo più grande sforzo collezionistico fu legato alla costruzione di una montagna magica a nord-est del palazzo imperiale di K’ai- feng, su richiesta di un geomante. Il completamento di questa monumentale impresa richiese diversi anni, essendo stata iniziata nel 1117 d.C.. Vi furono portate pietre di forma meravigliosa da tutte le parti del regno, soprattutto quelle del Grande Lago e di Ling-pi (Schafer 1961, 8).
Molte di queste strane e rare pietre erano perforate e “piene di buchi”. Schafer ne elenca alcune nella sua traduzione di un Catalogo di pietre compilato da Tu Wan nel XII secolo d.C. Qui troviamo voci come:
- Pietre a forma di cuore (nel fiume di Hsiang-chou, a nord di Hupeh). Piccoli ciottoli blu-neri, ciascuno con un foro, da cui il nome. Gli indigeni li cercano nel letto del fiume ogni primavera, per predire il numero di figli che avranno. Recentemente mio fratello ne ha trovato uno grande come un uovo d’oca. Era blu, con due linee di segni bianchi che facevano pensare a una scrittura corsiva fatta in ceruleo. È stato derubato da un giovane aristocratico. Non ne sono stati trovati altri simili (Schafer 1961, 72).

Questi ciottoli sono stati trovati nel Bharata Puzha (bhārata-puḻa) o fiume Ponnani a Kat;1t;1anur, a circa un miglio e mezzo a valle di Pattambi. Sono chiamati kōḻipparal, “pesci-pollo” in malayalam. Alcuni hanno dei fori e sono considerati “naturalmente perforati” (svayamātṛṇṇā). L’agnicayana richiede due ciottoli con (almeno) tre fori e uno con (almeno) cinque fori. Se non si trovano ciottoli con fori completamente perforati, sono accettabili ammaccature o piccole depressioni.
Questi ciottoli sono composti da vivianite, uno scarso minerale che prende il nome dal mineralogista britannico J.G.Vivian, che lo scoprì in Cornovaglia. Si tratta di un fosfato idrato di ferro, Fe3(P04)-8H20, che si trova spesso in letti di argilla o in cavità di fossili alterati. I ciottoli hanno un colore terroso e smeraldo, dovuto all’erosione della superficie, ma il minerale all’interno è di colore blu-nero. Si presenta sotto forma di conformazioni da sferiche a irregolari con cristalli prismatici in gruppi radianti.
Foto Michael Beaucage
L’importanza che i cinesi attribuivano alle pietre e alle rocce perforate così come alle montagne cavernose, è ampiamente illustrata nella pittura. Alcune volte le rocce perforate appaiono isolate; più spesso punteggiano il paesaggio (Foto 7A). Spesso un saggio appare davanti a una roccia di questo tipo (Foto 7B); altre volte un Buddha è seduto al suo interno (Foto 8A; riprodotta anche in Hu, 1977, Foto 041-25, insieme a diversi dipinti simili). Ci sono anche immagini di pietre crivellate di buchi, che appartengono a una collezione (Foto 8B). In un dipinto una roccia cavernosa appare sulle acque come un’apparizione sovrannaturale (Foto 9). Ancora oggi, i cinesi conservano le rocce con buchi nei giardini e in altri luoghi speciali (tavole l0 A-B).
I fatti che abbiamo citato sono tutti chiaramente collegati tra loro e ne emerge un quadro generale. Fin dall’antichità, in Asia centrale si è diffusa la convinzione che le grotte siano le dimore degli spiriti. Si può solo ipotizzare se ciò possa risalire all’epoca in cui gli uomini erano essi stessi abitanti delle caverne. In Asia centrale, le speculazioni sulle corrispondenze tra micro e macrocosmo hanno portato all’importanza delle pietre forate, che sono rappresentazioni in miniatura di queste rocce cavernose e che venivano utilizzate per scopi magici e rituali, forse legati alla divinazione. Molte di queste pratiche e credenze sopravvivono nello sciamanesimo. Queste idee furono introdotte in Cina in un periodo precoce e furono sviluppate principalmente nei circoli taoisti. A partire dal periodo T’ang, acquisirono una dimensione estetica che sopravvive fino ai giorni nostri nei giardini rocciosi dell’Oriente.
Gli Indoeuropei condividevano alcune delle credenze dell’Asia centrale sulle pietre forate. Gli Indo-iraniani le importarono nel subcontinente indiano. Gli Indo-iraniani erano anche impegnati in un culto del fuoco e forse conoscevano la nozione di Uomo cosmico. In India incontrarono credenze simili e anche una tecnologia avanzata che comprendeva tecniche di cottura dei mattoni. Adottarono queste tecniche nella costruzione di un grande altare di fuoco per l’Uomo Cosmico, impilato con i mattoni cotti dell’uomo indiano, ma con l’aggiunta delle loro pietre forate. I nomadi vedici contrapponevano la naturalezza di queste pietre ai manufatti della civiltà sedentaria che incontravano. Pur costruendo l’altare dell’agnicayana alla maniera indigena, i nomadi vedici continuarono a ritenere che l’essenza dell’altare fosse già contenuta nelle loro pietre forate naturali.
Gran parte di questo quadro è ancora speculativo, ma vedremo che esistono prove di altro tipo che puntano nella stessa direzione e sono molto più specifiche. Ciò diventa chiaro non appena si presta attenzione al ruolo svolto dalle pietre naturalmente perforate nella costruzione dell’altare agnicayana. Gli aṅgiras forniscono un punto di partenza. Abbiamo visto che il vaso di ukhā è preparato “alla maniera degli aṅgiras “. Come vedremo in seguito, tutti i mattoni vengono posati nello stesso modo. Abbiamo anche visto che gli aṅgiras potrebbero essere stati originariamente una tribù o una famiglia indigena, forse sacerdoti di un culto del fuoco. Ciò implica, a sua volta, che gli indiani pre-vedici avevano il loro proprio culto del fuoco. Questo, ovviamente, è prevedibile. Un popolo i cui antenati avevano costruito grandi città con mattoni cotti, che cuocevano le loro ceramiche, mangiavano cibi cotti e avevano bisogno del fuoco per riscaldarsi (anche se non nella stessa misura richiesta in Asia centrale) non poteva non occuparsi del fuoco.

Il titolo di questo dipinto è: “Abitazioni della foresta nella regione di Chü”. Il pittore è Wang Meng (1308-1385), della dinastia Yüan.

“Pittura di un Lohan”, di Ch’en Hung-shou , pittore vissuto durante la dinastia Ming (1368-1644). Un Lohan (sanscrito: arhat, “meritevole”) è un saggio buddista, definito come una persona “in cui si sono esauriti i flussi del desiderio sensoriale, del divenire, dell’ignoranza e delle opinioni errate, che ha vissuto molto, che ha fatto ciò che doveva essere fatto, che si è liberato del fardello, che ha vinto il suo obiettivo, che non è più legato al divenire, che è libero, avendo giustamente conosciuto” (secondo Conze 1959, 93-94).
Collezione del National Palace Museum, Taiwan, Repubblica di Cina.

Bodhidharma introdusse in Cina la scuola Dhyana (meditazione) del Buddismo e divenne il primo patriarca del Ch’an (che in Giappone si sviluppò nello Zen). Per nove anni praticò la cosiddetta contemplazione delle pareti, seduto davanti a un muro. Morì nel 535 d.C. Qui è raffigurato come il venticinquesimo di una serie di venticinque dignitari buddisti, associati al sūraṅgama sūtra. La serie è intitolata: “I venticinque Buddha realizzati”del Leng-yen sutra”. È stato dipinto da Wu Pin (?1601-1643). L’intera serie è riprodotta in Hu, 1977, tavole da 041-1 a 041-25.

Il titolo è: “Pittura di una pietra a onde di neve”, opera dell’artista della dinastia Ch’ing Chang Jo-ch’eng m (XVIII secolo). Una delle iscrizioni sul dipinto fa riferimento a una pietra “onda di neve” citata dal celebre poeta dell’XI secolo Su Tung p’o. Chang Jo-ch’eng vide questa pietra in una collezione privata. Quando la incontrò di nuovo, vent’anni dopo, i caratteri Onda di neve erano stati incisi sulla sua superficie. Realizzò il dipinto per ricordare questo straordinario pezzo da collezione.
Collezione del National Palace Muesum, Taiwan, Repubblica di Cina

“Disegno del Picco della Fanciulla di Giada”, attribuito al pittore Fan Huai-chen, vissuto durante la dinastia Ch’i meridionale (479-502), ma ovviamente di data posteriore. La montagna di Giada Maiden è una delle numerose montagne famose tra i taoisti.
Collezione del Museo del Palazzo Nazionale, Taiwan, Repubblica di Cina

I “Tre stagni impressi dalla luna” sono caratteristiche di un piccolo isolotto al centro del Lago Occidentale, vicino a Hangchow. Due grandi poeti medievali, Po Chii-yi della dinastia T’ang e Su Tung-p’o dei Sung, in qualità di governatori di Hangchow, hanno contribuito allo sviluppo delle caratteristiche paesaggistiche del Lago Occidentale. L’isola costellata di specchi d’acqua su cui si trova questa roccia fu costruita nello stesso periodo dell’argine di Su, nell’XI secolo.

A Soochow, antico centro dell’arte del giardino cinese. Il giardino cinquecentesco in cui questa roccia fu portata dal vicino lago T’ai (T’aihu) fu ricostruito alla fine del XIX secolo e ribattezzato Liu-yuan, “Giardino dei balli”, come gioco di parole sul nome della famiglia dei proprietari, Liu. Le rocce di T’aihu, calcare consumato dalle onde, sono una delle caratteristiche principali dei giardini di Soochow.
Fotografie Cyril Birch
A questo punto incontriamo una difficoltà. Non ci sono dati della Civiltà della Valle dell’Indo che indichino un culto del fuoco. Gli scavi di Kalibangan hanno restituito “una vasca di terracotta con tracce di cenere, una pietra cilindrica al centro e alcune “torte” di terracotta disposte intorno ad essa” (Romila Thapar, comunicazione personale; anche Volume II, pagina 14). Sebbene questo stabilisca la presenza del fuoco, non stabilisce l’esistenza di un culto del fuoco. In ogni sito dell’Indo ci sono molti focolari, ma non è certo che ci fossero altari. I sigilli di Harappa sono altrettanto poco utili, il che non deve sorprendere. Anche se le iscrizioni su questi sigilli fossero comprese correttamente, darebbero un’immagine estremamente limitata di una civiltà, un po’ come quella che emergerebbe se tutto ciò che rimane della civiltà contemporanea fosse una collezione di francobolli. Questi dati sono belli e interessanti, ma hanno senso solo se si conosce molto di più. Per questo motivo, la nostra conoscenza della civiltà della Valle dell’Indo, anche supponendo che le iscrizioni siano state tutte decifrate in modo soddisfacente, è di tutt’altro ordine rispetto alla conoscenza delle civiltà del Vicino Oriente, che hanno lasciato grandi biblioteche di tavolette d’argilla.
Un altro confronto può aiutare a mettere nella giusta prospettiva il significato dei sigilli della Valle dell’Indo. Come è noto, la decifrazione dei geroglifici egizi da parte di Champollion è stata resa possibile soprattutto dalla scoperta della Stele di Rosetta, che conteneva 14 righe di geroglifici insieme alla traduzione in 32 righe di demotico e 54 righe di greco. La chiave della decifrazione è stata la presenza di nomi nelle tre lingue. Nella parte geroglifica, ciascuno di essi era chiaramente indicato all’interno di un contorno ovale. Tutto ciò è molto diverso dalla situazione in India. Nel caso dei sigilli di Harappa, non abbiamo trovato una stele di Rosetta e gli oltre 2.000 sigilli finora rinvenuti corrispondono al massimo al materiale contenuto nei contorni ovali delle iscrizioni geroglifiche egiziane.
È chiaro che un culto del fuoco nella Valle dell’Indo potrebbe facilmente non lasciare alcuna traccia nei dati archeologici o sui sigilli di Harappa. Tuttavia, un tale culto non poteva rimanere inosservato in un’ampia letteratura. Pertanto, se vogliamo scoprire un possibile culto del fuoco nella civiltà della valle dell’Indo, le prove positive provenienti da culture simili nel Vicino Oriente sarebbero più significative di quelle negative provenienti dalla stessa valle dell’Indo. Fortunatamente, le prove rilevanti sono state recentemente raccolte da Jean Bottero (1973). Da questa evidenza apprendiamo che gli antichi mesopotamici erano ancora vicini al periodo della raccolta del fuoco. Sebbene la produzione del fuoco dovesse essere nota, non esiste un singolo verbo che sembri riferirsi ad essa. Esistono tuttavia numerosi riferimenti alla conservazione e al trasporto del fuoco. Esistevano focolari mobili, riferimenti all’uso del fuoco in relazione alla produzione di ceramica e mattoni e, ultimo man non meno importante, esistono divinità del fuoco. Il dio principale del fuoco era chiamato Gi-bil o Bil-gi (a volte Giš-bar) in sumerico, che corrisponde a Girra, Gir(r)u in accadico. “Questo è il nome del dio del fuoco, o del fuoco divinizzato, conosciuto fin dal periodo di Fara, intorno al 2.600 a.C., o forse risalente al 2.700 a.C. negli archivi arcaici di Ur. Gi-bil significa ‘canna ardente’” (Bottéro 1973, 10). Esisteva anche un altro dio del fuoco, chiamato Nusku (ibid., p. 11).
Da queste prove sembrerebbe probabile che una situazione simile si sia verificata nella Civiltà della Valle dell’Indo. Se così fosse, però, i nomadi vedici non si sono limitati a importare un culto del fuoco nel subcontinente, ma devono aver trovato anche un culto del fuoco già presente. In queste circostanze ci aspetteremmo che i due culti del fuoco venissero combinati. L’agnicayana conserva prove che suggeriscono proprio questo.
Nell’agnicayana c’è un personaggio curioso che funge da sacerdote, ma non si trova in altri rituali vedici (cfr. Staal 1978; 1982, 42s.). È chiamato brahmino, ma è un avidvas, “ignorante”. (Vedi Foto 11, 67, 79) Il termine brahmino non deve indurci a supporre che questo personaggio debba essere un ārya vedico. A parte il puruṣasūkta, brāhmaṇa ricorre solo due volte nel ṛgveda, entrambe le volte nell’inno alle rane, ṛgveda 7.103. In questo contesto il termine, usato al plurale, si riferisce ai sacerdoti officianti (cfr. Renou 1967, 150). Sarebbe lecito attribuire lo stesso significato all’espressione “bramino ignorante” nel contesto dell’agnicayana.
Come per tutte le cose che riguardano l’agnicayana, il bramino ignorante appare per la prima volta nello yajurveda. La kāṭhaka saṃhitā (20.6: 24.10) fa riferimento a un “adhvaryu ignorante”. Il “bramino ignorante” si trova in diversi śrauta dello yajurveda nero, ma non nello yajurveda bianco. Poiché lo yajurveda nero è più antico, ciò sembra indicare che la sua funzione era importante e antica. Tuttavia, poco dopo, non è stato più compreso e quindi è stato omesso.
Chi è questo bramino ignorante che continua a essere ignorato? Weber non lo ha incontrato nell’agnicayana, poiché la sua descrizione si basava sul kāṭyayana śrauta sūtra, che appartiene allo yajurveda bianco e quindi non lo menziona. Caland lo scoprì negli śrauta sūtra di Baudhāyana e di Āpastamba, ma anche lui dichiarò: “Il vero significato di questo brahmano ‘ignorante’ (cioè, forse, non familiare con il culto di agni) non mi è chiaro” [die eigentliche Bedeutung des ‘unwissenden’ (d.h. wohl des mit dem agniritus nicht vertrauten) Brahmanen ist mir nicht klar: nota 4 su āpastamba śrauta sūtra 16.23.1].
Il bramino ignorante compare tre volte nell’agnicayana (cfr. baudhāyana śrauta sūtra 10.31:29.1; 10.39:37.17; 10.46:46.9-10; corrispondentemente āpastamba śrauta sūtra 16.23.1, 17.1.12 e 17.3.8; mānava 6.1.7; vārāha 2.1.6). Deve assistere quando l’adhvaryu depone la svayamātṛṇṇā nel primo, terzo e quinto strato dell’altare dell’offerta a forma di uccello. Nella prima occasione, l’adhvaryu recita la taittirīya saṃhitā 4.2.9.1b:
Che il Signore delle creature (prajāpati) ti faccia sedere sulla cresta della terra, tu che sei ampio ed esteso. Tu siete l’ampiezza. Tu sei la terra. Tu sei la terra. Tu sei il suolo. Tu sei Aditi che tutto sostiene, sostenitrice di ogni essere. Tieni salda la terra, rendi salda la terra, non danneggiare la terra. Per ogni respiro, per ogni espirazione, per ogni respiro diffuso, per ogni inspirazione, per sostegno, per movimento! Che agni vi protegga con grande benessere, una copertura sicura! Con quel dio, alla maniera di Angiras, siediti con fermezza!
Nel terzo strato, l’adhvaryu recita il taittirīya saṃhitā 4.3.6.2b:
Lasciate che il Creatore di Tutto (viśvakarman) ti faccia sedere sul crinale del cielo, tu che sei ampio ed esteso. Sei brillante, pieno di sole, che risplende sulla terra, nell’ampio cielo. Tieni fermo il cielo, rendi stabile il cielo, non danneggiare il cielo. Per ogni respiro, per ogni espirazione, per ogni respiro diffuso, per ogni inspirazione, per il sostegno, per il movimento! Lasciate che vāyu ti protegga con grande benessere, una copertura sicura! Con questo dio, alla maniera di aṅgiras, siediti con fermezza!

“Terra! Lasciate che prajāpati vi faccia sedere sul dorso della terra, voi che siete ampi ed estesi. Tu sei il paese, sei la terra, sei il suolo. Tu sei Aditi, che sostiene tutto, che sostiene il mondo intero… Con quel dio, alla maniera di Aṅgiras, siediti con fermezza!”. (TS 4.2.9.lb)
Il bramino ignorante (a destra) assiste l’adhvaryu (al centro) e lo yajamana (a sinistra) nella consacrazione del primo ciottolo naturalmente forato, che presenta tre fori. È nascosto nel terreno, sotto il centro dell’altare, che è segnato da un piolo. Alcuni mattoni del primo strato dell’altare sono già stati posati, ma solo due sono stati consacrati.
Nel quinto strato, l’adhvaryu recita la taittirīya saṃhitā 4.4.3.3 h:
Che l’Essere Supremo (parameṣṭin) ti faccia sedere sul crinale del cielo, tu che sei ampio ed esteso. Sei forte, signorile, magistrale. Tieni stretto il cielo, rendi saldo il cielo, non danneggiare il cielo. Per ogni respiro, per ogni espirazione, per ogni respiro diffuso, per ogni inspirazione, per il sostegno, per il movimento! Lascia che Surya ti protegga con grande benessere, una copertura sicura! Con questo dio, alla maniera di aṅgiras, siediti con fermezza!
Ci sono evidenti parallelismi tra queste tre recitazioni (non evidenziati nella traduzione di Keith). Consideriamoli prima di esaminare le differenze. È chiaro, innanzitutto, che i tre svayamātṛṇṇā nel primo, terzo e quinto strato sono fatti corrispondere ai tre mondi: terra, cielo e paradiso. Inoltre, l’identico ritornello: “Con quel dio, alla maniera aṅgiras , siediti con fermezza!” pur riferendosi a divinità diverse, sottolinea che gli svayamātṛṇṇā devono essere incorporati nell’altare secondo le tecniche di costruzione dei mattoni degli indiani pre-vedici. Questo ritornello, inoltre, viene ripetuto per ognuno dei mattoni dell’intero altare, cioè più di mille volte. Poiché il ritornello è lo stesso della taittirīya saṃhitā 4.2.4.4.1, dove “quel dio” si riferisce ad agni, si ritiene che il riferimento per ogni mattone sia ad agni.
Un altro mantra viene ripetuto in modo analogo per ogni mattone:
I bovini maculati, versando il latte, mescolano il suo soma. Alla nascita degli dèi, le tribù si trovano nelle tre volte luminose del cielo (taittirīya saṃhitā 4.2.4.4) o = ṛgveda 8.69.3
Il significato di questo secondo mantra non è molto chiaro. Il “suo” soma si riferisce al soma di indra. Il succo viene mescolato con il latte. Le mucche sono anche collegate ai mattoni, perché i mattoni si trasformeranno in mucche e sono quindi potenzialmente mucche. I mattoni sono mattoni del desiderio (vedi sopra, pagina 132). Questo mantra ricorre anche nella Grande Litania (mahad uktham) del Gavām Ayanam, “Il cammino delle mucche”, un rituale sattra che dura un anno e che incorpora un agnicayana. In questo rituale, il mantra rappresenta l’aria vitale che pervade il corpo a forma di uccello di agni-prajāpati (Eggeling 1897, IV, 110-112, note). Quali che siano gli enigmi che circondano questo secondo mantra, esso si riferisce chiaramente a soma, così come il primo mantra, attraverso Ailgiras, si riferisce ad agni. La funzione dei due mantra nel loro insieme sembra quindi chiara: essi mettono in relazione ciascuno dei mattoni dell’altare pre-vedico con il culto vedico di agni e soma.
Vediamo ora le differenze tra le tre recitazioni dell’adhvaryu. In ogni caso, si chiede a una prima divinità di ospitare lo svayamātṛṇṇā; e a una seconda di proteggerlo. La corrispondenza è la seguente:
| PRIMA DIVINITÀ | SECONDA DIVINITÀ | |
|---|---|---|
| 1° svayamātṛṇṇā (1° strato) | prajāpati | agni |
| 2° svayamātṛṇṇā (3° strato) | viśvakarman | vāyu |
| 3° svayamātṛṇṇā (5° strato) | parameṣṭin | sūrya |
Le divinità del secondo gruppo, agni (fuoco), vāyu (vento) e sūrya (sole), sono chiaramente divinità vediche. Sono presenti nelle prime parti del ṛgveda e sono anche indo-iranici. Sono anche nozioni fondamentali dello sciamanesimo (cfr. Anisimov 1963, 210-215). Il loro legame con i tre mondi è evidente. Ricorrono frequentemente nel rituale, ad esempio quando lo yajamāna, prima del sacrificio degli animali per vāyu, prende i voti di agni Signore dei voti, vāyu Signore dei voti e āditya (= sūrya) Signore dei voti (sotto, pagina 306). Qui i tre sono invocati per assicurare la svayamātṛṇṇā nell’ambito della religione e della cultura vedica.
Le divinità del primo gruppo sono invocate per incorporare la svayamātṛṇṇā nell’altare, che viene costruito alla maniera indigena. Mentre incorporano la svayamātṛṇṇā vedica nella cultura pre-vedica, alle divinità vediche del secondo gruppo viene chiesto di appoggiare e sostenere questo processo. Ma le divinità del primo gruppo, per svolgere il loro compito, devono ovviamente essere esse stesse divinità indigene.
Si tratta proprio di questo. prajāpati compare solo poche volte nel ṛgveda, sempre nel decimo libro, che è il più recente. Non è indo-iranico. Sebbene possa essere ricomposto da pezzi ṛgvedici, come abbiamo visto, è identificato con l’Uomo Cosmico, che compare anch’esso nel decimo libro, ed era molto probabilmente una divinità degli indiani pre-vedici. viśvakarman, architetto dell’universo, rientra nella stessa categoria. Non è indo-iranico ed è chiaramente legato all’Uomo cosmico. Sebbene viśvakarman sia, nelle prime parti del ṛgveda, un epiteto di savitṛ, la forza solare, egli compare come divinità indipendente solo nel decimo libro e viene successivamente identificato con prajāpati. parameṣṭin non è indo-iranico e non compare affatto nel ṛgveda. Si trova solo nell’atharvaveda e nei brāhmaṇa, ed è identificato con prajāpati e agni.
La differenza di carattere tra i due tipi di divinità è evidente anche dai loro nomi. agni, vāyu e sūrya sono nomi reali di fenomeni e di divinità che si manifestano in quei fenomeni. Ma prajāpati (“signore delle creature”), viśvakarman (“creatore di tutto”) e parameṣṭin (“essere supremo”) non sono nomi, sono descrizioni funzionali. Queste descrizioni sono puramente vediche, per quanto riguarda il linguaggio. Così viśvakarman fu applicato a savitṛ. In seguito sono diventate descrizioni vediche di divinità non vediche che avevano nomi non vedici, che dovevano essere incomprensibili e dal suono barbaro per i nomadi vedici. Che i nomadi vedici si riferissero con tali termini descrittivi a divinità non vediche è naturale. Lo stesso facciamo noi quando ci riferiamo al Dio Sole azteco o al Signore del Cielo giapponese piuttosto che a Huitzilopochtli o Ame-no-minaka-nushi.
Una situazione del genere non è ovviamente rara. Ci sono infatti paralleli in tutto il mondo. Gli Egizi incontrarono molte divinità diverse dalle loro. A volte li identificarono con le divinità egizie, come quando trasformarono le divinità asiatiche in Hat-Hor o Seth. In seguito, divinità asiatiche e semitiche (ad esempio, Baal, Astarte) furono venerate in Egitto (A.J. Wilson in Pritchard 1955, 249-250). Tali scambi devono aver avuto luogo tra i nomadi vedici e gli indiani indigeni, anche se conosciamo solo un lato della storia.
In questo contesto diventa comprensibile il motivo per cui gli indiani vedici chiedevano chi dovessero adorare con le oblazioni. Questa domanda ricorre alla fine di ciascuno dei nove versi del ṛgveda 10.121, un altro inno recente. Un decimo verso è stato aggiunto successivamente e fornisce la risposta: prajāpati. Queste domande non esprimono scetticismo, come è stato suggerito. Esprimono una domanda reale che i nomadi vedici si ponevano: qual è l’identità degli dei pre-vedici degli indiani? Non c’è da stupirsi che questa stessa domanda ricorra più volte nelle recitazioni che accompagnano episodi tipici dell’agnicayana, come l’offerta di animali a prajāpati all’inizio dell’agnicayana (TS 4.1.8) e la deposizione dell’uomo d’oro (TS 4.2.8.2 e).
Il quadro che emerge dalle tre recitazioni che accompagnano la deposizione della svayamātṛṇṇā esprime proprio il tipo di sintesi tra i due culti che ci aspettavamo. Alle divinità pre-vediche viene chiesto di inserire oggetti di culto vedici in un culto pre-vedico, e alle divinità vediche viene chiesto di collaborare e avallare l’operazione. I brāhmaṇa che interpretano questi mantra della taittirīya saṃhitā lo confermano, lo specificano ulteriormente e ci permettono di risolvere l’enigma del bramino ignorante.
I brāhmaṇa che spiegano i mantra della prima recitazione sono riportati nella taittirīya saṃhitā 5.2.8.1-2. Essi spiegano la deposizione della svayamātṛṇṇā con l’assistenza del brahmino ignorante nei seguenti termini:
Si dice: il fuoco deve essere ammassato sul fuoco (agnāv agniś cetavyaḥ). Il brahmano è agni vaiśvānara. A lui (cioè all’adhvaryu) deve essere consegnato il primo mattone preparato con la formula. Il bramino deve depositarlo insieme all’adhvaryu. Così facendo, accumula fuoco su fuoco.
Questo passaggio sconcertante si trova una sola volta. Non ricorre nelle parti di brāhmaṇa che spiegano i mantra della seconda e della terza recitazione (che sono riportate rispettivamente nella taittirīya saṃhitā 5.3.2 e 5.3.7). Che cosa significa?
Mi viene in mente una sola spiegazione che ha senso. L’adhvaryu è il rappresentante del culto del fuoco vedico. Il bramino ignorante è il ripresentatore del culto del fuoco indiano pre-vedico. È ignorante agli occhi dei nomadi vedici, perché ignora il culto vedico del fuoco (come Caland aveva correttamente intuito). Non sarebbe sufficiente dire che, in questa cerimonia, la cooperazione tra i due è essenziale. Piuttosto, la cooperazione è l’essenza della cerimonia. Quando depone la svayamātṛṇṇā, insieme all’adhvaryu, il bramino ignorante “ammassa fuoco su fuoco”, cioè incorpora il proprio culto del fuoco non vedico nel culto vedico del fuoco dell’adhvaryu. Pur essendo ignorante, è un bramino. È accettato come tale perché officia come sacerdote nel culto del fuoco. La sua assistenza è essenziale perché è l’anello di congiunzione tra i due culti del fuoco e scambia doni con l’adhvaryu per suggellare questa cooperazione.
Ci sono paralleli con la frase “ammassare fuoco su fuoco”. ṛgveda 1.12.6 e 8.43.14 ( = taittirīya saṃhitā 1.4.46 1-m) si riferiscono all’accensione del fuoco con il fuoco. Nel contesto rituale, si intende l’accensione del fuoco sacrificale dal fuoco domestico. Altrove, il fuoco viene offerto nel fuoco. Questo viene menzionato, ad esempio, nel contesto del sacrificio animale. Gli animali non sono desiderosi di essere macellati, ma gli dèi li hanno convinti che è sempre nel fuoco che viene offerto il cibo sacrificale:
Dopo aver messo al sicuro gli animali e aver spento il fuoco, offrirono il fuoco nel fuoco (agnāv agnim ajuhuvuḥ), e allora (gli animali) capirono che questo è il modo in cui viene offerto il cibo sacrificale, questo è il suo luogo, che è davvero nel fuoco che viene offerto il cibo sacrificale. Di conseguenza si rassegnarono e divennero favorevolmente disposti alla macellazione (śatapatha brāhmaṇa 3.7.3.5, dopo Eggeling).
In questo contesto, l’offerta del fuoco nel fuoco ha senso. Se il fuoco è sempre il ricettacolo in cui tutto viene offerto, anche il fuoco stesso viene offerto nel fuoco, e questo viene presentato come l’esempio più eloquente che lo dimostra. Ma non c’è alcun collegamento con l’accumulo di fuoco su fuoco nella taittirīya saṃhitā 5.2.8.1-2, che non può essere spiegato in modo così semplice e diretto.
Abbiamo visto che l’agnicayana potrebbe essere stato introdotto nel culto vedico del fuoco attraverso l’intermediazione di una classe di sacerdoti indigeni, gli aṅgirasi (cfr. pagina 137). Se questo è vero, sembra probabile che il bramino ignorante fosse uno di loro. Non conosco regole in tal senso e il gotra āṅgirasa non è raro tra i Nambudiri. Qualunque sia il suo significato, l’avidvān della rappresentazione del 1975 era un bramino del gotra āṅgirasa (vedi sotto a pagina 267).
È possibile che l’avidvān debba essere correlato alla classe generale dei sacerdoti degli asura o dei sacerdoti demoni (asurya), come viśvarūpa, vṛtra e śukra (cfr. O’Flaherty 1976, 98-99, 104-106, 120-122). Lascio ad altri la possibilità di speculare, poiché non abbiamo ancora risposto a un’altra domanda, più pertinente alla nostra indagine: perché il sacerdote ignorante si chiama agni vaiśvānara? agni vaiśvānara, “fuoco che è comune a tutti gli uomini”, è un appellativo comune di agni a partire dal ṛgveda. È stato interpretato come un riferimento al sole o al fuoco sacrificale. È stato anche collegato alla fertilità (Heesterman 1957, 46-47). Nei brāhmaṇa, agni vaiśvānara è identificato con il sole, con l’anno e con tutti i fuochi. Più tardi, nelle upaniṣad, si dice che include il “fuoco della digestione”, poiché i processi digestivi degli uomini sono ovunque gli stessi.
Ma chi erano “tutti gli uomini” per i nomadi vedici che erano entrati nel subcontinente indiano, se non loro stessi e le persone che incontravano e che erano già lì? agni vaiśvānara ha quindi un significato piuttosto specifico: indica agni che è comune ai nomadi vedici e agli indiani pre-vedici. Entrambi avevano il loro culto del fuoco. Il brahmino ignorante viene introdotto nel rituale vedico perché rappresenta il culto del fuoco indigeno. agni vaiśvānara esprime la scoperta, da parte degli invasori nomadi, che anche le popolazioni stanziali incontrate conoscevano agni. agni, quindi, è intensamente ricercato (pṛṣṭa) [cfr. ṛgveda 1.98.2 = taittirīya saṃhitā 1.5.11.1 d (sotto pag. 342), etc. (Renou 1955-1967, XII, 98)].
Siamo quasi giunti alla fine della nostra storia, una storia che racconta le avventure dei nomadi che combinano le idee che hanno portato con loro dall’Asia centrale con le pratiche e le credenze dei cittadini sedentari dell’India. Se è vero che gli indiani vedici erano così profondamente convinti del valore delle pietre forate da insistere per integrarle in un altare da fuoco pre-vedico, perché non hanno cercato pietre simili in India? Da quello che sappiamo, questi ciottoli si trovano generalmente nei fiumi o nelle loro vicinanze. Sul territorio indiano, i nomadi vedici seguivano generalmente il corso dei fiumi e talvolta cercavano di attraversarli. Abbiamo visto (sopra, pagina 97) che la loro espansione originaria verso est era limitata alle pendici a ovest del fiume Gandak, che è ampio e difficile da attraversare. Ecco un fiume sulle cui rive gli Indo vedici devono aver trascorso un po’ di tempo, con l’opportunità di cercare pietre forate.
Si dà il caso che il fiume Gandak - che i greci chiamavano xxxxx, ma che gli indù fanno derivare da gaṇḍaka, “rinoceronte” - sia conosciuto nell’induismo soprattutto perché in esso si trova un particolare tipo di pietra forata, la śālagrāma, che è sacro a viṣṇu. Queste pietre sono generalmente nere e contengono ammoniti fossili. (vedi FOTO 12) Contengono aperture o fori che si suppone siano stati fatti da un insetto chiamato vajrakīṭa. Sono chiamati chidra, “forati” (ad es, nel garuḍa e nel padma Purāṇa: Kirfel 1935, 168), come le svayamātṛṇṇā. Il nome di queste pietre deriva da un villaggio (grāma) che prende il nome dall’albero di śāla (Vatica robusta: Kirfel 1935, 165); oppure da una striscia di terra montuosa sul fiume Gandak, chiamata śālagrāmakṣetra (Venkatachalam 1958, 108; cfr. anche Bhardwaj 1973, 51). Il principale affluente del fiume Gandak, il Kali Gandak, nasce vicino al confine con il Tibet e scorre verso sud tra i massicci montuosi del Dhaulagiri e dell’Annapurna. Poco più a est del fiume, nel Nepal settentrionale, si trova Muktinath, un centro di pellegrinaggio indù che è anche associato al culto del śālagrāma. A valle, nel Nepal meridionale, diversi punti del fiume sono legati al culto di viṣṇu come nārāyaṇa. Un tratto del fiume Gandak stesso è chiamato nārāyaṇī.
Il culto del ṣālagrāma è relativamente antico. È menzionato nel vedānta sūtra bhāṣya di śaṅkara (VIII secolo d.C.) e in diversi purāṇa (Kane 1941, II, 716). Nel garuḍa purāṇa (con porzioni corrispondenti in altri purāṇa), il culto di śālagrāma è collegato all’adorazione delle divinità vāstu che svolgono un ruolo importante nella fondazione di un edificio. Il capitolo XLVI di questo purāṇa fornisce una descrizione dettagliata di un edificio con 81 stanze, disposte in un diagramma di nove per nove stanze. Le diverse divinità sono collocate in quadrati o stanze differenti e in un ordine particolare. Sebbene molto diversa nei dettagli, l’intera costruzione non è dissimile da quella dell’altare dell’agnicayana. In questo mistico diagramma o yantra sono collocate varie forme di śālagrāma.
Venkatachalam (1958, 120) ha richiamato l’attenzione su alcuni riferimenti al culto del śālagrāma che potrebbero essere precedenti, ma che non sono riuscito a rintracciare. Secondo il vīramitrodaya, un testo più tardo, il śālagrāma è menzionato nell’āpastamba dharma sūtra, che Kane ha datato tra il 600 e il 300 a.C.

La pietra śālagrāma è sacra a viṣṇu. In genere presenta dei fori e contiene ammoniti fossili. In origine, queste pietre si trovavano nel fiume gandak, l’antica sadānīrā, che costituiva una barriera all’espansione verso est degli indiani vedici nelle pianure settentrionali del Gange. Il fiume nasce nel Nepal settentrionale e si unisce al Gange a Patna, l’antica pāṭaliputra. Esistono molti tipi di śālagrāma che si distinguono per i loro nomi, spesso nomi di viṣṇu o di attributi vaiṣṇava, ad esempio sanātanagopāla, sudarśana, ecc. La pietra in alto proviene dalla collezione di Ajit Mookerjee, Nuova Delhi. In basso, al centro, un sudarśana che è un calco dell’area ombelicale di un’ammonite. La pietra a destra mostra parti dell’ammonite stessa e un grande foro a sinistra. Se la pietra a sinistra contenga un’ammonite o sia artificiale può essere accertato solo rompendola. In realtà, i fori possono essere prodotti nei fossili per varie cause. Nei fossili di ammoniti o di altri animali, i buchi possono essere provocati da gusci simili a quelli delle lumache, ad esempio quando il fango non è entrato completamente nel guscio ma ha lasciato spazi aperti che sono venuti in superficie in un secondo momento, quando il fossile è stato esposto al vento o all’acqua. Tutte queste ammoniti appartengono probabilmente alla grande famiglia delle Perisphinctaceae, diffusa in tutto il mondo. Provengono dalla formazione del Giurassico, che si trova sull’Himalaya ma non nelle pianure indiane.
Foto John Webb Michael Beaucage
Venkatachalam cita anche un riferimento, in un āśvalāyana gṛhya sūtra pariśiṣṭa, a svākṛti, “avente forma propria”, che è stato spiegato come denota oggetti come il liṅga di śiva e il śālagrāma di viṣṇu. Il termine svākṛti esprime che questi oggetti non sono manufatti creati dall’uomo, ma hanno origine spontanea nella natura, proprio come i ciottoli svayamātṛṇṇā. Ancora oggi, le sacre perline rudrākṣa (semi di Elaeocarpus ganitrus) che si trovano naturalmente forate per l’inserimento di un filo sono preferite a quelle che devono essere forate artificialmente (Ghurye 1964, 92).
Il culto delle pietre forate in India non si limita al śālagrāma. Secondo Crooke, che descrive le credenze correlate nella religione popolare e nel folklore dell’India settentrionale, “il rispetto per queste pietre forate si basa sul noto principio che guardare attraverso una pietra forata migliora la vista” (Crooke 1896, II, 165). Crooke fa dei paralleli con altre culture e mette in relazione le pietre forate con i grani, “la cui efficacia è alla base dell’uso dei rosari” (II, 19). Tra le loro virtù c’è quella di dare figli, che ricorda le credenze degli indigeni del nord di Hupeh, citate nel catalogo delle pietre di Tu Wan. Il motivo di questo potere soprannaturale è che le pietre śālagrāma sono esse stesse figli. I purāṇa raccontano che la dea del fiume gaṇḍakī si impegnò in esercizi ascetici per molti anni e fu ricompensata da viṣṇu che nacque come suo figlio sotto forma di pietre śālagrāma (cfr. Kirfel 1935, 165; Ruben 1939, 232). Nel Tantrismo, infine, pietre simili sono venerate come rappresentazioni della vulva della dea.
Se è vero che il culto del śālagrāma dell’induismo è legato ai ciottoli svayamātṛṇṇā dell’agnicayana, i collegamenti con viṣṇu e nārāyaṇa non sono sorprendenti, poiché abbiamo visto che il puruṣa del puruṣasūkta, che è anche il puruṣa dell’agnicayana, si è gradualmente fuso con viṣṇu e nārāyaṇa nella letteratura vedica successiva (sopra, pagina 179). Ciò è ulteriormente confermato da un’usanza vaiṣṇava che continua fino ai giorni nostri: gli adoratori di viṣṇu sorseggiano l’acqua in cui è stato lavato un śālagrāma durante la recita del puruṣasūkta (Gonda 1970, 205, nota 36).
Questi dati sparsi dimostrano che il culto delle pietre forate, che i nomadi vedici introdussero nel rituale agnicayana, ha un’ampia diffusione nell’Induismo. Non è impossibile che tale culto esistesse in India già da molto prima, poiché sono state trovate pietre forate nei siti dell’Indo, ma è anche possibile che abbia avuto origine quando gli indiani vedici trovarono nel fiume Gandak pietre forate simili a quelle che i loro antenati avevano conosciuto in Asia centrale.4
-
Per questa sezione mi sono avvalso di Geldner (1957) 3-34; Gonda (1959) 79-96, (1960) 67-73; Hillebrandt (1927) I. 71-193; Keith (1925) 154-162; Renou e Filliozat (1947) I. 325-326. ↩
-
Per questa sezione mi sono avvalso di Eiseley (1954); Fewkes (1920); Forbes (1958); Frazer (1958); Gilbert (1947); Harrison (1954); Heizer (1963); Hough (1926, 1928); Lippert (1931); MacLeod (1925); Oakley (1955, 1956, 1958, 1961); Peake (1933); Sauer (1961); e Wilbert (1967). ↩
-
nota del traduttore : è stata ripresa la traduzione di Saverio Sani, ṛgveda, le strofe della sapienza, Marsilio 2000 ↩
-
Una conferma inaspettata dell’ipotesi esposta in questa sezione mi è stata fornita da Ajit Mookerjee, che mi ha riferito che le pietre śālagrāma sono invariabilmente collocate nelle fondamenta dei templi del Bengala (che è l’area che gli indiani vedici raggiunsero dopo aver attraversato i fiumi Gandak e Gange). Un numero particolarmente elevato di queste pietre si trova nelle fondamenta del tempio in terracotta dedicato a haṃseśvarī, la Dea Oca, veicolo di brahma, a bāṃsabeḍi, un sobborgo di Bandel (Chinsura Dis trict), a nord di Calcutta. Per un’ulteriore discussione, si veda Staal 1982, 42-53. ↩